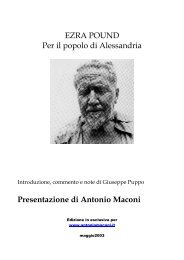Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Giuliano, dopo aver subito l’influsso del neoidealismo e del pragmatismo, fu protagonista<br />
di un’intransigente opposizione all’hegelismo, opposizione che sviluppò nelle sue opere di<br />
più alto spessore teoretico (“Il torto di Hegel” e “Immanenza e trascendenza nel sistema di<br />
Hegel”, “Il valore pratico <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong>”, oltre che nelle due edizioni de “Il valore<br />
degl’ideali”).<br />
In conformità al catechismo cattolico, che afferma la presenza di Dio “in cielo, in terra e<br />
in ogni luogo”, e alla dottrina agostiniana, secondo cui Dio è più intimo all’uomo dell’uomo<br />
stesso, Giuliano mostrava l’insufficienza del pensiero idealistico dinanzi al mistero <strong>della</strong><br />
storia e però affermava la necessità di riconoscere il limite dell’uomo: “Proprio in questa<br />
<strong>filosofia</strong> che si chiama idealismo manca un positivo concreto ideale che giustifichi le<br />
multiformi finalità per cui uomini e popoli soffrono, e giustifichi anche l’accettazione di<br />
questa sofferenza. Senza una forma ideale che superi la storia non si giustifica veramente la<br />
storia ... coll’idealismo ci si spiega il valore di ogni sua realizzazione, ma si viene a perdere<br />
in quest’universale storicismo ogni sicuro criterio per un giudizio che distingua i valori dai<br />
disvalori. ... Noi abbiamo riconosciuto insomma che per capire qualche cosa nella realtà<br />
così del nostro spirito come del mondo circostante bisogna fare un atto di umiltà e<br />
concedere che c’è qualcosa che superà la nostra possibilità di capire; ed abbiamo<br />
riconosciuto che non si spiega il dramma <strong>della</strong> vita se non accettando il postulato che il<br />
compimento del dovere sia anche atto di devozione ad una autorità che sta sopra il dramma<br />
stesso” 19 .<br />
Ora Giuliano riconosceva la parte di verità conservata (malgrado tutto)<br />
dall’immanentismo hegeliano, senza peraltro fare concessioni alla riduzione (hegeliana e<br />
gentiliana) dell’Assoluto al pensiero. Giuliano affermava, coerentemente, che l’Assoluto è<br />
immanente al reale e, al tempo stesso, trascendente. In tal modo la tradizione neoidealistica,<br />
che aveva dominato la scena <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong> italiana durante la prima metà del Novecento,<br />
era avviata ad un felice esito.<br />
Alla luce delle conclusioni di Giuliano, è lecito convenire con Gianni Baget Bozzo,<br />
secondo il quale nell’ultimo Gentile, quello <strong>della</strong> conferenza del 1942 sulla religione e<br />
quello <strong>della</strong> commemorazione vichiana del 1944, il Gentile che dichiara “Voglio sperare<br />
che tra i miei ascoltatori nessuno voglia accusarmi che la mia religione umanizzi Dio, o<br />
divinizzi l’uomo e finisca col ridurre ad uno i due termini essenziali del rapporto” 20 ,<br />
considera l’ispirazione di un mistico cristiano, piuttosto che il freddo rigore di un filosofo di<br />
scuola laica e razionalistica.<br />
Il fatto è che Gentile ha esplorato il vuoto propriamente pneumatico (neognostico)<br />
dell’ateismo moderno, aprendo la nuova via di ricerca – la via al postmoderno - che il card.<br />
Siri e Sciacca percorreranno a partire dagli anni Cinquanta.<br />
Gli argomenti <strong>della</strong> negazione antimoderna - quella pars destruens <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong> dopo la<br />
catastrofe, che il depistaggio tradizionalistico inutilmente di dedurre dalle pagine imbrattate<br />
fu ministro dell’Educazione popolare. Aveva aderito al movimento fascista, conservando la piena indipendenza<br />
di pensiero, come attestano gli accenti anticonformistici dei suoi saggi politici, “Elementi di cultura fascista” del<br />
1933 e <strong>“La</strong>tinità e germanesimo” del 1941. Nella cattedra universitaria si distinse per l’eccellente traduzione e<br />
per il dotto commento alle Lettere a Lucilio di Seneca. Nel dopoguerra partecipò all’attività del centro di<br />
Gallarate, pubblicando un importante saggio (“Il dramma delle moderne idolatrie”) sulla crisi del pensiero<br />
moderno. Giovanni Gentile, pur criticando le sue opere, gli ricnobbe “buona cultura e vivace spirito filosofico”,<br />
cfr.: “Frammenti di storia <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong>”, Le Lettere, Firenze 1999, pag. 597.<br />
19 “Il valore degl’ideali”, op. cit., pag. X-XI.<br />
20 Cfr. <strong>“La</strong> religione”, Sansoni, Firenze 1967, pag. 422.<br />
95