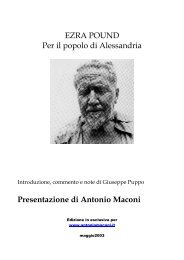Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
eccessi in cui il disprezzo dell’antica religione e quello dell’autorità <strong>della</strong> Chiesa<br />
sono stati capaci di spingere gli uomini” 14 .<br />
Nel 1767, Nicolas-Silvestre Bergier pubblica un saggio (<strong>“La</strong> certitude des preuves<br />
du Christianisme”) in cui denuncia il disordine morale alla radice dell’incredulità dei<br />
sedicenti spiriti forti: “Troppo onore si fa ad essi col supporre che solo allora<br />
abbiano cominciato a vacillar nella fede, quando ne hanno esaminati con diligenza i<br />
fondamenti. Se pur alcuni hanno fatto tale esame, essi avevano già preso la loro<br />
decisione: cercavano non tanto ragioni per credere quanto pretesti per confermarsi<br />
nella miscredenza; le passioni, la superbia, l’amore dell’indipendenza sono sempre<br />
state e saranno sempre le vere cagioni dell’incredulità” 15 .<br />
Nella chiara visione di Leone XIII, i guasti prodotti dalla furente sovversione in<br />
atto nella seconda metà dell’Ottocento, erano considerati realisticamente quali<br />
conseguenza del disordine, che si era manifestato (pacificamente fino al 1789) nel<br />
XVIII secolo: <strong>“La</strong> pervicacia degli ingegni intolleranti di ogni legittima soggezione,<br />
il perenne fomento alle discordie, da cui le intestine contese, e le guerre crudeli e<br />
sanguinosissime, il disprezzo di ogni legge di moralità e di giustizia, l’insaziabile<br />
cupidigia dei beni caduchi e la noncuranza degli eterni, spinta fino al pazzo furore<br />
che mena così spesso tanti infelici a darsi la morte, la improvvida amministrazione,<br />
lo sperpero, la malversazione delle comuni sostanze, come pure la impudenza di<br />
coloro che con perfido inganno vogliono essere creduti difensori <strong>della</strong> patria, <strong>della</strong><br />
libertà e di ogni diritto, quel letale malessere infine che serpeggia per le più riposte<br />
fibre <strong>della</strong> umana società, la rende inquiete, e minaccia travolgerla in una<br />
spaventosa catastrofe” 16 .<br />
Purtroppo il partito dell’ateismo moderno, rovesciandosi nella immoralità<br />
postmoderna, ha conservato intatta la sua severa intolleranza nei confronti dei<br />
cattolici. Niente è cambiato dal tempo in cui, imperversando il mito <strong>della</strong> scienza<br />
14 Citato da Marcel De Corte, cfr. “Evoluzione e fondamento <strong>della</strong> nozione d’autorità”, in Aa. Vv.,<br />
“Autorità e libertà”, atti del I Incontro romano <strong>della</strong> cultura, Giovanni Volpe editore, Roma 1974,pag.<br />
34. Analoga la tesi di Vico, esposta nella lettera all’abate Degli Esperti su Gassendi, che suggerirà a<br />
Sciacca l’indicazione del Seicento come età in cui ha inizio il cammino <strong>della</strong> decadenza: “il riso facile,<br />
l’immaginazione sbizzarrita, la sensualità, la dissipazione del tempo, e su tutto la morte ... il Barocco<br />
è decadenza”. “L’oscuramento dell’intelligenza”, Marzorati, Milano 1971, pag. 110. Nel testo<br />
sciacchiano si trova anche un preciso riferimento alla riforma luterana che, “nonostante il suo iniziale<br />
ed equivoco slancio religioso, provoca lo sbilancio in favore degli interessi terreni”.<br />
15 Citato da Alfonso Prandi, “Cristianesimo offeso e difeso. Deismo e apologetica cristiana nel secondo<br />
Settecento”, Il Mulino, Bologna 1975, pag. 170-171. Risalendo al malinteso originario <strong>della</strong> crisi<br />
moderna, Fabro afferma che il lontano precedente dell’ateismo è rappresentato dal “cogito” cartesiano,<br />
che va inteso alla stregua di un vuoto atto di volizione. Al riguardo cfr.: “L’avventura <strong>della</strong> teologia<br />
progressista”, Rusconi, Milano 1974, pag. 177, “Quando Cartesio pronuncia il suo cogito ergo sum,<br />
quel cogito è anzitutto e soprattutto un volo, in quanto il cogito vuole essere un atto ponente,<br />
originario. Infatti un cogito che intende contrapporsi al dubbio radicale e vincerlo, vale a dire il cogito<br />
che pretende salvarsi grazie proprio alla messa fra parentesi universale del contenuto, il cogito che<br />
esclude ogni riferimento di oggetto e di oggettività e afferma la priorità dell’atto sul contenuto ovvero<br />
il cogito attivo non può essere che volontà<br />
16 “Inscrutabili Dei consilio”, 21 aprile 1878.<br />
9