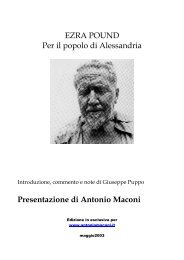Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Non si legge senza emozione la pagina gentiliana, che evoca quella nobile cortesia<br />
italiana, che, nel 1944, un pugno di sicari ha affondato nel sangue: “Francesco Acri è uno<br />
dei pochissimi filosofi che abbia avuto l’Italia dopo il Rosmini e il Gioberti; dico dei<br />
pochissimi pei quali la <strong>filosofia</strong> non sia stata semplice materia di libri e d’insegnamento,<br />
ma la stessa vita dello spirito, come suol essere per ogni uomo tutto ciò che per lui ha un<br />
valore assoluto. Il malinconico mistico scetticismo, in cui si fermò la mente dell’Acri, se gli<br />
rese disamabile, come laboriosa vanità, l’assidua indagine del pensiero speculativo e la<br />
metodica disciplina degli studi storici, per modo che la produzione letteraria e scientifica<br />
dello scrittore non è di certo proporzionata al suo ingegno e alla sua dottrina, e i lavori<br />
critici e indagativi di lui han più aspetto di acute e argute prove di uno spirito che sa vedere<br />
a fondo dove guardi; ha portato peraltro a piena maturità le doti intrinseche dello scrittore<br />
in molteplici saggi, che, se non concorrono al progresso di quella scienza, in cui l’Acri,<br />
propriamente non ha mai creduto, raccolgono alcune delle più profonde voci mistiche che<br />
risuonino nella letteratura italiana. Piccoli scritti, pagine episodiche, frammenti, in cui con<br />
forma, che par derivata dal più ingenuo Trecento ed è schiettamente e vigorosamente<br />
moderna nella meditata concentrazione e personale nella vivezza del sentimento che la<br />
riscalda, è espressa l’antica ed eterna storia dell’animo, che, alla presenza del suo Dio,<br />
trema, si smarrisce e rimane quasi schiacciata dalla sua grande visione” 4 .<br />
Francesco Acri, infatti, intervenne da acuto protagonista nel dibattito intorno al<br />
rinnovamento <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong> cattolica dell’Ottocento, rielaborando ed innestando<br />
sull’estenuato ontologismo dei platonizzanti italiani (<strong>Antonio</strong> Rosmini e Vincenzo Gioberti,<br />
ma anche Vincenzo Cuoco e Vito Fornari erano inscritti nel suo orizzonte), le novità<br />
(fortemente critiche nei confronti dell’idealismo), che erano proposte da due illustri<br />
esponenti <strong>della</strong> destra hegeliana di Germania (Trendelenburg e Michelet), dei quali aveva<br />
ascoltato le lezioni durante il biennio del suo soggiorno a Berlino.<br />
Non si può nascondere che, quasi mai, lo svolgimento del pensiero acriano fu aderente<br />
alla linea tracciata dai restauratori ortodossi <strong>della</strong> metafisica tomistica e approvata e<br />
raccomandata da Leone XIII; nei suoi scritti l’inclinazione verso l’innatismo platonico (e<br />
rosminiano e giobertiano) è fin troppo evidente 5 .<br />
Tuttavia il suo originale apporto alla critica dei grandi sistemi dell’immanenza, che<br />
dominavano la scena del tardo Ottocento e del primo Novecento, appartiene, a pieno titolo,<br />
al patrimonio <strong>della</strong> cultura cattolica 6 .<br />
4 Cfr.: “Frammenti di storia <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong>”, Le Lettere, Firenze 1999, pag. 175. Il testo fu pubblicato nel “Resto<br />
del Carlino”, il 22 maggio 1913, insieme con le testimonianze di Agostino Gemelli, Benedetto Croce.<br />
Fortemente critico è, invece, il giudizio di Eugenio Garin, secondo il quale Acri “non giunse mai ad una<br />
organizzazione del suo pensiero ... i suoi ragionamenti non sono che la traduzione in termini logici di<br />
atteggiamenti sentimentali” Cfr.: “Storia <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong> italiana”, Einaudi, Torino 1966, III vol., pag. 1212.<br />
5 In un dialogo immaginario, che fa parte del volume “Videmus in aenigmate”, pubblicato dall’editore Cappelli<br />
(Bologna 1907) e riproposto da Giuseppe Faggin nella Grande antologia filosofica, Acri dichiarò apertamente la<br />
sua adesione alle tesi di Rosmini, pur proponendo alcune varianti tecniche sul tema <strong>della</strong> visione dell’Essere.<br />
6 Al riguardo del rapporto tra neoidealismo e spiritualismo, scriveva Balbino Giuliano: “Nei primi anni del<br />
Novecento, quando io cominciavo a propormi i problemi filosofici, volgeva al tramonto col positivismo<br />
quell’ingenuo astrattismo materialista, che negli ultimi decenni del secolo scorso aveva finito per dominare la<br />
nostra cultura, e sorgeva un nuovo movimento spiritualista, di cui forse non abbiamo ancora veduta tutta<br />
l’importanza. Era un movimento più ampio dell’idealismo crociano e gentiliano, e basta per rendersene conto<br />
ricordare il caro nome di Bernardinio Varisco, ascetica figura di pensatore e di maestro, ma bisogna convenire<br />
che quel movimento ha avuto la sua espressione più viva e feconda nella scuola idealista di cui erano maestri<br />
allora concordi il Croce ed il Gentile. Non solo la <strong>filosofia</strong> ma tutta la cultura italiana ha sentito l’influenza di<br />
questa nuova concezione che aveva il grande merito di affermare la spirituale essenza del soggetto umano<br />
91