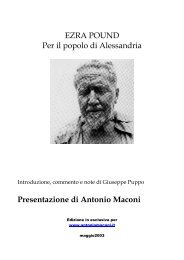Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dalle lezioni di Trendelenburg, Acri aveva ricavato la chiave di un’animosa e originale<br />
lettura post-hegeliana di Aristotele. Di qui l’audace tentativo di correggere (e adattare alla<br />
metafisica aristotelico-tomista) l’eredità platonica conservata, nonostante tutto,<br />
dall’idealismo hegeliano. Di là dei risultati, in questa intenzione si deve apprezzare la<br />
disposizione eminentemente cattolica e tomistica ad apprezzare e raccogliere i frutti <strong>della</strong><br />
ricerca condotta dai non cattolici.<br />
In vista di questa ambiziosa strategia, che, nelle contraddizioni hegeliane, contemplava<br />
l’occasione per rivitalizzare il platonismo, Acri approfondì, interpretandolo a suo modo,<br />
l’assioma (d’impronta platonica), che è esposto nel III libro del “De anima” di Aristotele:<br />
“Del principio dello scibile non c’è scienza, non arte, né prudenza cioè scienza pratica e<br />
rimane che ci sia sola intelligenza”.<br />
Acri utilizzò questa definizione aristotelica per elaborare un’audace teoria dell’intelletto<br />
agente, teoria che si discosta da quella tradizionale <strong>della</strong> scolastica: “L’intelletto attivo sé<br />
intuisce, e in sé i primi princìpi intuisce <strong>della</strong> scienza speculativa e pratica, perocché essi<br />
non sono obbietto di ragionamento; e li contiene nella virtù sua, cioè nella relazione di Sé<br />
con sé stesso” 7 .<br />
Lungo questo accidentato cammino, l’incontro con le oscurità e le aporie di Rosmini era<br />
però inevitabile. Acri ha celebrato la (precaria) convergenza di Rosmini con l’ortodossia<br />
scolastica, forzando il significato di una tesi, che san Tommaso aveva formulato in gioventù<br />
e rettificato in età matura: “Come dice Avicenna nel II <strong>della</strong> Metafisica, così egli [san<br />
Tommaso] dice «Quello che l’intelletto concepisce quasi notissimo e in cui tutte le<br />
conoscenze risolve, quello è l’Ente» (De Veritate nel corpo dell’art. 1). E tutte le altre<br />
concezioni si ricevono per addizioni all’Ente. Ma all’Ente non può aggiungersi (mentre<br />
scrivo questo mi viene in mente Rosmini) non può aggiungersi alcun che quasi estranea<br />
natura, in quel modo che si aggiunge la differenza al genere o l’accidente al subbietto” 8 .<br />
La conclusione necessaria è che “l’intelletto agente ha in sé l’idea dell’Ente con i modi suoi<br />
universali, altresì ha in sé i principii che divengono da essa idea, cioè quelli di<br />
contraddizione e di causalità” 9 .<br />
E poco più avanti, quasi con l’intenzione di confermare la sua piena adesione alle tesi di<br />
Rosmini, Acri precisa che “l’idea di Ente comune, prima che illumini i fantasmi, illumina<br />
l’intelletto, e per esso l’anima, dove tutti i fantasmi sono come quelli di uno” 10 .<br />
Ora è evidente che la sequela delle tracce rosminiane conduce ad un punto morto, dove,<br />
nel migliore dei casi, si può ottenere il risultato esibito da Michele Federico Sciacca, cioè la<br />
revisione (la moderazione) delle tesi estreme di Rosmini, e il riconoscimento (fermo<br />
restando l’irreversibile giudizio sulla gratuità filosofica delle tesi innatistiche), che è lecita<br />
l’accettazione <strong>della</strong> <strong>filosofia</strong> prodotta da questa operazione di setaccio 11 . Sciacca, infatti, fu<br />
ridonandogli il pieno senso del valore <strong>della</strong> sua attività creatrice libera dagl’impedimenti delle astrazioni<br />
materialiste”. Cfr. “Il valore degl’ideali”, Zanichelli, Bologna 1946, pag. VII-VIII.<br />
7<br />
“Della cognizione secondo san Tommaso e Aristotele”, op. cit., pag. 21.<br />
8<br />
Id., id. Pag. 33.<br />
9<br />
Id., id. Pag. 35.<br />
10<br />
Id., id., pag. 36.<br />
11<br />
La formula faticosamente elaborata da Sciacca per chiarire l’ortodossia del pensiero rosminiano afferma che<br />
“l’essere è presente alla nostra mente, è oggetto di essa e per ciò l’essere ideale è immanente nell’uomo, non<br />
come pura funzione <strong>della</strong> mente, bensì come oggetto inuito; immanenza che è presenza e dunque trascendenza”.<br />
Cfr. “Interpretazioni rosminiane”, Marzorati, Milano 1963, pag. 79.<br />
92