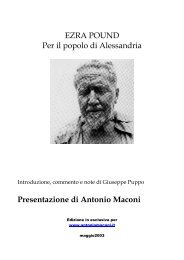Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
Piero Vassallo “La restaurazione della filosofia ... - Maconi, Antonio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Introduzione<br />
Un sordo accanimento terapeutico, nasconde la morte cerebrale dell’illuminismo e<br />
ne prolunga artificialmente l’autorità, rianimando illusioni filosofiche e pregiudizi<br />
storiografici senza più fondamento.<br />
L’indispensabile e temuta revisione <strong>della</strong> storia moderna, pertanto, inizierà solo<br />
dalla considerazione, senza pregiudizi, di quell’ingente e cruciale produzione <strong>della</strong><br />
scolastica del XIX e XX secoli, che il potere culturale, applicando con sistematica<br />
protervia le tecniche <strong>della</strong> disinformazione e <strong>della</strong> censura vandalica, ha occultato<br />
dietro la cortina <strong>della</strong> menzogna e <strong>della</strong> stupidità.<br />
Versato sapientemente dai naufraghi <strong>della</strong> modernità, il bianchetto <strong>della</strong> malafede<br />
nasconde due secoli di ricerche filosofiche propriamente eroiche e, di conseguenza,<br />
impedisce la chiara visione del rapporto tra i delitti dei rivoluzionari e l’odio contro<br />
la verità 1 .<br />
Così il fiume degli storici inganni scende imperterrito e solenne, come se non<br />
fosse, infine, evidente che la distruzione <strong>della</strong> metafisica da parte degli illuministi e<br />
dei loro continuatori, era organizzata da un’antropologia dilettantesca e favolosa 2 ,<br />
oltre che da una contraddittoria e perfino ingenua ricostruzione delle attività mentali.<br />
Contraddizioni e ingenuità, peraltro, furono ripetutamente segnalate dai moderni<br />
difensori <strong>della</strong> metafisica, da Balbino Giuliano, ad esempio, che domandava: “Come<br />
avviene, ha diritto di domandare a Kant un confutatore più scettico o più dogmatico<br />
di lui, questa unione di una forma soggettiva <strong>della</strong> ragione pura colla materia<br />
obbiettiva, da cui la ragione del soggetto è scissa? E parimenti da chi riceve la<br />
nostra ragione pratica le credenziali, che le diano diritto d’imporsi alle naturali<br />
tendenze del nostro volere?” 3 . E da Carmelo Ottaviano, che ha documentato l’esito<br />
1<br />
Insigne monumento al barattolo del bianchetto, l’Enciclopedia Garzanti di Filosofia, diretta dal soave<br />
Gianni Vattimo con la illuminata collaborazione di Ugo Fabietti, sfodera una prodigiosa memoria nel<br />
ricorda, ad esempio, il lugubre e oscuro pornografo Pierre Klossowski, memoria che tuttavia svanisce<br />
nell’esclusione dall’elenco di autori illustri come Francesco Acri, Cornelio Fabro, Réginald Garrigou-<br />
Lagrange, Balbino Giuliano, Carmelo Ottaviano, Michele Federico Sciacca, Luigi Stefanini ecc..<br />
2<br />
Si pensi alle disinvolte dimostrazioni scientifiche di Paul-Henri d’Holbach e alle fantasticherie<br />
arcadiche di Jean-Jacques Rousseau.<br />
3<br />
Cfr. “Il valore degl’ideali”, Zanichelli, Bologna 1946, pag. 112. Più avanti Giuliano osservava che<br />
Immanuel Kant “restò a mezza via in una posizione intermedia, in sé stranamente contraddittoria fra<br />
un oggettivismo non del tutto risolto e un soggettivismo non del tutto conquistato, con un duplice<br />
atteggiamento dogmatico e scettico. Si può dire, infatti, che egli resta scettico in tutto lo svolgimento<br />
<strong>della</strong> sua concezione critica, fino al momento <strong>della</strong> conclusione, in cui, ritrovando nell’ombra del<br />
noumenon il principio delle fenomenia criticamente studiata ritrova la posizione dogmatica”. Op. cit.,<br />
pag. 157. Nella “critica <strong>della</strong> ragione pura”, Kant, convinto di pronunciare una sentenza inappellabile,<br />
sostiene che “il concetto <strong>della</strong> somma di 7 e 5 non racchiude che l’unione di due numeri in uno solo,<br />
senza che perciò venga assolutamente pensato quale sia questo numero unico che raccoglie gli altri<br />
due. Il concetto di dodici non è affatto pensato già pel fatto che io penso semplicemente quella unione<br />
di sette e cinque, e finché io analizzerò il mio concetto di una tale possibile somma non vi troverò<br />
5