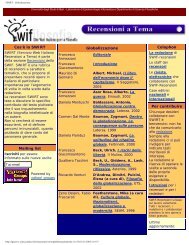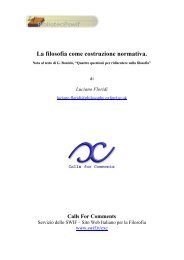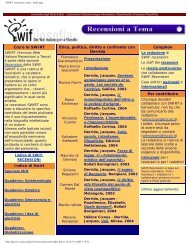Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Giovanni Boniolo© 2003 – <strong>Lo</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong>della</strong> <strong>gnoseologia</strong> <strong>moderna</strong><br />
all'oggetto non può mai esser dato il predicato <strong>della</strong> parvenza, appunto<br />
perché si verrebbe ad attribuire all'oggetto per sé, ciò che gli può convenire<br />
solo in rapporto ai sensi o in generale al soggetto, per es.: i due anelli<br />
attribuiti una volta a Saturno. Fenomeno è ciò che non appartiene all'oggetto<br />
in sé stesso, ma si trova sempre nel rapporto di esso col soggetto, ed è<br />
inseparabile dalla rappresentazione di questo; giustamente perciò i predicati<br />
dello spazio e del tempo sono attribuiti agli oggetti dei sensi come tali, e in<br />
ciò non v'è parvenza. Al contrario, se io attribuisco alla rosa in sé il color<br />
rosso, a Saturno gli anelli o a tutti gli oggetti in sé l'estensione, senza<br />
guardare a un determinato rapporto di questi oggetti col soggetto e senza<br />
limitare ad esso il mio giudizio, allora nasce la parvenza” (B 90, n.1). La<br />
critica trascendentale, che trova il suo apogeo nella Dialettica<br />
trascendentale, ha il compito di snidare e combattere proprio tale apparenza<br />
trascendentale (B 287-288). Invece l'apparenza logica “sorge unicamente da<br />
un difetto di attenzione alla regola logica” (B 287), mentre l'apparenza<br />
empirica “(per esempio [...] quella ottica [...] ha luogo nell'uso empirico di<br />
regole, del resto giuste, dell'intelletto, e per cui il giudizio è sviato<br />
dall'influsso dell'immaginazione” (B286).<br />
[ ]<br />
52 Qui si innesta la critica di Schopenhauer alla concezione kantiana.<br />
Schopenhauer, nell'Appendice al suo Il mondo come volontà e come<br />
rappresentazione (Schopenhauer, 1819, pp. 537-684) pur accettando la<br />
"rivoluzione copernicana'', non accetta la teoria kantiana <strong>della</strong><br />
modificazione perché vi ravvisa un uso del principio di causalità indebito e<br />
non trascendentale, come quello proposto dallo stesso Kant nella seconda<br />
analogia dell'esperienza. Infatti, quando si parla di un oggetto noumenico<br />
che modifica i sensi per dar luogo alla sensazione, si presuppone<br />
cripticamente che vi sia un nesso causale fra mondo delle cose in sé e<br />
mondo dei fenomeni. Ma in tal modo la posizione idealistica, che<br />
Schopenhauer credeva di ravvisare nella prima edizione (che preferiva),<br />
diventa solo una sorta di realismo di stampo empiristico che non accetta. In<br />
realtà, Kant parla <strong>della</strong> cosa in sé che affetta i sensi sia nella parte <strong>della</strong><br />
prima edizione poi espunta (per esempio, A 651, 655 e 658), sia nella parte<br />
CxC – Calls for Comments, SWIF www.swif.it/cxc 102