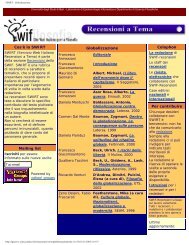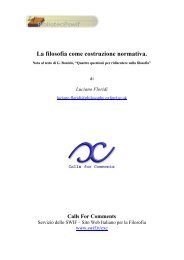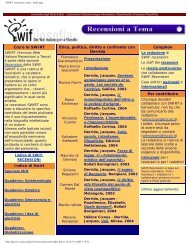Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Giovanni Boniolo© 2003 – <strong>Lo</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong>della</strong> <strong>gnoseologia</strong> <strong>moderna</strong><br />
“La prima era di non accettare mai per vera nessuna cosa che non riconoscessi tale con<br />
evidenza, cioè di evitare diligentemente la precipitazione e la prevenzione e di non<br />
comprendere nei miei giudizi nulla più di quanto si presentasse così chiaramente e<br />
distintamente al mio spirito, da non lasciarvi alcuna occasione di dubbio. La seconda era di<br />
suddividere ogni difficoltà che esaminavo nel maggior numero di parti possibili e<br />
necessarie per meglio risolverla. La terza di condurre per ordine i miei pensieri,<br />
cominciando dagli oggetti più semplici e più facili da conoscere, per salire a poco a poco,<br />
come per gradi, fino alla conoscenza dei più complessi, presupponendo un ordine anche tra<br />
gli oggetti che non si precedono naturalmente l'un l'altro. E l'ultima era di fare ovunque<br />
enumerazioni così complete e revisioni così generali da essere sicuro di non omettere nulla”<br />
(Cartesio, 1637, pp. 144-5).<br />
Il Discours de la Méthode nasce come testo introduttivo a tre trattati scientifici (La<br />
Dioptrique, Les Methéores, La Géometrie). Già questo dato esprime chiaramente la<br />
stretta, indissolubile connessione tra processo scientifico e innovazione metodologica.<br />
D'altra parte questa attenzione aveva ispirato anche un testo composto da Cartesio circa<br />
dieci anni prima: le Regulae ad directionem ingenii. Le ventuno regulae sono diventate<br />
solo quattro nel testo del Discours, ma in questa contrazione non hanno perso di<br />
precisione: anzi, per alcuni aspetti ne hanno guadagnata.<br />
Un'analisi <strong>della</strong> prima regola del metodo mostra una struttura rovesciata,<br />
logicamente, rispetto all'enunciazione. La verità si appoggia alll'evidenza, che viene<br />
descritta come assenza di prevenzione e precipitazione, ma soprattutto come chiarezza e<br />
distinzione che, a loro volta, derivano dalla mancanza di dubbio. Dal punto di vista<br />
logico è quindi il dubbio a garantire la chiarezza e la distinzione, cioè l'evidenza, e<br />
quindi la verità.<br />
E' visibile in modo nettissimo la curvatura soggettivistica di questa regola, che<br />
appoggia alla mancanza di dubbio per il “mio spirito” le condizioni di possibilità <strong>della</strong><br />
verità. E che il soggetto del dubitare sia l'io è pronominalmente chiaro. Ciò tuttavia è<br />
possibile perché in tale spirito, per Cartesio, risiede la capacità di cogliere “la<br />
conoscenza delle cose senza alcun pericolo di inganno”, risiede cioè quel lume naturale<br />
che ben condotto permette di cogliere la verità. [7] E' quindi la presupposta esistenza di<br />
tale capacità a consentire di fare del dubbio posto e risolto il criterio che il soggetto<br />
segue nel saggiare la chiarezza e l'evidenza, quindi la verità delle sue conoscenze.[n7]<br />
Dopo aver invitato, nella prima regola del metodo, a guardarsi dalla “prevenzione e<br />
precipitazione” tale "fiducia" nel coglimento <strong>della</strong> verità lascia perplessi. Ma Cartesio<br />
ha due ragioni per sostenerla: si chiamano aritmetica e geometria.<br />
CxC – Calls for Comments, SWIF www.swif.it/cxc 9