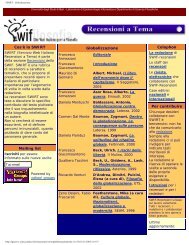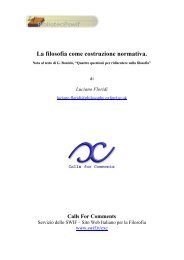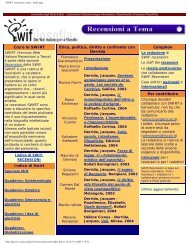Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Giovanni Boniolo© 2003 – <strong>Lo</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong>della</strong> <strong>gnoseologia</strong> <strong>moderna</strong><br />
Finora aveva considerato il giudizio come semplice compositio fra due concetti.<br />
Adesso si pone il problema di che cosa sia questa compositio e punta l'attenzione sulla<br />
copula per sottolineare che è proprio per essa che si distingue l'unità necessaria dalla<br />
connessione contingente.<br />
Ma è sempre sulla base di questa definizione del giudizio quale “maniera di ridurre<br />
date conoscenze alla unità oggettiva dell'appercezione” che nega lo status di giudizio a<br />
quelli che invece nei Prolegomeni e nella <strong>Lo</strong>gica aveva considerato giudizi di<br />
percezione. Questi, ora, sono considerati solo associazioni di stati di coscienza<br />
soggettivi. Quindi non è lecito chiamare giudizi né i giudizi percettivi del primo tipo<br />
("Mi piace il caldo"), né i giudizi percettivi del secondo tipo ("Quando il sole rischiara<br />
la pietra, sento che diventa calda"). Entrambi sono formulazioni di associazioni di stati<br />
di coscienza, anche se la seconda associazione può tramutarsi in giudizio empirico con<br />
l'ingresso di un concetto puro. Nella Critica, dunque, Kant non parla più di giudizi<br />
percettivi e di giudizi d'esperienza, bensì, rispettivamente, di associazioni di stati di<br />
coscienza e di giudizi empirici. [ 78 ]<br />
Andiamo avanti con la citazione di questo breve e fondamentale paragrafo:<br />
“Essa [la particella "è"] infatti designa la loro [delle rappresentazioni] relazione con<br />
l'appercezione originaria e la loro unità necessaria, anche quando il giudizio stesso sia<br />
empirico, e perciò accidentale, come ad es.: i corpi sono pesanti. Con ciò non voglio dire<br />
che queste rappresentazioni nell'intuizione empirica siano necessariamente subordinate<br />
l'una all'altra; ma che esse sono l'una all'altra subordinate mercè l'unità necessaria<br />
dell'appercezione nella sintesi delle intuizioni, e cioè secondo principi <strong>della</strong> determinazione<br />
oggettiva di tutte le rappresentazioni, in quanto possa risultareuna conoscenza [...]<br />
Solamente così da questo rapporto nasce un giudizio, ossia un rapporto valido<br />
oggettivamente, e che si distingue appunto dal rapporto delle rappresentazioni medesime in<br />
cui ci sia solamente un valore soggettivo, per es., secondo le leggi dell'associazione.<br />
Secondo queste, io potrei dire soltanto: "quando porto un corpo, un'impressione di peso";<br />
ma non: "esso, il corpo, è pesante"; che val quanto dire che le due rappresentazioni sono<br />
unite nell'oggetto, indipendentemente cioè dallo stato del soggetto, e non stanno insieme<br />
semplicemente nella percezione (per quanto essa possa essere ripetuta)” (B 139).<br />
Dunque, i giudizi empirici sono contingenti, ma connettono in modo universale e<br />
oggettivo le rappresentazioni. Vi è allora veramente la contraddizione a cui prima<br />
avevamo accennato? Ebbene, no. Qui Kant sottolinea che quando parla <strong>della</strong> loro “unità<br />
necessaria” non intende una necessità espressa dalla proposizione in sé, ma dal principio<br />
dell'intelletto puro che forma lo stampo in cui si inseriscono le rappresentazioni in modo<br />
di trasformare una mera associazione soggettiva in un'unione oggettiva.<br />
CxC – Calls for Comments, SWIF www.swif.it/cxc 75