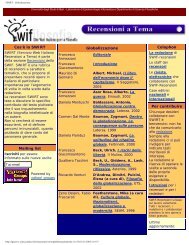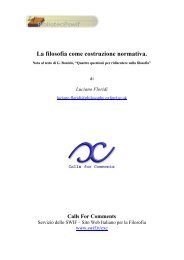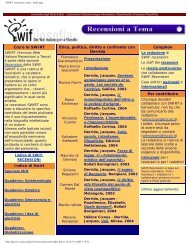Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Giovanni Boniolo© 2003 – <strong>Lo</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong>della</strong> <strong>gnoseologia</strong> <strong>moderna</strong><br />
l'attività di pensiero sono azioni proprie <strong>della</strong> riflessione che comportano una autonomia<br />
certo difficilmente illustrata dalla metafora dello specchio.<br />
Individuata così, in particolare nella sensazione, l'origine empirica del nostro sapere,<br />
<strong>Lo</strong>cke passa a una differenziazione fondamentale, quella tra idee semplici, direttamente<br />
congiunte alla sensazione e prodotto di questa, e idee complesse.<br />
Sulla base di questo approccio <strong>Lo</strong>cke inizia a definire le idee semplici, cioè idee che<br />
corrispondono a singole qualità di oggetti sensibili oppure a singoli fatti psichici del<br />
nostro operare riflessivo. Ma proprio qui nasce il problema.<br />
“Ma per meglio scoprire la natura delle nostre idee e parlarne in modo intelligibile, sarà<br />
opportuno distinguerle a seconda che siano delle percezioni o delle idee nel nostro spirito,<br />
oppure siano, nei corpi, delle modificazioni <strong>della</strong> materia, le quali producono tali percezioni<br />
in noi. Bisogna, dico, distinguere esattamente queste due cose, per evitare l'illusione (forse<br />
anche troppo consueta) che le nostre idee siano delle veraci immagini o somiglianze di<br />
qualcosa di inerente all'oggetto che le produce: poiché la maggior parte delle idee nate dalla<br />
sensazione, che si trovano nel nostro spirito, non somiglia a qualcosa che esista fuori di noi,<br />
più che non somiglino alle nostre idee i nomi che si usano per esprimerle, sebbene tali nomi<br />
non manchino mai di suscitarle in noi non appena li sentiamo menzionare” (Ivi, II, VII, 7,<br />
pp. 48-49).<br />
<strong>Lo</strong>cke aveva sorvolato sul problema <strong>della</strong> diversa natura delle nostre idee semplici,<br />
autoprodotte nel senso interno <strong>della</strong> riflessione, oppure eteroprodotte nel senso esterno<br />
<strong>della</strong> sensazione. Si trova ora in difficoltà nel giustificare le seconde, proprio per la<br />
evidente possibilità che esse ci ingannino circa la loro natura: il ruolo rispecchiante<br />
<strong>della</strong> conoscenza umana, che <strong>Lo</strong>cke dava per scontato nella costruzione delle idee<br />
semplici via sensazione, rimane ancora tutto da verificare, e la strada che il filosofo<br />
inglese sceglierà certamente è la soluzione intelligente di un problema affrontato in<br />
ritardo.<br />
Seguendo le indicazioni di R. Boyle (Boyle, 1666, pp. 318 e ss.), che a sua volta si<br />
rifaceva alla tradizione galileiana e cartesiana, <strong>Lo</strong>cke ritiene che si possa definire<br />
“qualità di un corpo” il suo potere di produrre una certa idea nello spirito. Ed ecco la sua<br />
soluzione:<br />
“Ciò posto bisogna distinguere nei corpi due specie di qualità. Anzitutto quelle che sono<br />
interamente inseparabili dal corpo, in qualunque stato esso sia. Riguardo a queste qualità<br />
possiamo osservare quelle primarie in corpi che producono in noi idee semplici, come la<br />
solidità, l' estensione, il moto, o il riposo, il numero e la figura” (Ivi, II, VIII, 9, p. 49). [ 26 ]<br />
CxC – Calls for Comments, SWIF www.swif.it/cxc 25