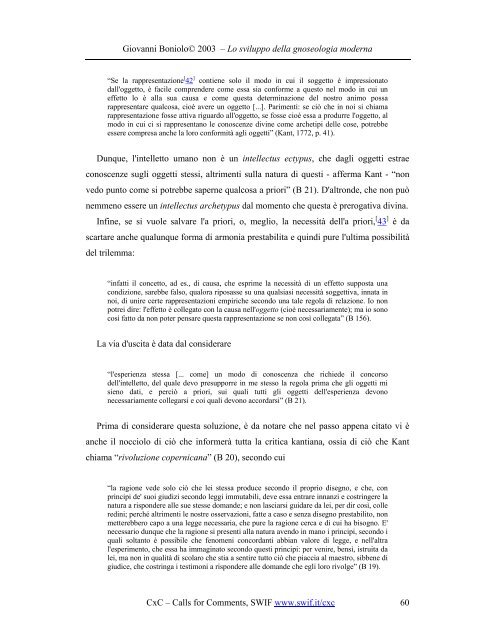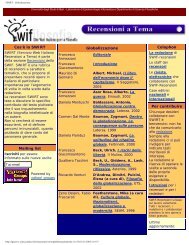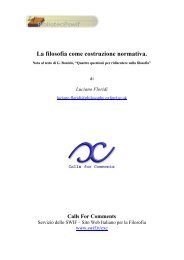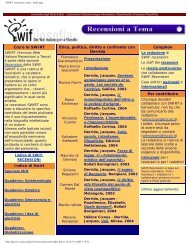Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Giovanni Boniolo© 2003 – <strong>Lo</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong>della</strong> <strong>gnoseologia</strong> <strong>moderna</strong><br />
“Se la rappresentazione [ 42 ] contiene solo il modo in cui il soggetto è impressionato<br />
dall'oggetto, è facile comprendere come essa sia conforme a questo nel modo in cui un<br />
effetto lo è alla sua causa e come questa determinazione del nostro animo possa<br />
rappresentare qualcosa, cioè avere un oggetto [...]. Parimenti: se ciò che in noi si chiama<br />
rappresentazione fosse attiva riguardo all'oggetto, se fosse cioè essa a produrre l'oggetto, al<br />
modo in cui ci si rappresentano le conoscenze divine come archetipi delle cose, potrebbe<br />
essere compresa anche la loro conformità agli oggetti” (Kant, 1772, p. 41).<br />
Dunque, l'intelletto umano non è un intellectus ectypus, che dagli oggetti estrae<br />
conoscenze sugli oggetti stessi, altrimenti sulla natura di questi - afferma Kant - “non<br />
vedo punto come si potrebbe saperne qualcosa a priori” (B 21). D'altronde, che non può<br />
nemmeno essere un intellectus archetypus dal momento che questa è prerogativa divina.<br />
Infine, se si vuole salvare l'a priori, o, meglio, la necessità dell'a priori, [ 43 ] è da<br />
scartare anche qualunque forma di armonia prestabilita e quindi pure l'ultima possibilità<br />
del trilemma:<br />
“infatti il concetto, ad es., di causa, che esprime la necessità di un effetto supposta una<br />
condizione, sarebbe falso, qualora riposasse su una qualsiasi necessità soggettiva, innata in<br />
noi, di unire certe rappresentazioni empiriche secondo una tale regola di relazione. Io non<br />
potrei dire: l'effetto è collegato con la causa nell'oggetto (cioè necessariamente); ma io sono<br />
così fatto da non poter pensare questa rappresentazione se non così collegata” (B 156).<br />
La via d'uscita è data dal considerare<br />
“l'esperienza stessa [... come] un modo di conoscenza che richiede il concorso<br />
dell'intelletto, del quale devo presupporre in me stesso la regola prima che gli oggetti mi<br />
sieno dati, e perciò a priori, sui quali tutti gli oggetti dell'esperienza devono<br />
necessariamente collegarsi e coi quali devono accordarsi” (B 21).<br />
Prima di considerare questa soluzione, è da notare che nel passo appena citato vi è<br />
anche il nocciolo di ciò che informerà tutta la critica kantiana, ossia di ciò che Kant<br />
chiama “rivoluzione copernicana” (B 20), secondo cui<br />
“la ragione vede solo ciò che lei stessa produce secondo il proprio disegno, e che, con<br />
principi de' suoi giudizi secondo leggi immutabili, deve essa entrare innanzi e costringere la<br />
natura a rispondere alle sue stesse domande; e non lasciarsi guidare da lei, per dir così, colle<br />
redini; perché altrimenti le nostre osservazioni, fatte a caso e senza disegno prestabilito, non<br />
metterebbero capo a una legge necessaria, che pure la ragione cerca e di cui ha bisogno. E'<br />
necessario dunque che la ragione si presenti alla natura avendo in mano i principi, secondo i<br />
quali soltanto è possibile che fenomeni concordanti abbian valore di legge, e nell'altra<br />
l'esperimento, che essa ha immaginato secondo questi principi: per venire, bensì, istruita da<br />
lei, ma non in qualità di scolaro che stia a sentire tutto ciò che piaccia al maestro, sibbene di<br />
giudice, che costringa i testimoni a rispondere alle domande che egli loro rivolge” (B 19).<br />
CxC – Calls for Comments, SWIF www.swif.it/cxc 60