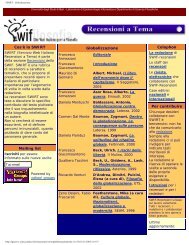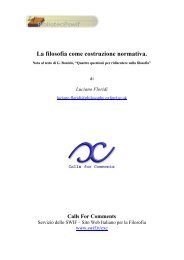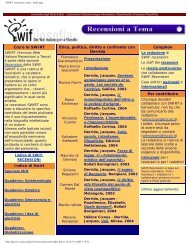Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
Lo sviluppo della gnoseologia moderna - Swif
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Giovanni Boniolo© 2003 – <strong>Lo</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong>della</strong> <strong>gnoseologia</strong> <strong>moderna</strong><br />
metafisica. Per i primi due si tratta solo di scoprire come sono possibili, per<br />
gli altri anche se effettivamente vi sono. E' questo il problema da cui Kant è<br />
angosciato e che così formula nella lettera del 21 febbraio 1772 a M. Herz:<br />
“[...] rilevai che mi mancava ancora qualcosa di essenziale. Durante le mie<br />
lunghe ricerche metafisiche, io (così come molti altri) non l'avevo preso in<br />
considerazione, ma esso costituisce in realtà la chiave di tutti i misteri <strong>della</strong><br />
metafisica, che finora è rimasta celata a se stessa. Mi chiesi cioè: su quale<br />
fondamento poggia la relazione di ciò che in noi si chiama rappresentazione<br />
con l'oggetto?” (Kant, 1772, p. 65). Ebbene, la risposta a questa domanda, e<br />
quindi “la chiave di tutti i misteri <strong>della</strong> metafisica”, si trova nella Deduzione<br />
trascendentale.<br />
[ ]<br />
98 Nella Prefazione all'edizione del 1781, Kant spiega: “L'una [quella<br />
oggettiva] riguarda gli oggetti dell'intelletto puro, e deve stabilire e spiegare<br />
la validità oggettiva de' suoi concetti a priori; e rientra appunto perciò<br />
essenzialmente nei miei fini. L'altra [quella soggettiva] passa a considerare<br />
lo stesso intelletto puro secondo la sua possibilità e i poteri conoscitivi su<br />
cui esso si fonda, per studiarlo quindi nel rapporto soggettivo” (A 10).<br />
Strawson fa notare (Strawson, 1966, p. 77) che tenendo presente questo<br />
duplice aspetto, la Deduzione trascendentale, da un lato, può essere vista<br />
come un'argomentazione “sulle implicazioni del concetto di esperienza in<br />
generale” - è l'aspetto oggettivo -, dall'altro lato, come “una descrizione<br />
delle attività trascendentali delle facoltà soggettive che producono<br />
esperienza” - è l'aspetto soggettivo -. Qui si collega anche il problema se la<br />
deduzione 1781 sia completamente altra da quella del 1787. Per esempio,<br />
Schopenhauer (Schopenhauer, 1819) e Heidegger (Heidegger, 1929)<br />
propendevano per questa tesi ed entrambi privilegiavano la prima versione,<br />
seppur per motivi diversi: Schopenhauer perché la riteneva più idealistica e<br />
Heidegger perché in essa il tempo aveva un ruolo primario. In effetti, nella<br />
versione del 1781 vi è una maggior enfatizzazione <strong>della</strong> dottrina delle tre<br />
sintesi delle fonti soggettive del conoscere, ma a ben guardare questa è tratta<br />
anche nell'edizione del 1787, seppur in modo diverso. Secondo tale dottrina,<br />
“Se io dunque attribuisco al senso, per il fatto che esso conviene nella sua<br />
CxC – Calls for Comments, SWIF www.swif.it/cxc 124