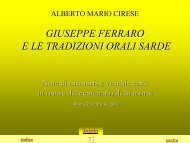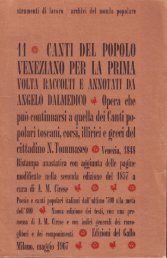Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I PROVERBI DI PREFERENZA 163<br />
In effetti il parlante si pone come "relatante", come "citans", per mezzo di una<br />
operazione - linguisticamente manifesta, o in ogni caso pertinente ai fatti linguistici -<br />
che consiste:<br />
a) nell'affermare che una terza persona (un altro parlante qualsiasi, un quidam) ha<br />
compiuto l'operazione (linguistica) di pronunciare una <strong>parola</strong>, una frase, un discorso,<br />
una sentenza ecc.<br />
b) nel ripetere testualmente (oppure nel presentare come testualmente ripetuti), ed in<br />
oratio recta, la <strong>parola</strong>, la frase, e insomma il dictum di questa terza persona. Più oltre<br />
si vedrà che possono esserci anche altri elementi; ma per il momento possiamo<br />
accontentarci di quelli strettamente indispensabili.<br />
Impiegando un procedimento di simbolizzazione piuttosto rudimentale, il tipo di<br />
rapporto che il wellerismo stabilisce tra il parlante e il dictum di cui egli si fa<br />
"relatante" potrebbe rappresentarsi come segue:<br />
L: « q: “d” »<br />
in cui L è il locutore o parlante, i due punti : rappresentano l'operazione "dire", q<br />
è il quidam che ha pronunciato la <strong>parola</strong> o il detto d, le virgolette ‘inglesi’ « »<br />
delimitano l'enunciato di L, e le virgolette ‘semplici’ “ ” segnalano che il dictum è<br />
ripetuto in oratio recta.<br />
Mi rendo perfettamente conto che la formula rappresenta piuttosto la citazione nella<br />
sua generalità che non la specificità del wellerismo. Occorrerebbe insomma precisare<br />
la differentia specifica del wellerismo all'interno del genus citazione. Per farlo si<br />
dovrebbero certo utilizzare talune qualità più superficiali che in genere sono state già<br />
notate: natura spesso (ma non sempre) "immaginaria” del personaggio q di cui si<br />
ripete il detto d; carattere di "detto stereotipato" di d, che di frequente, però, o non è<br />
un detto o non è stereotipato; carattere "ironico” (ma anche “solenne" e simili) della<br />
citazione "welleristica”, ecc. Ma non si potrebbe trascurare un esame più<br />
approfondito, rivolto soprattutto ai rapporti interni ed a quelli “situazionali" dei testi<br />
correntemente classificati (o percepiti) come wellerismi. Occorrerebbe precisare (più<br />
linguisticamente che psicologicamente) l'atteggiamento del locutore nei confronti<br />
dell'enunciato di cui si fa esplicitamente “relatante", invece di enunciarlo<br />
direttamente. Bisognerebbe perciò esaminare - ciascuno per sé e nella rete delle loro<br />
interazioni - i rapporti tra il locutore e la sua "situazione" socio-contestuale (rapporti<br />
già segnalati, ad es., dalla definizione di G. Pettenati più sopra riferita); i rapporti tra<br />
"il locutore nella sua situazione” e il destinatario (anche lui "in situazione"); i rapporti<br />
tra “locutore/destinatario/situazione” (elemento per elemento e complessivamente) e<br />
il "quidam", locutore-personaggio, il quale ultimo è in rapporto con il suo dictum,<br />
ecc. Insomma occorrerebbe analizzare il wellerismo nella totalità delle sue<br />
caratteristiche e dei suoi rapporti, in quanto fatto linguistico e di comunicazione che è<br />
sempre funzione della situazione socio-contestuale. Ma è del tutto evidente che le<br />
totalità si affrontano solo a condizione di dividerle e suddividerle (sempre che,<br />
naturalmente, un tale frazionamento sia consapevole di sé e della totalità su cui opera<br />
ed alla quale intende tornare).