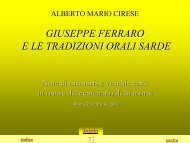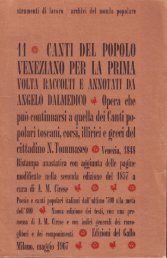Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I PROVERBI DI PREFERENZA 166<br />
contestuale ed extra-linguistica in cui il wellerismo viene pronunciato, o invece ad un<br />
qualche contesto linguistico-narrativo di cui il wellerismo è o potrebbe essere parte:<br />
per es. il racconto del carbonaio che alla domenica indossa a rovescio la sua abituale<br />
camicia esclamando appunto Quant'è bella la pulizia.<br />
La seconda osservazione riguarda lo svoIgimento temporale: si può parlare di<br />
historiola quando non ci sia una simulazione esplicita dello sviluppo dell'azione nel<br />
tempo?<br />
Per concludere su Costanza e su Il carbonaio mi pare dunque che:<br />
a) Non si può parlare di micro-racconto a proposito di Costanza la cui unità - in<br />
quanto associazione di q: e “d” - è soprattutto isofonica, ed interamente reversibile, se<br />
non per ciò che concerne il rapporto tra L e «q: “d”», certo per quel che riguarda “d”.<br />
Costanza resta dunque quel che genericamente si chiama un wellerismo almeno dal<br />
punto di vista dello scarto tra il locutore L e la sentenza “d”; ma appartiene ad un<br />
gruppo di wellerismi (del resto correntemente detti .proverbi welleristici" o<br />
"wellerizzati") che non è lo stesso cui si deve assegnare Il carbonaio.<br />
b) A proposito del Carbonaio si può parlare di micro-racconto in forza della<br />
relazione oppositiva tra i termini contestuali “pulizia” e “carbonaio”, ma occorre<br />
aggiungere da un lato che il wellerismo conserva una ambiguità che non si può<br />
risolvere nell'ambito del testo stesso, e dall'altro che non c'è simulazione esplicita<br />
dello svolgimento temporale.<br />
3. Il terzo esempio, che intitolerò Donno Janne, servirà forse a chiarire uno o due<br />
punti già considerati. Eccone innanzi tutto il testo:<br />
III. Dicette Donno Janne: 'O fecato nun è carne<br />
e cioè: Disse don Giovanni: Il fegato non è carne.<br />
A parte il rapporto isofonico (“rima”) tra Janne e carne, si capisce soltanto che un<br />
tale, chiamato Donno Janne, ha enunciato una banalità, o quasi, quale è appunto<br />
l'affermazione che "il fegato non è carne”. In altri termini, al livello dei fatti<br />
verbalizzati non si può stabilire alcun asse semantico che possa legare q: e “d”, e<br />
dunque non si può stabilire alcun rapporto di opposizione-associazione che assicuri<br />
l'autonomia del testo nei confronti dei fatti non verbaIizzati, della situazione ecc.<br />
D'altronde la relazione fegato / non carne è polivalente: l'espressione non è<br />
codificata, come invece avviene nel caso di “il sangue non è acqua”. Ed in effetti<br />
Raffaele Corso - pubblicando una variante di Donno Janne: 1947 p. 13 -dichiarò che<br />
non gli riusciva di spiegare né il personaggio (ma suppose che si trattasse di un<br />
teologo, senza peraltro notare il rapporto isofonico), né perché mai questi venisse a<br />
proclamare la differenza tra fegato e carne. Tutto invece pare spiegarsi quando si<br />
conosca la storia, riferita da G. Tucci, del prete don Giovanni che, avendo mangiato<br />
fegato al venerdì, se ne giustificò affermando appunto che il fegato non è carne.<br />
Allora "si capisce", perché si sa che don Giovanni è un prete cui incombe il dovere di<br />
rispettare le regole sia del digiuno sia della verità; che questo prete ha violato la