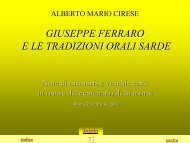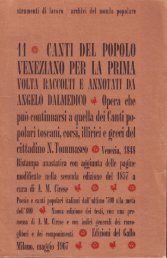Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I PROVERBI DI PREFERENZA 169<br />
a) testi del tipo Costanza, nei quali i segmenti componenti possono essere separati<br />
senza che l'espressione attribuita al personaggio perda senso, e che non hanno alcuna<br />
dimensione narrativa;<br />
b) testi non scindibili, del tipo Donno Janne, che possono essere considerati come<br />
evocazione e "condensazione emblematica" di una narrazione (sia essa o meno la<br />
"fonte" del wellerismo), e che possono perdere la loro polisemia soltanto se si<br />
conosce “qualche altra cosa" oltre al testo in sé;<br />
c) testi ancora una volta non scindibili, ma che presentano un senso autonomo e<br />
autosufficiente, pur se in misura diversa: da un lato c’è il Carbonaio, che è in sé<br />
intelligibile ma che tuttavia conserva una certa ambiguità che deriva dalla polivalenza<br />
del rapporto tra la qualità del personaggio e il contenuto del suo enunciato; dall'altro<br />
lato ci sono Donna Lena e Ottimo disse che, grazie alla presenza di un terzo elemento<br />
o segmento, stabiliscono all'interno del testo un rapporto oppositivo perfettamente<br />
chiaro, assolutamente univoco, completamente intelligibile senza bisogno di<br />
conoscenze specifiche preliminari o extratestuali.<br />
Negli esempi che abbiamo esaminato la differenza tra la historiola ancora ambigua e<br />
il micro-racconto perfettamente autonomo si trova a coincidere con la differenza tra<br />
testi a due membri e testi a tre membri; ma bisogna sottolineare che si tratta di una<br />
coincidenza che non sembra avere alcuna necessità logica. E facile prevedere testi a<br />
due membri e tuttavia perfettamente univoci e autonomi. Le categorie classificatorie<br />
correntemente utilizzate per i wellerismi (distinzione tra wellerismo e citazione, tra<br />
"proverbio wellerizzato” e "wellerismo-apologo", tra testi a due elementi e testi a tre<br />
elementi ecc.) appaiono dunque insufficienti e chiedono di essere riformulate. Per<br />
farlo, e cioè per arrivare ad una classificazione adeguata, bisogna abbandonare le<br />
considerazioni che mescolano a caso i fatti linguistici e quelli extralinguistici, le<br />
osservazioni testuali e quelle extra-testuali ecc.<br />
E questa la ragione per cui ho ritenuto preferibile affrontare l'argomento piuttosto<br />
isolando dei testi "indissolubili e autonomi" che non affrontando la questione<br />
generale della distinzione tra "citazione” e "wellerismo". Aggiungerò che non intendo<br />
identificare il piccolo gruppo privilegiato dei "micro-racconti welleristici”né con il<br />
wellerismo né con il micro-racconto: ci sono wellerismi che non sono micro-racconti<br />
e micro-racconti che non sono wellerismi. In ogni caso, una definizione più rigorosa<br />
del wellerismo non potrebbe non mantenere un qualche valido rapporto con la<br />
nozione intuitiva e corrente da cui si sono prese le mosse, a meno che non si tratti di<br />
dissolverla in quanto del tutto infondata. Ma in quest'ultimo caso sarebbe del tutto<br />
arbitrario designare con il significante della nozione intuitiva un significato che se ne<br />
distacca totalmente.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
in cui si fa riferimento anche alla maggiore raccolta di wellerismi disponibile finora<br />
in Italia (GIOVANNI TUCCI, Dicette Polecenella, Silva, Milano 1966) e alla<br />
Recensione a tre voci che ne fecero A. L. COLAJANNI, G. PETTENATI e A.<br />
MANGO, in Problemi”, n. 9, Palermo, maggio-giugno 1968, pp. 419-27].