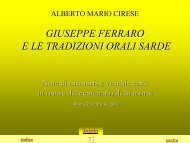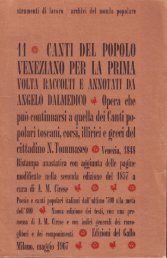Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I PROVERBI DI PREFERENZA 168<br />
che potrebbero facilmente unificarsi tra loro e con l'opposizione offertaci dal<br />
Carbonaio. Ma va sottolineato che, a differenza del Carbonaio, l’effetto (comico)<br />
che nasce dall'opposizione tra i fatti reali e le manifestazioni verbali di Donna Lena e<br />
di Ottimo disse non è ambiguo. Infatti gli elementi offertici dai due testi sono del<br />
tutto autonomi nei confronti della situazione extra-testuale o del contesto non<br />
verbalizzato: per capire, e per ridere, non occorre possedere preliminarmente nessuna<br />
cognizione specifica; non bisogna presupporre la conoscenza né di questo o quel<br />
racconto (di cui i wellerismi sarebbero la condensazione emblematica), né della storia<br />
dei personaggi. Donna Lena è una qualsiasi donna, e dunque un personaggio che<br />
resta neutro (salvo il rapporto isofonico, che però sta tutto all'interno del testo). Un<br />
conte, poi, vale l'altro; ed anche nel caso che il personaggio cambiasse (e divenisse<br />
per esempio “mio nonno”), le sfumature perdute o introdotte resterebbero trascurabili<br />
rispetto all'unità e all'autonoma intelligibilità del testo.<br />
Bisogna aggiungere un'osservazione: il terzo elemento offertoci da Donna Lena e<br />
Ottimo disse - e cioè q⇒A - rende in qualche modo esplicita la simulazione dello<br />
svolgimento temporale: il che comporta una ulteriore differenza dal Carbonaio. Il<br />
locutore L è il "relatante” non solo di un fatto di <strong>parola</strong>, ma anche delle circostanze e<br />
azioni non verbali che l'hanno accompagnato.<br />
Si potrebbe allora dire che Donna Lena e Ottimo disse hanno uno statuto "narrativo”<br />
più completo ed evidente del Carbonaio, e cioè che sono più nettamente historiolae,<br />
micro-racconti? O invece deve ritenersi che le condizioni minime per l'esistenza di<br />
una narrazione siano già realizzate anche dal Carbonaio, pur in assenza della<br />
simulazione dello svolgimento temporale, ed a dispetto dell'ambiguità di senso che lo<br />
caratterizza? Personalmente propendo per la prima ipotesi; ma quel che si<br />
desidererebbe è appunto il contributo di una discussione.<br />
5. Aggiungo alcune considerazioni finali. I testi che i folkloristi chiamano<br />
abitualmente wellerismi sono una species o sotto-classe del genus, o classe, delle<br />
"citazioni". Per distinguere adeguatamente tra le citazioni-wellerismo e gli altri tipi di<br />
citazione non ci si può contentare delle osservazioni grossolane e parziali sulla natura<br />
del personaggio implicato, sul carattere "proverbiale” dei dicta che gli vengono<br />
attribuiti ecc. Occorre esaminare, esaustivamente e comparativamente, la rete di<br />
rapporti tra tutti gli elementi (locutori, destinatari, situazioni, enunciati riferiti ecc.)<br />
che concorrono a formare la citazione in genere e le citazioni-wellerismo in specie.<br />
Questo esame, una volta compiuto, comporterà un rimaneggiamento più o meno<br />
profondo della nozione stessa di wellerismo, escludendone certi testi abitualmente<br />
inclusi, includendone altri abitualmente esclusi, riconoscendo varietà all'interno della<br />
stessa specie, oppure raggruppamenti di specie dello stesso ordine ecc. Potrà darci,<br />
insomma, una classificazione adeguata.<br />
Come primo passo verso questa classificazione, si può qui ricapitolativamente<br />
osservare che tra i testi correntemente denominati wellerismi sono riconoscibili<br />
almeno i seguenti gruppi: