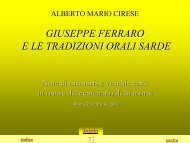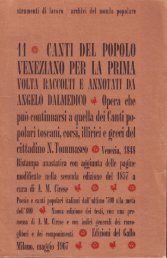Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I PROVERBI DI PREFERENZA 164<br />
Per questa ragione appunto credo non soltanto possibile, ma addirittura necessario<br />
isolare provvisoriamente alcuni elementi che sembrano presentare un più accentuato<br />
grado di autonomia (relativa). Ciò vale soprattutto per l'enunciato tra virgolette<br />
‘inglesi’(« »), di cui viene esplicitato e verbalizzato il solo rapporto con il locutore L<br />
- e ciò per mezzo del segmento q: - , mentre invece le altre relazioni con la situazione<br />
ecc. vanno ricercate altrove. Da questo punto di vista si potrebbe accertare da un lato<br />
se tutti i testi correntemente chiamati wellerismi sopportino una simile operazione di<br />
isolamento del segmento « », pur conservando un senso che sia riconoscibile senza<br />
far ricorso agli elementi extra-testuali; e dall'altro se in tutti i testi il segmento q:<br />
presenti lo stesso grado di necessità, e cioè se lo scarto "narrativo” che esso sembra<br />
stabilire tra il locutore L e il citatum sia effettivamente intrinseco o invece<br />
sovrapposto. Le due direzioni di ricerca sono evidentemente convergenti tra loro e<br />
verso la questione del wellerismo (o almeno di certi tipi di wellerismo) in quanto<br />
micro-racconti. Tralasciando ogni altra considerazione teorica, porrò dunque i miei<br />
quesiti sulla base di cinque wellerismi (che traggo n parte dalla raccolta napoletana<br />
Dicette Polecenella di Giovanni Tucci.).<br />
2. I primi due testi, che intitolerò rispettivamente Costanza e Il carbonaio, sono i<br />
seguenti:<br />
I. Disse Costanza: L'acqua vuole la pendenza<br />
E l'amore la speranza<br />
II. Quant'è bella la pulizia, disse il carbonaio.<br />
Si scorge abbastanza agevolmente una notevole differenza per quel che riguarda il<br />
rapporto tra q: e d.<br />
Il dictum d di Costanza (L'acqua ecc. ) è un detto o proverbio che ha un notevole<br />
grado di formalizzazione, perfino a livello metrico: c'è non soltanto il parallelismo<br />
acqua / pendenza<br />
amore / speranza<br />
ma anche una relazione di isofonia (“rima”) tra le desinenze dei due versi (giacché<br />
di veri e propri versi si tratta), e cioè tra -enza e -anza. Si tratta, come è noto, di un<br />
grado di isofonia correntemente detto "consonanza atona", che fu già presente<br />
nella poesia delle origini ed ancor oggi viene largamente utilizzato sia nella poesia<br />
di vecchia tradizione orale sia nella moderna canzonettistica radiotelevisiva.<br />
Questa accentuata formalizzazione, che si aggiunge al "senso compiuto" e al carattere<br />
di “sentenza", già basta per assicurare al dictum di Costanza una netta autonomia nei<br />
confronti del segmento q: “Disse Costanza”. Ma c'è di più: è possibile separare d da<br />
q:, e cioè si può leggere isolatamente l'enunciato attribuito a Costanza (“L'acqua<br />
etc.”) senza che cambi il senso del detto in sé. Naturalmente c'è qualcosa che cambia:<br />
il rapporto con il locutore L, il carattere di citazione ecc. Ma resta il fatto che,<br />
all'interno dell'enunciato di L, tra q: e d non c'è alcun legame davvero necessario (e