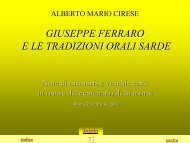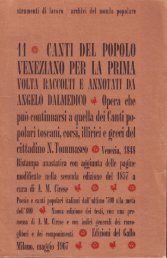Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
Una parola tira l'altra - AM Cirese
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2. Prime approssimazioni<br />
2.1. Proverbialità potenziale e proverbialità attuale<br />
Nella raccolta di proverbi toscani di Giuseppe Giusti troviamo il seguente<br />
testo, cui già ci siamo riferiti:<br />
Il beccaio non ama il pescatore,<br />
ossia, parafrasando un poco:<br />
chi vende carni non ama chi vende pesci.<br />
Ci si chiede: se udissimo questa espressione, senza sapere che essa è registrata<br />
in una raccolta di proverbi, penseremmo che essa è un proverbio, o invece la<br />
considereremmo come una frase qualsiasi, appartenente al discorso corrente e<br />
normale? È molto probabile che la nostra impressione sarebbe appunto la seconda:<br />
non penseremmo ad un proverbio, o vi penseremmo soltanto se la frase venisse<br />
pronunciate in una situazione particolare: per esempio nel corso di un discorso in cui<br />
ci si riferisce ad attività concorrenziali qualsiasi, che possono anche non avere nulla<br />
che vedere con quella del macellaio (che vende carne) o quella del pescatore (che<br />
vende pesce); pronunciare allora l’espressione “Il beccaio” ecc. assume un valore per<br />
così dire di sentenza; il significato effettivo della frase diviene: “è ovvio che non ci<br />
può essere amore tra due persone (o tra due attività) in concorrenza, quali che stano<br />
queste persone o queste attività”. In altre parole l'espressione, che in sé è specifica in<br />
quanto si riferisce a due specifiche attività, assume un valore generale e traslato:<br />
diviene simbolo di tutte le situazioni concorrenziali e delle loro normali conseguenze.<br />
Tutto ciò equivale a dire che il valore proverbiale di Il beccaio dipende in gran<br />
parte dalla collocazione effettiva e concreta di quel testo in una situazione extratestuale<br />
(nella situazione socio-culturale in cui viene o può venire pronunciata).<br />
Ben diversa è l'effetto di espressioni come<br />
Chi rompe paga<br />
Chi tace acconsente<br />
Chi sa, fa, e chi non sa insegna<br />
ecc. Queste espressioni vengono percepite immediatamente come<br />
"detti", "ammaestramenti", "sentenze", "proverbi" e simili, anche se si<br />
ignora che sono catalogati come proverbi nelle raccolte, ed anche se si<br />
prescinde da tutte le occasioni e situazioni concrete in cui sono state<br />
pronunciate.<br />
Da che cosa dipende questa differenza tra "Il beccaio" da un lato e "Chi rompe<br />
paga" o simili dall'altro? Evidentemente da certe proprietà o qualità dei rispettivi<br />
testi, e la nostra ricerca è appunto quella di identificare almeno qualcuna di tali<br />
proprietà o qualità.<br />
Possiamo intanto riconoscere subito una evidente differenza tra "Il beccaio" e<br />
"Chi rompe". Diciamo che Il beccaio ha un riferimento specifico (due specifiche<br />
categorie o attività: beccaio e pescatore), mentre "Chi rompe" ha già in sé un carattere<br />
generale (chiunque rompa, chiunque taccia, ecc.).<br />
In altre parole, Il beccaio può essere assunto come significativo di una<br />
situazione generale o addirittura universale (tutti quelli che sono in concorrenza non<br />
si amano, chiunque sia in concorrenza non ama il suo rivale, ecc.) e questa<br />
32