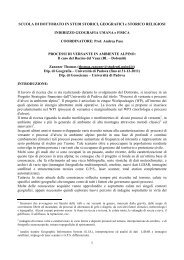Documento - Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici ...
Documento - Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici ...
Documento - Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ANTONIO ROTONDÒ<br />
modenesi a queste <strong>di</strong>ffuse espressioni della polemica antiecclesiastica derivava<br />
da presupposti ra<strong>di</strong>cati nella mentalità d’un esperto <strong>di</strong> canoni e già<br />
da più d’un ventennio accorto amministratore della <strong>di</strong>ocesi quale era il<br />
Sigibal<strong>di</strong>. Derivava, in primo luogo, dall’in<strong>di</strong>fferenza del Sigibal<strong>di</strong> a una<br />
conoscenza ravvicinata, anche se non necessariamente compromissoria,<br />
delle idee che si esprimevano nella crescente protesta <strong>di</strong> tanta parte della<br />
città. Nel periodo più agitato della pre<strong>di</strong>cazione modenese dell’agostiniano<br />
Egi<strong>di</strong>o da Bergamo, tutto ciò che egli seppe riferire al Morone sul<br />
contenuto delle pre<strong>di</strong>che fu che «alchuno m’ha pur detto non so che, alchuno<br />
ch’el pre<strong>di</strong>ca catholicamente»; né seppe riferire <strong>di</strong> più sul controverso<br />
passato del frate se non che gli erano state attribuite «certe heresie».<br />
244 Quando, poi, dal suo osservatorio <strong>di</strong> Modena Sigibal<strong>di</strong> provava a<br />
guardare alla complessiva rivoluzione del secolo, compen<strong>di</strong>ava tutte le<br />
deviazioni dei «moderni heretici» nella «speranza (utinam vana) – come<br />
scriveva sempre al Morone – che l’authorità ecclesiastica vada in fumo et<br />
che ne li altri articoli li sia licito quel che li piace, secondo la libertà christiana<br />
carnale a loro modo intesa». 245 La polemica contro gli abusi – che<br />
forse preoccupavano il Sigibal<strong>di</strong> più <strong>di</strong> quanto fosse la norma d’un vicario<br />
<strong>di</strong>ocesano del tempo – era irrilevante rispetto all’intangibilità del canone<br />
che sorreggeva la potestà dell’istituzione; ma quando essa si risolveva<br />
in critica dell’incontestabile esercizio dell’autorità ecclesiastica, allora<br />
costituiva una minaccia alla sola garanzia contro l’instaurazione d’una «libertà<br />
christiana carnale». Probabilmente da questa visione delle cose nacque<br />
la rottura <strong>di</strong> Giovanni Bertari col Sigibal<strong>di</strong> in iniziative riformatrici<br />
cc. 63v-64r), nei Pasquillorum tomi duo cit., II, pp. 302-305 (cfr. Carmina Burana, ed. HILKA-<br />
SCHUMANN, Heidelberg, Carl Winter, 1930, I, p. 44, con bibliografia, che tuttavia ignora l’e<strong>di</strong>zione<br />
del Curione). Dieci anni dopo, nel febbraio del 1537, in un singolare <strong>di</strong>alogo epistolare<br />
tra Pasquino e la Bonissima (figurazione modenese della saggezza popolare), quest’ultima<br />
trasse occasione dalla pubblica denuncia <strong>di</strong> un’usurpazione <strong>di</strong> uffici perpetrata in <strong>di</strong>spregio<br />
degli or<strong>di</strong>namenti citta<strong>di</strong>ni, per deplorare ciò che, eccezione a Modena, a Roma era invece<br />
malo esempio e norma <strong>di</strong> curia: un groviglio <strong>di</strong> benefici «intertiati et intrigati» con arbitrarie<br />
designazioni ere<strong>di</strong>tarie <strong>di</strong> nipoti e pronipoti, tale «ch’el <strong>di</strong>avolo non saperia far peggio»;<br />
non c’era <strong>di</strong> che meravigliarsi se Dio aveva mandato i lanzichenecchi a porre almeno<br />
un provvisorio rime<strong>di</strong>o («a schurmar la pignata»); c’era, invece, da prevedere che «una favilla<br />
del presente serà più del passato fiamma». E Tommasino trascrisse (ma anche questo fu<br />
omesso nell’e<strong>di</strong>zione ottocentesca) nella Cronaca quel fittizio carteggio tra le «cose degne <strong>di</strong><br />
memoria», compresa l’investitura <strong>di</strong> Pasquino come «protettore del populo modenese». Sul<br />
Sacco <strong>di</strong> Roma come avveramento, secondo Lancillotti, <strong>di</strong> varie profezie, ve<strong>di</strong> OTTAVIA<br />
NICCOLI, Profeti e popolo nell’Italia del Rinascimento, Bari, Laterza, 1987, pp. 15-17, 222-225.<br />
244 MASSIMO FIRPO, DARIO MARCATTO, IL processo inquisitoriale cit., II, pp. 924, 932, lettera<br />
al Morone del 1 o marzo 1541.<br />
245 Ibid., p. 1020, lettera al Morone del 3 giugno 1541.<br />
~ 138 ~