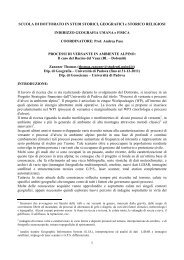Documento - Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici ...
Documento - Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici ...
Documento - Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
II - ANTICRISTO E CHIESA ROMANA<br />
dottrine <strong>di</strong> provenienza anabattista era stata larghissima anche tra popolani<br />
le cui vicende e le cui idee non sono sempre riportabili all’ambito del<br />
movimento anabattista così come risulta delimitato nella nota delazione<br />
<strong>di</strong> don Pietro Manelfi. Ora, se, per Bologna, le testimonianze tuttora a<br />
<strong>di</strong>sposizione non documentano rapporti tra la cerchia del Vittori e il vivace<br />
gruppo bolognese <strong>di</strong> tessitori che Antonio Balduzzi <strong>di</strong>sperse negli<br />
stessi anni, esse documentano, invece, che al centro del loro mondo religioso<br />
vi fu la figura d’un popolano che già nel 1551 il Manelfi aveva denunciato<br />
come anabattista proprio in quella parte della sua delazione<br />
consegnata, a Bologna, nelle mani dell’inquisitore Leandro Alberti.<br />
Era giunto a Bologna probabilmente nel 1555. Lo conoscevano tutti<br />
– compreso il Manelfi – come Baldassarre «bambinaro», dal suo mestiere<br />
<strong>di</strong> fabbricante <strong>di</strong> bambole. 220 In un estratto del processo bolognese <strong>di</strong><br />
Marco Magnavacca (1566) è detto «Baldassar quondam Ioannis de Venetiis»;<br />
nella sentenza che il 22 gennaio 1567 deferì lui stesso al braccio se-<br />
Inquisizione, busta 6, Processi 1569-1573, «Liber duodecimus», processo Pighino Baroni, testimonianza<br />
<strong>di</strong> Andrea Martini del 21 maggio 1570), era un conta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni agiate,<br />
possedendo cinque pezze <strong>di</strong> terra «arborate a vite» e una pezza «casamentiva» in Savignano<br />
(ibid., Rettori: Modena e Modenese, Savignano, copialettere, f. 86r: «Pelegrino Baroni detto<br />
Grasso»). Molte delle idee che Pighino, secondo la <strong>di</strong>stinzione dell’inquisitore, confessò o gli<br />
vennero attribuite, erano ampiamente <strong>di</strong>ffuse nel contado modenese. Ad esempio, nel feudo<br />
<strong>di</strong> Nirano (presso Fiorano), Natale Andreotti sosteneva che «morto il corpo era morta l’anima»,<br />
con le stesse contrad<strong>di</strong>zioni rilevate da Ginzburg a proposito <strong>di</strong> Pighino (ve<strong>di</strong> processo<br />
Natale Andreotti da Nirano cit. alla nota 199, deposizione <strong>di</strong> Bernar<strong>di</strong>na Pellicani del 25<br />
gennaio 1574). A Monfestino, il prete Giovanni Tremanini, del quale un testimone <strong>di</strong>ceva<br />
«pare habbia devorato la Grecia» (l’inquisitore Camillo Campeggio lo descriveva così: «Presbyter<br />
quidam nomine Ioannes Tremaninus [...] modo huc modo illuc tamquam profugus se<br />
transfert et iu<strong>di</strong>cis faciem declinare studet») sosteneva pubblicamente (a detta d’un testimone,<br />
anche fra i conta<strong>di</strong>ni) che «l’anima è mortale». Questa convinzione del Tremanini risaliva<br />
a vent’anni prima, secondo la testimonianza <strong>di</strong> Giovanni Antonio Del Pino, che fra l’altro<br />
<strong>di</strong>chiarò: «Io ho inteso <strong>di</strong>re a esso don Giovanni che per il tempo passato havea tenuto et<br />
creduto morto il corpo perisse anchora l’anima, ma <strong>di</strong> puoi si era levato <strong>di</strong> questa openione<br />
per haver sentito al tempo <strong>di</strong> notte certi strepiti in un palazzo, per i quali haveva conosciuto<br />
che erano spiriti» (ibid., busta 3, Processi 1550-1565, «Liber octavus», processo Don Giovanni<br />
Tremanini, deposizione <strong>di</strong> Giovanni Antonio Del Pino del 23 agosto 1564). A Sassomolare<br />
(presso Pavullo), il conte Cesare Montecuccoli negava l’esistenza dell’inferno e l’immortalità<br />
dell’anima, secondo la testimonianza d’un gruppo <strong>di</strong> preti, che associavano tali credenze del<br />
Montecuccoli ai suoi costumi libertini (oltre che ai suoi soprusi ai danni della giuris<strong>di</strong>zione<br />
parrocchiale): ibid., busta 6, Processi 1569-1573, «Liber duodecimus», processo Cesare Montecuccoli,<br />
deposizione del 29 maggio 1570. E così via.<br />
220 Cfr. CARLO GINZBURG, I costituti <strong>di</strong> don Pietro Manelfi, Firenze, Sansoni, Chicago, The<br />
Newberry Library, 1970, p. 39: «Baldessera colla moglie, anabattisti». Nel suo costituto del<br />
13 agosto 1571, Lucrezia Cavalieri raccontò all’inquisitore che il marito Rinaldo era riuscito<br />
a fuggire da Bologna prima dell’arresto perché avvertito da un figlio <strong>di</strong> Baldassarre.<br />
~ 131 ~