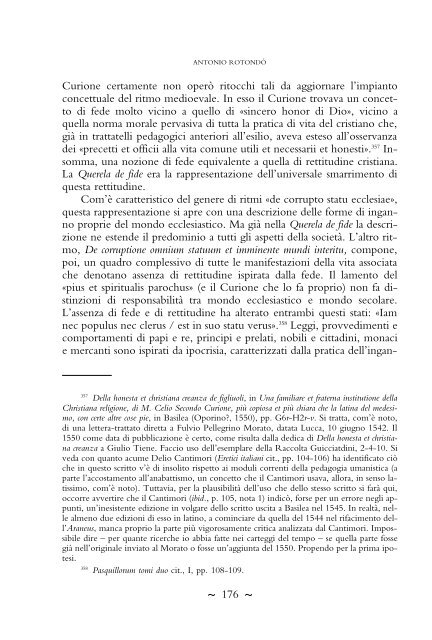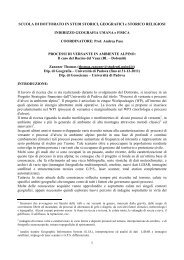Documento - Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici ...
Documento - Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici ...
Documento - Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ANTONIO ROTONDÒ<br />
Curione certamente non operò ritocchi tali da aggiornare l’impianto<br />
concettuale del ritmo me<strong>di</strong>oevale. In esso il Curione trovava un concetto<br />
<strong>di</strong> fede molto vicino a quello <strong>di</strong> «sincero honor <strong>di</strong> Dio», vicino a<br />
quella norma morale pervasiva <strong>di</strong> tutta la pratica <strong>di</strong> vita del cristiano che,<br />
già in trattatelli pedagogici anteriori all’esilio, aveva esteso all’osservanza<br />
dei «precetti et officii alla vita comune utili et necessarii et honesti». 357 Insomma,<br />
una nozione <strong>di</strong> fede equivalente a quella <strong>di</strong> rettitu<strong>di</strong>ne cristiana.<br />
La Querela de fide era la rappresentazione dell’universale smarrimento <strong>di</strong><br />
questa rettitu<strong>di</strong>ne.<br />
Com’è caratteristico del genere <strong>di</strong> ritmi «de corrupto statu ecclesiae»,<br />
questa rappresentazione si apre con una descrizione delle forme <strong>di</strong> inganno<br />
proprie del mondo ecclesiastico. Ma già nella Querela de fide la descrizione<br />
ne estende il predominio a tutti gli aspetti della società. L’altro ritmo,<br />
De corruptione omnium statuum et imminente mun<strong>di</strong> interitu, compone,<br />
poi, un quadro complessivo <strong>di</strong> tutte le manifestazioni della vita associata<br />
che denotano assenza <strong>di</strong> rettitu<strong>di</strong>ne ispirata dalla fede. Il lamento del<br />
«pius et spiritualis parochus» (e il Curione che lo fa proprio) non fa <strong>di</strong>stinzioni<br />
<strong>di</strong> responsabilità tra mondo ecclesiastico e mondo secolare.<br />
L’assenza <strong>di</strong> fede e <strong>di</strong> rettitu<strong>di</strong>ne ha alterato entrambi questi stati: «Iam<br />
nec populus nec clerus / est in suo statu verus». 358 Leggi, provve<strong>di</strong>menti e<br />
comportamenti <strong>di</strong> papi e re, principi e prelati, nobili e citta<strong>di</strong>ni, monaci<br />
e mercanti sono ispirati da ipocrisia, caratterizzati dalla pratica dell’ingan-<br />
357 Della honesta et christiana creanza de figliuoli, in Una familiare et fraterna institutione della<br />
Christiana religione, <strong>di</strong> M. Celio Secondo Curione, più copiosa et più chiara che la latina del medesimo,<br />
con certe altre cose pie, in Basilea (Oporino?, 1550), pp. G6r-H2r-v. Si tratta, com’è noto,<br />
<strong>di</strong> una lettera-trattato <strong>di</strong>retta a Fulvio Pellegrino Morato, datata Lucca, 10 giugno 1542. Il<br />
1550 come data <strong>di</strong> pubblicazione è certo, come risulta dalla de<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> Della honesta et christiana<br />
creanza a Giulio Tiene. Faccio uso dell’esemplare della Raccolta Guicciat<strong>di</strong>ni, 2-4-10. Si<br />
veda con quanto acume Delio Cantimori (Eretici italiani cit., pp. 104-106) ha identificato ciò<br />
che in questo scritto v’è <strong>di</strong> insolito rispetto ai moduli correnti della pedagogia umanistica (a<br />
parte l’accostamento all’anabattismo, un concetto che il Cantimori usava, allora, in senso latissimo,<br />
com’è noto). Tuttavia, per la plausibilità dell’uso che dello stesso scritto si farà qui,<br />
occorre avvertire che il Cantimori (ibid., p. 105, nota 1) in<strong>di</strong>cò, forse per un errore negli appunti,<br />
un’inesistente e<strong>di</strong>zione in volgare dello scritto uscita a Basilea nel 1545. In realtà, nelle<br />
almeno due e<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esso in latino, a cominciare da quella del 1544 nel rifacimento dell’Araneus,<br />
manca proprio la parte più vigorosamente critica analizzata dal Cantimori. Impossibile<br />
<strong>di</strong>re – per quante ricerche io abbia fatte nei carteggi del tempo – se quella parte fosse<br />
già nell’originale inviato al Morato o fosse un’aggiunta del 1550. Propendo per la prima ipotesi.<br />
358 Pasquillorum tomi duo cit., I, pp. 108-109.<br />
~ 176 ~