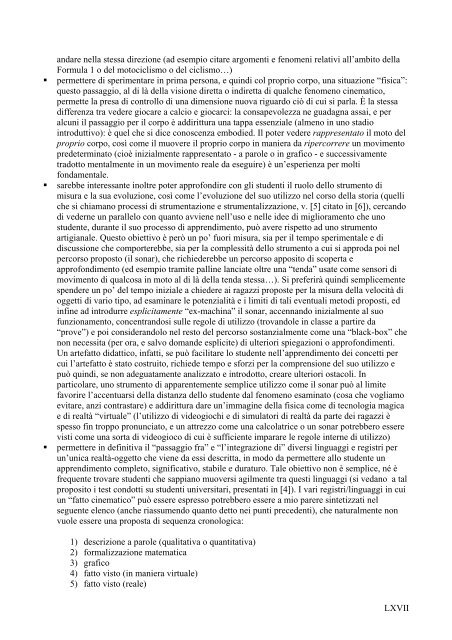Insegnamento e Apprendimento delle Coniche A049.pdf - Didattica.it
Insegnamento e Apprendimento delle Coniche A049.pdf - Didattica.it
Insegnamento e Apprendimento delle Coniche A049.pdf - Didattica.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
andare nella stessa direzione (ad esempio c<strong>it</strong>are argomenti e fenomeni relativi all’amb<strong>it</strong>o della<br />
Formula 1 o del motociclismo o del ciclismo…)<br />
permettere di sperimentare in prima persona, e quindi col proprio corpo, una s<strong>it</strong>uazione “fisica”:<br />
questo passaggio, al di là della visione diretta o indiretta di qualche fenomeno cinematico,<br />
permette la presa di controllo di una dimensione nuova riguardo ciò di cui si parla. È la stessa<br />
differenza tra vedere giocare a calcio e giocarci: la consapevolezza ne guadagna assai, e per<br />
alcuni il passaggio per il corpo è addir<strong>it</strong>tura una tappa essenziale (almeno in uno stadio<br />
introduttivo): è quel che si dice conoscenza embodied. Il poter vedere rappresentato il moto del<br />
proprio corpo, così come il muovere il proprio corpo in maniera da ripercorrere un movimento<br />
predeterminato (cioè inizialmente rappresentato - a parole o in grafico - e successivamente<br />
tradotto mentalmente in un movimento reale da eseguire) è un’esperienza per molti<br />
fondamentale.<br />
sarebbe interessante inoltre poter approfondire con gli studenti il ruolo dello strumento di<br />
misura e la sua evoluzione, così come l’evoluzione del suo utilizzo<br />
nel corso della storia (quelli<br />
che si chiamano processi di strumentazione e strumentalizzazione, v. [ 5] c<strong>it</strong>ato in [6]), cercando<br />
di vederne un parallelo con quanto avviene nell’uso e nelle idee di miglioramento<br />
che uno<br />
studente, durante il suo processo di apprendimento, può avere rispetto ad uno strumento<br />
artigianale. Questo obiettivo è però un po’ fuori misura, sia per il tempo sperimentale e di<br />
discussione che comporterebbe, sia per la compless<strong>it</strong>à dello strumento a cui si approda poi nel<br />
percorso proposto (il sonar), che richiederebbe un percorso appos<strong>it</strong>o di scoperta e<br />
approfondimento (ed esempio tram<strong>it</strong>e palline lanciate oltre una “tenda” usate come sensori di<br />
movimento di qualcosa in moto al di là della tenda stessa…). Si preferirà quindi semplicemente<br />
spendere un po’ del tempo iniziale a chiedere ai ragazzi proposte per la misura della veloc<strong>it</strong>à di<br />
oggetti di vario tipo, ad esaminare<br />
le potenzial<strong>it</strong>à e i lim<strong>it</strong>i di tali eventuali metodi proposti, ed<br />
infine ad introdurre esplic<strong>it</strong>amente “ex-machina” il sonar, accennando inizialmente al suo<br />
funzionamento,<br />
concentrandosi sulle regole di utilizzo (trovandole in classe a partire da<br />
“prove”) e poi considerandolo nel resto del percorso sostanzialmente come una “black-box” che<br />
non necess<strong>it</strong>a (per ora, e salvo domande esplic<strong>it</strong>e) di ulteriori spiegazioni o approfondimenti.<br />
Un artefatto didattico, infatti, se può facil<strong>it</strong>are lo studente nell’apprendimento dei concetti<br />
per<br />
cui l’artefatto è stato costru<strong>it</strong>o, richiede tempo e sforzi per la comprensione del suo utilizzo e<br />
può quindi, se non adeguatamente analizzato e introdotto, creare ulteriori ostacoli. In<br />
particolare, uno strumento di apparentemente semplice utilizzo come il sonar può al lim<strong>it</strong>e<br />
favorire l’accentuarsi della distanza dello studente dal fenomeno esaminato (cosa che vogliamo<br />
ev<strong>it</strong>are, anzi contrastare) e addir<strong>it</strong>tura dare un’immagine della fisica come di tecnologia magica<br />
e di realtà “virtuale” (l’utilizzo di videogiochi e di simulatori di realtà da parte dei ragazzi è<br />
spesso fin troppo pronunciato, e un attrezzo come una calcolatrice o un sonar potrebbero essere<br />
visti come una sorta di videogioco di cui è sufficiente imparare le regole interne di utilizzo)<br />
permettere in defin<strong>it</strong>iva il “passaggio fra” e “l’integrazione<br />
di” diversi linguaggi e registri per<br />
un’unica realtà-oggetto che viene da essi descr<strong>it</strong>ta, in modo da permettere allo studente un<br />
apprendimento completo, significativo, stabile e duraturo. Tale obiettivo non è semplice, né è<br />
frequente trovare studenti che sappiano muoversi agilmente tra questi linguaggi (si vedano a tal<br />
propos<strong>it</strong>o i test condotti su studenti univers<strong>it</strong>ari, presentati in [4]). I vari registri/linguaggiincui<br />
un “fatto cinematico” può essere espresso potrebbero essere a mio parere sintetizzati nel<br />
seguente elenco (anche riassumendo quanto detto nei punti precedenti), che naturalmente non<br />
vuole essere una proposta di sequenza cronologica:<br />
1) descrizione a parole (qual<strong>it</strong>ativa o quant<strong>it</strong>ativa)<br />
2) formalizzazione matematica<br />
3) grafico<br />
4) fatto visto (in maniera virtuale)<br />
5) fatto visto (reale)<br />
LXVII