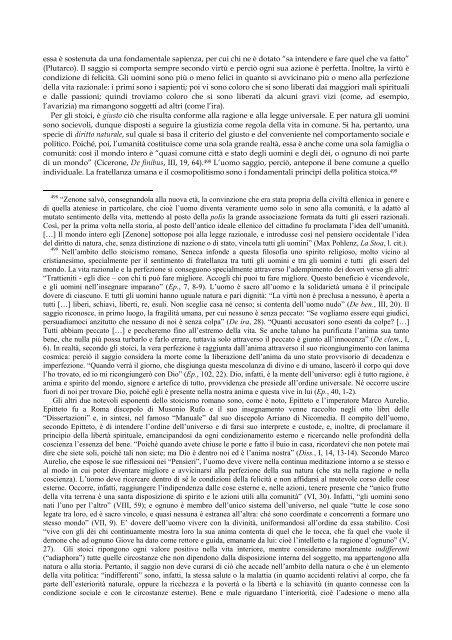Storia popolare della filosofia - prova-cor
Storia popolare della filosofia - prova-cor
Storia popolare della filosofia - prova-cor
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
essa è sostenuta da una fondamentale sapienza, per cui chi ne è dotato “sa intendere e fare quel che va fatto”<br />
(Plutarco). Il saggio si comporta sempre secondo virtù e perciò ogni sua azione è perfetta. Inoltre, la virtù è<br />
condizione di felicità. Gli uomini sono più o meno felici in quanto si avvicinano più o meno alla perfezione<br />
<strong>della</strong> vita razionale: i primi sono i sapienti; poi vi sono coloro che si sono liberati dai maggiori mali spirituali<br />
e dalle passioni; quindi troviamo coloro che si sono liberati da alcuni gravi vizi (come, ad esempio,<br />
l’avarizia) ma rimangono soggetti ad altri (come l’ira).<br />
Per gli stoici, è giusto ciò che risulta conforme alla ragione e alla legge universale. E per natura gli uomini<br />
sono socievoli, dunque disposti a seguire la giustizia come regola <strong>della</strong> vita in comune. Si ha, pertanto, una<br />
specie di diritto naturale, sul quale si basa il criterio del giusto e del conveniente nel comportamento sociale e<br />
politico. Poiché, poi, l’umanità costituisce come una sola grande realtà, essa è anche come una sola famiglia o<br />
comunità: così il mondo intero è “quasi comune città e stato degli uomini e degli dèi, o ognuno di noi parte<br />
di un mondo” (Cicerone, De finibus, III, 19, 64). 498 L’uomo saggio, perciò, antepone il bene comune a quello<br />
individuale. La fratellanza umana e il cosmopolitismo sono i fondamentali princìpi <strong>della</strong> politica stoica. 499<br />
498 “Zenone salvò, consegnandola alla nuova età, la convinzione che era stata propria <strong>della</strong> civiltà ellenica in genere e<br />
di quella ateniese in particolare, che cioè l’uomo diventa veramente uomo solo in seno alla comunità, e la adattò al<br />
mutato sentimento <strong>della</strong> vita, mettendo al posto <strong>della</strong> polis la grande associazione formata da tutti gli esseri razionali.<br />
Così, per la prima volta nella storia, al posto dell’antico ideale ellenico del cittadino fu proclamata l’idea dell’umanità.<br />
[…] Il mondo intero egli [Zenone] sottopose poi alla legge razionale, e introdusse così nel pensiero occidentale l’idea<br />
del diritto di natura, che, senza distinzione di nazione o di stato, vincola tutti gli uomini” (Max Pohlenz, La Stoa, l. cit.).<br />
499 Nell’ambito dello stoicismo romano, Seneca infonde a questa <strong>filosofia</strong> uno spirito religioso, molto vicino al<br />
cristianesimo, specialmente per il sentimento di fratellanza tra tutti gli uomini e tra gli uomini e tutti gli esseri del<br />
mondo. La vita razionale e la perfezione si conseguono specialmente attraverso l’adempimento dei doveri verso gli altri:<br />
“Trattieniti - egli dice – con chi ti può fare migliore. Accogli chi puoi tu fare migliore. Questo beneficio è vicendevole,<br />
e gli uomini nell’insegnare imparano” (Ep., 7, 8-9). L’uomo è sacro all’uomo e la solidarietà umana è il principale<br />
dovere di ciascuno. E tutti gli uomini hanno uguale natura e pari dignità: “La virtù non è preclusa a nessuno, è aperta a<br />
tutti […] liberi, schiavi, liberti, re, esuli. Non sceglie casa né censo; si contenta dell’uomo nudo” (De ben., III, 20). Il<br />
saggio riconosce, in primo luogo, la fragilità umana, per cui nessuno è senza peccato: “Se vogliamo essere equi giudici,<br />
persuadiamoci anzitutto che nessuno di noi è senza colpa” (De ira, 28). “Quanti accusatori sono esenti da colpe? […]<br />
Tutti abbiam peccato […] e peccheremo fino all’estremo <strong>della</strong> vita. Se anche taluno ha purificata l’anima sua tanto<br />
bene, che nulla più possa turbarlo e farlo errare, tuttavia solo attraverso il peccato è giunto all’innocenza” (De clem., I,<br />
6). In realtà, secondo gli stoici, la vera perfezione è raggiunta dall’anima attraverso il suo ricongiungimento con lanima<br />
cosmica: perciò il saggio considera la morte come la liberazione dell’anima da uno stato provvisorio di decadenza e<br />
imperfezione. “Quando verrà il giorno, che disgiunga questa mescolanza di divino e di umano, lascerò il <strong>cor</strong>po qui dove<br />
l’ho trovato, ed io mi ricongiungerò con Dio” (Ep., 102, 22). Dio, infatti, è la mente dell’universo: egli è tutto ragione, è<br />
anima e spirito del mondo, signore e artefice di tutto, provvidenza che presiede all’ordine universale. Né oc<strong>cor</strong>re uscire<br />
fuori di noi per trovare Dio, poiché egli è presente nella nostra anima e questa vive in lui (Ep., 40, 1-2).<br />
Gli altri due notevoli esponenti dello stoicismo romano sono, come è noto, Epitteto e l’imperatore Marco Aurelio.<br />
Epitteto fu a Roma discepolo di Musonio Rufo e il suo insegnamento venne raccolto negli otto libri delle<br />
“Dissertazioni” e, in sintesi, nel famoso “Manuale” dal suo discepolo Arriano di Nicomedia. Il compito dell’uomo,<br />
secondo Epitteto, è di intendere l’ordine dell’universo e di farsi suo interprete e custode, e, inoltre, di proclamare il<br />
principio <strong>della</strong> libertà spirituale, emancipandosi da ogni condizionamento esterno e ricercando nelle profondità <strong>della</strong><br />
coscienza l’essenza del bene. “Poiché quando avete chiuse le porte e fatto il buio in casa, ri<strong>cor</strong>datevi che non potete mai<br />
dire che siete soli, poiché tali non siete; ma Dio è dentro noi ed è l’anima nostra” (Diss., I, 14, 13-14). Secondo Marco<br />
Aurelio, che espose le sue riflessioni nei “Pensieri”, l’uomo deve vivere nella continua meditazione intorno a se stesso e<br />
al modo in cui poter diventare migliore e avvicinarsi alla perfezione <strong>della</strong> sua natura (che sta nella ragione o nella<br />
coscienza). L’uomo deve ricercare dentro di sé le condizioni <strong>della</strong> felicità e non affidarsi al mutevole <strong>cor</strong>so delle cose<br />
esterne. Oc<strong>cor</strong>re, infatti, raggiungere l’indipendenza dalle cose esterne e, nelle azioni, tenere presente che “unico frutto<br />
<strong>della</strong> vita terrena è una santa disposizione di spirito e le azioni utili alla comunità” (VI, 30). Infatti, “gli uomini sono<br />
nati l’uno per l’altro” (VIII, 59); e ognuno è membro dell’unico sistema dell’universo, nel quale “tutte le cose sono<br />
legate tra loro, ed è sacro vincolo, e quasi nessuna è estranea all’altra: ché sono coordinate e con<strong>cor</strong>renti a formare uno<br />
stesso mondo” (VII, 9). E’ dovere dell’uomo vivere con la divinità, uniformandosi all’ordine da essa stabilito. Così<br />
“vive con gli dèi chi continuamente mostra loro la sua anima contenta di quel che le tocca, che fa quel che vuole il<br />
demone che ad ognuno Giove ha dato come rettore e guida, emanante da lui: cioè l’intelletto e la ragione d’ognuno” (V,<br />
27). Gli stoici ripongono ogni valore positivo nella vita interiore, mentre considerano moralmente indifferenti<br />
(“adiaphora”) tutte quelle circostanze che non dipendono dalla disposizione interna del soggetto, ma appartengono alla<br />
natura o alla storia. Pertanto, il saggio non deve curarsi di ciò che accade nell’ambito <strong>della</strong> natura o che è un elemento<br />
<strong>della</strong> vita politica: “indifferenti” sono, infatti, la stessa salute o la malattia (in quanto accidenti relativi al <strong>cor</strong>po, che fa<br />
parte dell’esteriorità naturale, oppure la ricchezza e la povertà o la libertà e la schiavitù (in quanto connesse con la<br />
condizione sociale e con le circostanze esterne). Bene e male riguardano l’interiorità, cioè l’adesione o meno alla