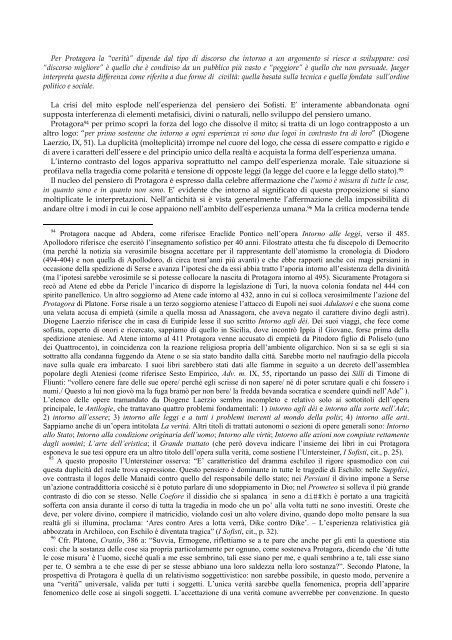Storia popolare della filosofia - prova-cor
Storia popolare della filosofia - prova-cor
Storia popolare della filosofia - prova-cor
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Per Protagora la “verità” dipende dal tipo di dis<strong>cor</strong>so che intorno a un argomento si riesce a sviluppare: così<br />
“dis<strong>cor</strong>so migliore” è quello che è condiviso da un pubblico più vasto e “peggiore” è quello che non persuade. Jaeger<br />
interpreta questa differenza come riferita a due forme di civiltà: quella basata sulla tecnica e quella fondata sull’ordine<br />
politico e sociale.<br />
La crisi del mito esplode nell’esperienza del pensiero dei Sofisti. E’ interamente abbandonata ogni<br />
supposta interferenza di elementi metafisici, divini o naturali, nello sviluppo del pensiero umano.<br />
Protagora 94 per primo scoprì la forza del logo che dissolve il mito; si tratta di un logo contrapposto a un<br />
altro logo: “per primo sostenne che intorno a ogni esperienza vi sono due logoi in contrasto tra di loro” (Diogene<br />
Laerzio, IX, 51). La duplicità (molteplicità) irrompe nel cuore del logo, che cessa di essere compatto e rigido e<br />
di avere i caratteri dell’essere e del principio unico <strong>della</strong> realtà e acquista la forma dell’esperienza umana.<br />
L’interno contrasto del logos appariva soprattutto nel campo dell’esperienza morale. Tale situazione si<br />
profilava nella tragedia come polarità e tensione di opposte leggi (la legge del cuore e la legge dello stato). 95<br />
Il nucleo del pensiero di Protagora è espresso dalla celebre affermazione che l’uomo è misura di tutte le cose,<br />
in quanto sono e in quanto non sono. E’ evidente che intorno al significato di questa proposizione si siano<br />
moltiplicate le interpretazioni. Nell’antichità si è vista generalmente l’affermazione <strong>della</strong> impossibilità di<br />
andare oltre i modi in cui le cose appaiono nell’ambito dell’esperienza umana. 96 Ma la critica moderna tende<br />
94 Protagora nacque ad Abdera, come riferisce Eraclide Pontico nell’opera Intorno alle leggi, verso il 485.<br />
Apollodoro riferisce che esercitò l’insegnamento sofistico per 40 anni. Filostrato attesta che fu discepolo di Democrito<br />
(ma perché la notizia sia verosimile bisogna accettare per il rappresentante dell’atomismo la cronologia di Diodoro<br />
(494-404) e non quella di Apollodoro, di circa trent’anni più avanti) e che ebbe rapporti anche coi magi persiani in<br />
occasione <strong>della</strong> spedizione di Serse e avanza l’ipotesi che da essi abbia tratto l’aporia intorno all’esistenza <strong>della</strong> divinità<br />
(ma l’ipotesi sarebbe verosimile se si potesse collocare la nascita di Protagora intorno al 495). Sicuramente Protagora si<br />
recò ad Atene ed ebbe da Pericle l’incarico di disporre la legislazione di Turi, la nuova colonia fondata nel 444 con<br />
spirito panellenico. Un altro soggiorno ad Atene cade intorno al 432, anno in cui si colloca verosimilmente l’azione del<br />
Protagora di Platone. Forse risale a un terzo soggiorno ateniese l’attacco di Eupoli nei suoi Adulatori e che suona come<br />
una velata accusa di empietà (simile a quella mossa ad Anassagora, che aveva negato il carattere divino degli astri).<br />
Diogene Laerzio riferisce che in casa di Euripide lesse il suo scritto Intorno agli dèi. Dei suoi viaggi, che fece come<br />
sofista, coperto di onori e ricercato, sappiamo di quello in Sicilia, dove incontrò Ippia il Giovane, forse prima <strong>della</strong><br />
spedizione ateniese. Ad Atene intorno al 411 Protagora venne accusato di empietà da Pitodoro figlio di Poliselo (uno<br />
dei Quattrocento), in coincidenza con la reazione religiosa propria dell’ambiente oligarchico. Non si sa se egli si sia<br />
sottratto alla condanna fuggendo da Atene o se sia stato bandito dalla città. Sarebbe morto nel naufragio <strong>della</strong> piccola<br />
nave sulla quale era imbarcato. I suoi libri sarebbero stati dati alle fiamme in seguito a un decreto dell’assemblea<br />
<strong>popolare</strong> degli Ateniesi (come riferisce Sesto Empirico, Adv. m. IX, 55, riportando un passo dei Silli di Timone di<br />
Fliunti: “vollero cenere fare delle sue opere/ perché egli scrisse di non sapere/ né di poter scrutare quali e chi fossero i<br />
numi./ Questo a lui non giovò ma la fuga bramò per non bere/ la fredda bevanda socratica e scendere quindi nell’Ade” ).<br />
L’elenco delle opere tramandato da Diogene Laerzio sembra incompleto e relativo solo ai sottotitoli dell’opera<br />
principale, le Antilogie, che trattavano quattro problemi fondamentali: 1) intorno agli dèi e intorno alla sorte nell’Ade;<br />
2) intorno all’essere; 3) intorno alle leggi e a tutti i problemi inerenti al mondo <strong>della</strong> polis; 4) intorno alle arti.<br />
Sappiamo anche di un’opera intitolata La verità. Altri titoli di trattati autonomi o sezioni di opere generali sono: Intorno<br />
allo Stato; Intorno alla condizione originaria dell’uomo; Intorno alle virtù; Intorno alle azioni non compiute rettamente<br />
dagli uomini; L’arte dell’eristica; il Grande trattato (che però doveva indicare l’insieme dei libri in cui Protagora<br />
esponeva le sue tesi oppure era un altro titolo dell’opera sulla verità, come sostiene l’Untersteiner, I Sofisti, cit., p. 25).<br />
95 A questo proposito l’Untersteiner osserva: “E’ caratteristico del dramma eschileo il rigore spasmodico con cui<br />
questa duplicità del reale trova espressione. Questo pensiero è dominante in tutte le tragedie di Eschilo: nelle Supplici,<br />
ove contrasta il logos delle Manaidi contro quello del responsabile dello stato; nei Persiani il divino impone a Serse<br />
un’azione contraddittoria cosicché si è potuto parlare di uno sdoppiamento in Dio; nel Prometeo si solleva il più grande<br />
contrasto di dio con se stesso. Nelle Coefore il dissidio che si spalanca in seno a di##kh è portato a una tragicità<br />
sofferta con ansia durante il <strong>cor</strong>so di tutta la tragedia in modo che un po’ alla volta tutti ne sono investiti. Oreste che<br />
deve, per volere divino, compiere il matricidio, violando così un alto volere divino, quando dopo molto pensare la sua<br />
realtà gli si illumina, proclama: ‘Ares contro Ares a lotta verrà, Dike contro Dike’. – L’esperienza relativistica già<br />
abbozzata in Archiloco, con Eschilo è diventata tragica” (I Sofisti, cit., p. 32).<br />
96 Cfr. Platone, Cratilo, 386 a: “Suvvia, Ermogene, riflettiamo se a te pare che anche per gli enti la questione stia<br />
così: che la sostanza delle cose sia propria particolarmente per ognuno, come sosteneva Protagora, dicendo che ‘di tutte<br />
le cose misura’ è l’uomo, sicché quali a me esse sembrino, tali esse siano per me, e quali sembrino a te, tali esse siano<br />
per te. O sembra a te che esse di per se stesse abbiano una loro saldezza nella loro sostanza?”. Secondo Platone, la<br />
prospettiva di Protagora è quella di un relativismo soggettivistico: non sarebbe possibile, in questo modo, pervenire a<br />
una “verità” universale, valida per tutti i soggetti. L’unica verità sarebbe quella fenomenica, propria dell’apparire<br />
fenomenico delle cose ai singoli soggetti. L’accettazione di una verità comune avverrebbe per convenzione. In questo