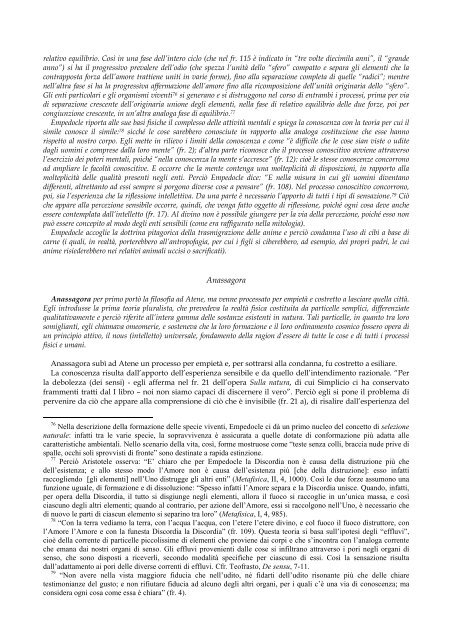Storia popolare della filosofia - prova-cor
Storia popolare della filosofia - prova-cor
Storia popolare della filosofia - prova-cor
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
elativo equilibrio. Così in una fase dell’intero ciclo (che nel fr. 115 è indicato in “tre volte diecimila anni”, il “grande<br />
anno”) si ha il progressivo prevalere dell’odio (che spezza l’unità dello “sfero” compatto e separa gli elementi che la<br />
contrapposta forza dell’amore trattiene uniti in varie forme), fino alla separazione completa di quelle “radici”; mentre<br />
nell’altra fase si ha la progressiva affermazione dell’amore fino alla ricomposizione dell’unità originaria dello “sfero”.<br />
Gli enti particolari e gli organismi viventi 76 si generano e si distruggono nel <strong>cor</strong>so di entrambi i processi, prima per via<br />
di separazione crescente dell’originaria unione degli elementi, nella fase di relativo equilibrio delle due forze, poi per<br />
congiunzione crescente, in un’altra analoga fase di equilibrio. 77<br />
Empedocle riporta alle sue basi fisiche il complesso delle attività mentali e spiega la conoscenza con la teoria per cui il<br />
simile conosce il simile: 78 sicché le cose sarebbero conosciute in rapporto alla analoga costituzione che esse hanno<br />
rispetto al nostro <strong>cor</strong>po. Egli mette in rilievo i limiti <strong>della</strong> conoscenza e come “è difficile che le cose sian viste o udite<br />
dagli uomini e comprese dalla loro mente” (fr. 2); d’altra parte riconosce che il processo conoscitivo avviene attraverso<br />
l’esercizio dei poteri mentali, poiché “nella conoscenza la mente s’accresce” (fr. 12): cioè le stesse conoscenze con<strong>cor</strong>rono<br />
ad ampliare le facoltà conoscitive. E oc<strong>cor</strong>re che la mente contenga una molteplicità di disposizioni, in rapporto alla<br />
molteplicità delle qualità presenti negli enti. Perciò Empedocle dice: “E nella misura in cui gli uomini diventano<br />
differenti, altrettanto ad essi sempre si porgono diverse cose a pensare” (fr. 108). Nel processo conoscitivo con<strong>cor</strong>rono,<br />
poi, sia l’esperienza che la riflessione intellettiva. Da una parte è necessario l’apporto di tutti i tipi di sensazione. 79 Ciò<br />
che appare alla percezione sensibile oc<strong>cor</strong>re, quindi, che venga fatto oggetto di riflessione, poiché ogni cosa deve anche<br />
essere contemplata dall’intelletto (fr. 17). Al divino non è possibile giungere per la via <strong>della</strong> percezione, poiché esso non<br />
può essere concepito al modo degli enti sensibili (come era raffigurato nella mitologia).<br />
Empedocle accoglie la dottrina pitagorica <strong>della</strong> trasmigrazione delle anime e perciò condanna l’uso di cibi a base di<br />
carne (i quali, in realtà, porterebbero all’antropofagia, per cui i figli si ciberebbero, ad esempio, dei propri padri, le cui<br />
anime risiederebbero nei relativi animali uccisi o sacrificati).<br />
Anassagora<br />
Anassagora per primo portò la <strong>filosofia</strong> ad Atene, ma venne processato per empietà e costretto a lasciare quella città.<br />
Egli introdusse la prima teoria pluralista, che prevedeva la realtà fisica costituita da particelle semplici, differenziate<br />
qualitativamente e perciò riferite all’intera gamma delle sostanze esistenti in natura. Tali particelle, in quanto tra loro<br />
somiglianti, egli chiamava omeomerie, e sosteneva che la loro formazione e il loro ordinamento cosmico fossero opera di<br />
un principio attivo, il nous (intelletto) universale, fondamento <strong>della</strong> ragion d’essere di tutte le cose e di tutti i processi<br />
fisici e umani.<br />
Anassagora subì ad Atene un processo per empietà e, per sottrarsi alla condanna, fu costretto a esiliare.<br />
La conoscenza risulta dall’apporto dell’esperienza sensibile e da quello dell’intendimento razionale. “Per<br />
la debolezza (dei sensi) - egli afferma nel fr. 21 dell’opera Sulla natura, di cui Simplicio ci ha conservato<br />
frammenti tratti dal I libro – noi non siamo capaci di discernere il vero”. Perciò egli si pone il problema di<br />
pervenire da ciò che appare alla comprensione di ciò che è invisibile (fr. 21 a), di risalire dall’esperienza del<br />
76 Nella descrizione <strong>della</strong> formazione delle specie viventi, Empedocle ci dà un primo nucleo del concetto di selezione<br />
naturale: infatti tra le varie specie, la sopravvivenza è assicurata a quelle dotate di conformazione più adatta alle<br />
caratteristiche ambientali. Nello scenario <strong>della</strong> vita, così, forme mostruose come “teste senza colli, braccia nude prive di<br />
spalle, occhi soli sprovvisti di fronte” sono destinate a rapida estinzione.<br />
77 Perciò Aristotele osserva: “E’ chiaro che per Empedocle la Dis<strong>cor</strong>dia non è causa <strong>della</strong> distruzione più che<br />
dell’esistenza; e allo stesso modo l’Amore non è causa dell’esistenza più [che <strong>della</strong> distruzione]: esso infatti<br />
raccogliendo [gli elementi] nell’Uno distrugge gli altri enti” (Metafisica, II, 4, 1000). Così le due forze assumono una<br />
funzione uguale, di formazione e di dissoluzione: “Spesso infatti l’Amore separa e la Dis<strong>cor</strong>dia unisce. Quando, infatti,<br />
per opera <strong>della</strong> Dis<strong>cor</strong>dia, il tutto si disgiunge negli elementi, allora il fuoco si raccoglie in un’unica massa, e così<br />
ciascuno degli altri elementi; quando al contrario, per azione dell’Amore, essi si raccolgono nell’Uno, è necessario che<br />
di nuovo le parti di ciascun elemento si separino tra loro” (Metafisica, I, 4, 985).<br />
78 “Con la terra vediamo la terra, con l’acqua l’acqua, con l’etere l’etere divino, e col fuoco il fuoco distruttore, con<br />
l’Amore l’Amore e con la funesta Dis<strong>cor</strong>dia la Dis<strong>cor</strong>dia” (fr. 109). Questa teoria si basa sull’ipotesi degli “effluvi”,<br />
cioè <strong>della</strong> <strong>cor</strong>rente di particelle piccolissime di elementi che proviene dai <strong>cor</strong>pi e che s’incontra con l’analoga <strong>cor</strong>rente<br />
che emana dai nostri organi di senso. Gli effluvi provenienti dalle cose si infiltrano attraverso i pori negli organi di<br />
senso, che sono disposti a riceverli, secondo modalità specifiche per ciascuno di essi. Così la sensazione risulta<br />
dall’adattamento ai pori delle diverse <strong>cor</strong>renti di effluvi. Cfr. Teofrasto, De sensu, 7-11.<br />
79 “Non avere nella vista maggiore fiducia che nell’udito, né fidarti dell’udito risonante più che delle chiare<br />
testimonianze del gusto; e non rifiutare fiducia ad alcuno degli altri organi, per i quali c’è una via di conoscenza; ma<br />
considera ogni cosa come essa è chiara” (fr. 4).