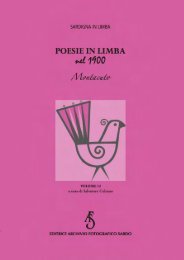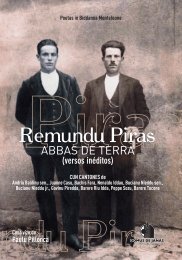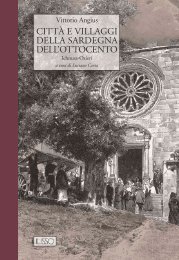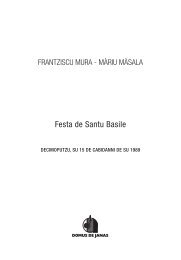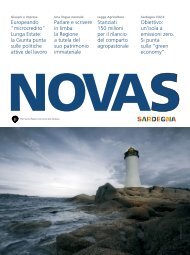versione pdf - Sardegna DigitalLibrary
versione pdf - Sardegna DigitalLibrary
versione pdf - Sardegna DigitalLibrary
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
STRATEGIE IRRIGUE INNOVATIVE PIù IDONEE<br />
PER L’IRRIGAZIONE A MICROPORTATA.<br />
LO STRESS IDRICO CONTROLLATO (RDI)<br />
La gestione dell’irrigazione in regime di stress idrico controllato<br />
(RDI) consente di modulare il comportamento vegetoproduttivo<br />
della vite, intervenendo sugli equilibri fisiologici e<br />
influenzando le caratteristiche dell’uva prodotta.<br />
Questa strategia prevede un reintegro irriguo deficitario nelle<br />
fasi fenologiche meno sensibili allo stress idrico, ovvero dallo<br />
sviluppo degli acini fino all’invaiatura e dall’invaiatura alla<br />
maturazione. Infatti, la carenza idrica in queste fasi determina<br />
un calo produttivo moderato, ma compensato da un miglioramento<br />
qualitativo delle uve.<br />
Al contrario, nelle fasi più sensibili, quali sviluppo vegetativo<br />
(dal germogliamento all’allegagione), fioritura e allegagione,<br />
la coltura deve essere mantenuta in condizioni idriche ottimali,<br />
per evitare cali di produzione eccessivi.<br />
Tabella 8. Effetti dei livelli di stress idrico. (modificato da Deloire et al., 2005).<br />
Per la corretta ed efficace applicazione dello stress idrico controllato<br />
occorre conoscere le esigenze della pianta nelle diverse<br />
fasi fenologiche e gli effetti dello stress idrico, a varie<br />
intensità, sugli aspetti vegeto-produttivi e qualitativi.<br />
Per il pieno raggiungimento degli obiettivi colturali ed economici,<br />
è quì ancor più importante la corretta determinazione<br />
dei consumi idrici e dei volumi, tempi e modi di restituzione,<br />
nonché la piena funzionalità e razionale gestione dell’impianto<br />
irriguo. La strategia dello stress idrico controllato si serve,<br />
quindi, di una situazione idrica non ottimale per la pianta per<br />
controllarne lo sviluppo vegetativo, da una parte, e la fase produttiva<br />
dall’altra. Si devono distinguere pertanto due tipologie<br />
di intervento, a seconda che l’epoca di induzione dello stress<br />
idrico sia precoce o tardiva (Tab. 8).<br />
Livelli di stress idrico Attività vegetativa Crescita dell’acino Fotosintesi Maturazione<br />
Assenza di stress Stimolata Stimolata Stimolata Sfavorita<br />
Stress moderato Ridotta da Normale a Ridotta da Normale a Ridotta Favorita<br />
Stress elevato Fortemente ridotta Fortemente ridotta da Fortemente ridotta a<br />
Bloccata<br />
Esistono diverse possibilità applicative dello stress idrico controllato,<br />
in relazione alle caratteristiche varietali e agli obiettivi<br />
enologici da ottenere<br />
Nelle varietà a bacca rossa, ad esempio, uno stress idrico più<br />
accentuato dovrebbe essere indotto durante lo sviluppo dell’acino,<br />
per ridurne il suo accrescimento a favore del rapporto<br />
buccia/polpa.<br />
Uno stress idrico più moderato, invece, è necessario dopo l’invaiatura,<br />
per assicurare minime competizioni tra gli acini in<br />
maturazione e i germogli in accrescimento vegetativo.<br />
Altri casi applicativi dello stress idrico controllato possono<br />
prevedere: il reintegro ottimale prima dell’allegagione e<br />
dall’allegagione all’invaiatura, contro una riduzione dell’apporto<br />
irriguo dall’invaiatura alla maturazione; oppure, di garantire<br />
il massimo fabbisogno idrico fino all’allegagione e indurre<br />
Sfavorita<br />
stress idrici moderati fino all’invaiatura, seguiti da stress idrici<br />
più intensi fino alla maturazione.<br />
Proprio quest’ultima strategia di stress idrico controllato (RDI)<br />
è stata sperimentata su Vermentino, nell’areale del Parteolla<br />
nel corso del progetto SQFVS.<br />
Sono state messe a confronto due modalità di intervento, differenziate<br />
a partire dalla fase di allegagione (la totale fornitura<br />
fino a questa fase, peraltro, è stata generalmente garantita<br />
dalla pioggia): la tesi A prevedeva sempre un volume irriguo<br />
doppio (sia pure sempre deficitario) rispetto alla tesi B, a parità<br />
di turno irriguo e con sistema di distribuzione per subirrigazione.<br />
I livelli di restituzione adottati nelle diverse fasi ed i volumi<br />
stagionali erogati per le due tesi sono stati sintetizzati nella<br />
successiva tabella 9.<br />
175