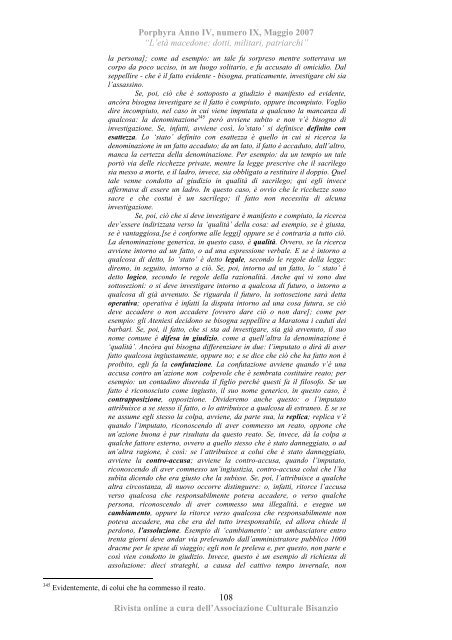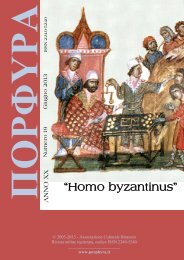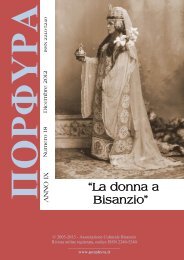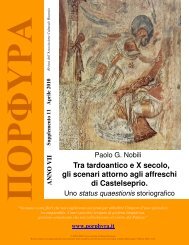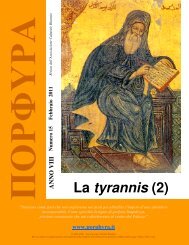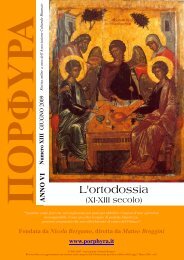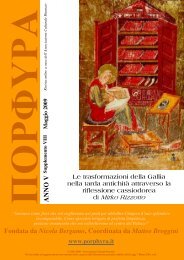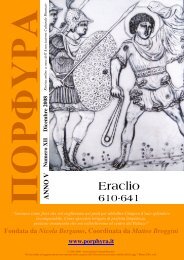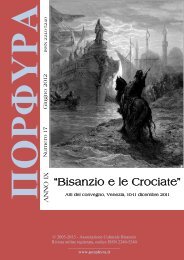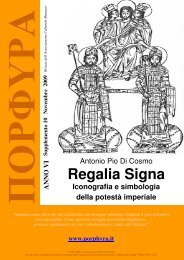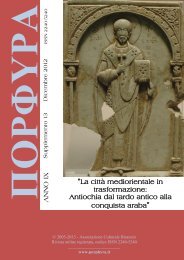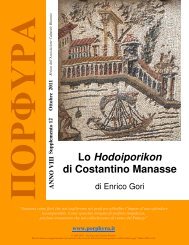Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Porphyra</strong> Anno IV, numero IX, Maggio 2007<br />
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi”<br />
la persona]; come ad esempio: un tale fu sorpreso mentre sotterrava un<br />
corpo da poco ucciso, in un luogo solitario, e fu accusato di omicidio. Dal<br />
seppellire - che è il fatto evidente - bisogna, praticamente, investigare chi sia<br />
l’assassino.<br />
Se, poi, ciò che è sottoposto a giudizio è manifesto ed evidente,<br />
ancòra bisogna investigare se il fatto è compiuto, oppure incompiuto. Voglio<br />
dire incompiuto, nel caso in cui viene imputata a qualcuno la mancanza di<br />
qualcosa: la denominazione 345 però avviene subito e non v’è bisogno di<br />
investigazione. Se, infatti, avviene così, lo’stato’ si definisce definito con<br />
esattezza. Lo ‘stato’ definito con esattezza è quello in cui si ricerca la<br />
denominazione in un fatto accaduto; da un lato, il fatto è accaduto, dall’altro,<br />
manca la certezza della denominazione. Per esempio: da un tempio un tale<br />
portò via delle ricchezze private, mentre la legge prescrive che il sacrìlego<br />
sia messo a morte, e il ladro, invece, sia obbligato a restituire il doppio. Quel<br />
tale venne condotto al giudizio in qualità di sacrilego; qui egli invece<br />
affermava di essere un ladro. In questo caso, è ovvio che le ricchezze sono<br />
sacre e che costui è un sacrilego; il fatto non necessita di alcuna<br />
investigazione.<br />
Se, poi, ciò che si deve investigare è manifesto e compiuto, la ricerca<br />
dev’essere indirizzata verso la ‘qualità’ della cosa: ad esempio, se è giusta,<br />
se è vantaggiosa,[se è conforme alle leggi] oppure se è contraria a tutto ciò.<br />
La denominazione generica, in questo caso, è qualità. Ovvero, se la ricerca<br />
avviene intorno ad un fatto, o ad una espressione verbale. E se è intorno a<br />
qualcosa di detto, lo ‘stato’ è detto legale, secondo le regole della legge:<br />
diremo, in seguito, intorno a ciò. Se, poi, intorno ad un fatto, lo ‘ stato’ è<br />
detto logico, secondo le regole della razionalità. Anche qui vi sono due<br />
sottosezioni: o si deve investigare intorno a qualcosa di futuro, o intorno a<br />
qualcosa di già avvenuto. Se riguarda il futuro, la sottosezione sarà detta<br />
operativa; operativa è infatti la disputa intorno ad una cosa futura, se ciò<br />
deve accadere o non accadere [ovvero dare ciò o non dare]; come per<br />
esempio: gli Ateniesi decidono se bisogna seppellire a Maratona i caduti dei<br />
barbari. Se, poi, il fatto, che si sta ad investigare, sia già avvenuto, il suo<br />
nome comune è difesa in giudizio, come a quell’altra la denominazione è<br />
‘qualità’. Ancòra qui bisogna differenziare in due: l’imputato o dirà di aver<br />
fatto qualcosa ingiustamente, oppure no; e se dice che ciò che ha fatto non è<br />
proibito, egli fa la confutazione. La confutazione avviene quando v’è una<br />
accusa contro un’azione non colpevole che è sembrata costituire reato; per<br />
esempio: un contadino disereda il figlio perché questi fa il filosofo. Se un<br />
fatto è riconosciuto come ingiusto, il suo nome generico, in questo caso, è<br />
contrapposizione, opposizione. Divideremo anche questo: o l’imputato<br />
attribuisce a se stesso il fatto, o lo attribuisce a qualcosa di estraneo. E se se<br />
ne assume egli stesso la colpa, avviene, da parte sua, la replica; replica v’è<br />
quando l’imputato, riconoscendo di aver commesso un reato, oppone che<br />
un’azione buona è pur risultata da questo reato. Se, invece, dà la colpa a<br />
qualche fattore esterno, ovvero a quello stesso che è stato danneggiato, o ad<br />
un’altra ragione, è così: se l’attribuisce a colui che è stato danneggiato,<br />
avviene la contro-accusa; avviene la contro-accusa, quando l’imputato,<br />
riconoscendo di aver commesso un’ingiustizia, contro-accusa colui che l’ha<br />
subìta dicendo che era giusto che la subisse. Se, poi, l’attribuisce a qualche<br />
altra circostanza, di nuovo occorre distinguere: o, infatti, ritorce l’accusa<br />
verso qualcosa che responsabilmente poteva accadere, o verso qualche<br />
persona, riconoscendo di aver commesso una illegalità, e esegue un<br />
cambiamento, oppure la ritorce verso qualcosa che responsabilmente non<br />
poteva accadere, ma che era del tutto irresponsabile, ed allora chiede il<br />
perdono, l’assoluzione. Esempio di ‘cambiamento’: un ambasciatore entro<br />
trenta giorni deve andar via prelevando dall’amministratore pubblico 1000<br />
dracme per le spese di viaggio; egli non le preleva e, per questo, non parte e<br />
così vien condotto in giudizio. Invece, questo è un esempio di richiesta di<br />
assoluzione: dieci strateghi, a causa del cattivo tempo invernale, non<br />
345 Evidentemente, di colui che ha commesso il reato.<br />
108<br />
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio