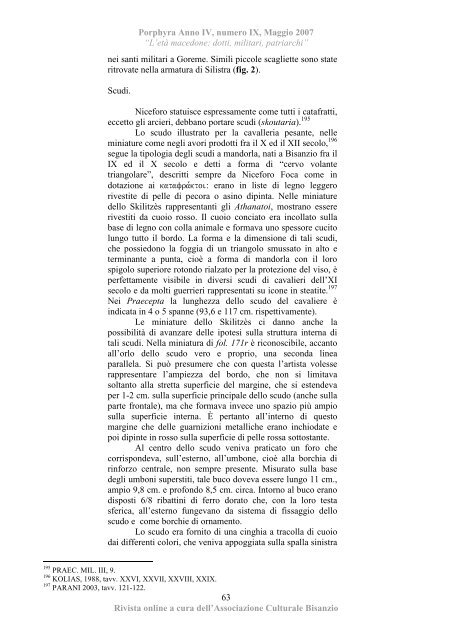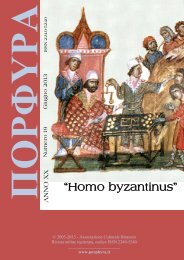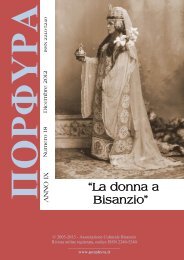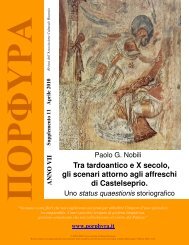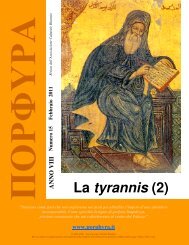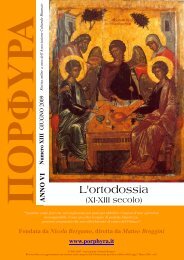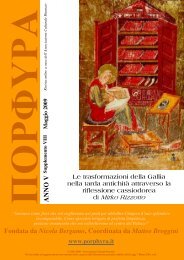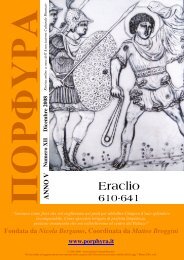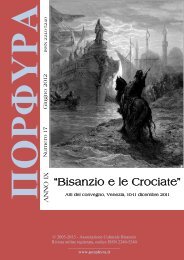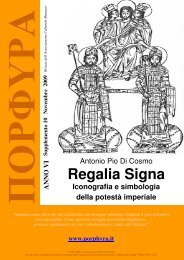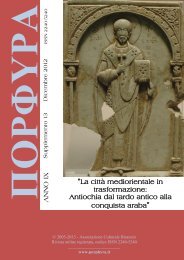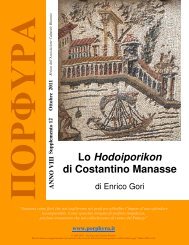Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Porphyra</strong> Anno IV, numero IX, Maggio 2007<br />
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi”<br />
nei santi militari a Goreme. Simili piccole scagliette sono state<br />
ritrovate nella armatura di Silistra (fig. 2).<br />
Scudi.<br />
Niceforo statuisce espressamente come tutti i catafratti,<br />
eccetto gli arcieri, debbano portare scudi (skoutaria). 195<br />
Lo scudo illustrato per la cavalleria pesante, nelle<br />
miniature come negli avori prodotti fra il X ed il XII secolo, 196<br />
segue la tipologia degli scudi a mandorla, nati a Bisanzio fra il<br />
IX ed il X secolo e detti a forma di “cervo volante<br />
triangolare”, descritti sempre da Niceforo Foca come in<br />
dotazione ai katafra,ktoi: erano in liste di legno leggero<br />
rivestite di pelle di pecora o asino dipinta. Nelle miniature<br />
dello Skilitzès rappresentanti gli Athanatoi, mostrano essere<br />
rivestiti da cuoio rosso. Il cuoio conciato era incollato sulla<br />
base di legno con colla animale e formava uno spessore cucito<br />
lungo tutto il bordo. La forma e la dimensione di tali scudi,<br />
che possiedono la foggia di un triangolo smussato in alto e<br />
terminante a punta, cioè a forma di mandorla con il loro<br />
spigolo superiore rotondo rialzato per la protezione del viso, è<br />
perfettamente visibile in diversi scudi di cavalieri dell’XI<br />
secolo e da molti guerrieri rappresentati su icone in steatite. 197<br />
Nei Praecepta la lunghezza dello scudo del cavaliere è<br />
indicata in 4 o 5 spanne (93,6 e 117 cm. rispettivamente).<br />
Le miniature dello Skilitzès ci danno anche la<br />
possibilità di avanzare delle ipotesi sulla struttura interna di<br />
tali scudi. Nella miniatura di fol. 171r è riconoscibile, accanto<br />
all’orlo dello scudo vero e proprio, una seconda linea<br />
parallela. Si può presumere che con questa l’artista volesse<br />
rappresentare l’ampiezza del bordo, che non si limitava<br />
soltanto alla stretta superficie del margine, che si estendeva<br />
per 1-2 cm. sulla superficie principale dello scudo (anche sulla<br />
parte frontale), ma che formava invece uno spazio più ampio<br />
sulla superficie interna. È pertanto all’interno di questo<br />
margine che delle guarnizioni metalliche erano inchiodate e<br />
poi dipinte in rosso sulla superficie di pelle rossa sottostante.<br />
Al centro dello scudo veniva praticato un foro che<br />
corrispondeva, sull’esterno, all’umbone, cioè alla borchia di<br />
rinforzo centrale, non sempre presente. Misurato sulla base<br />
degli umboni superstiti, tale buco doveva essere lungo 11 cm.,<br />
ampio 9,8 cm. e profondo 8,5 cm. circa. Intorno al buco erano<br />
disposti 6/8 ribattini di ferro dorato che, con la loro testa<br />
sferica, all’esterno fungevano da sistema di fissaggio dello<br />
scudo e come borchie di ornamento.<br />
Lo scudo era fornito di una cinghia a tracolla di cuoio<br />
dai differenti colori, che veniva appoggiata sulla spalla sinistra<br />
195 PRAEC. MIL. III, 9.<br />
196 KOLIAS, 1988, tavv. XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX.<br />
197 PARANI 2003, tavv. 121-122.<br />
63<br />
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio