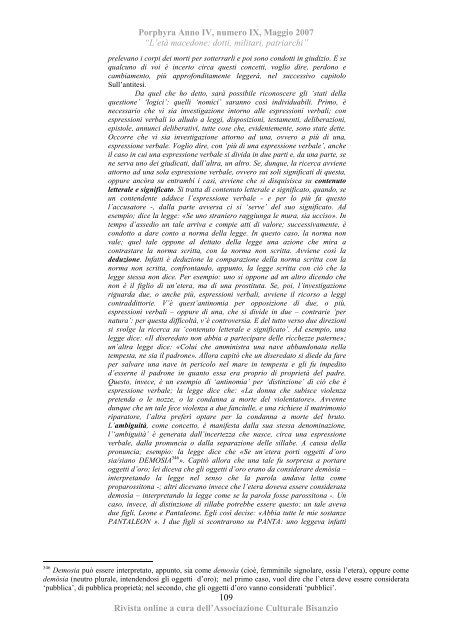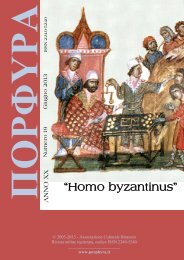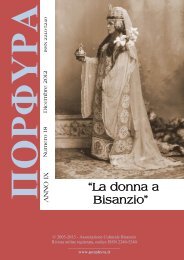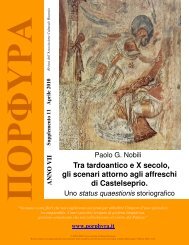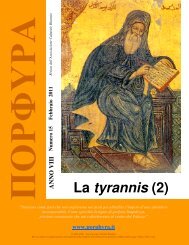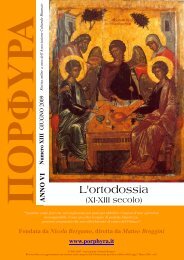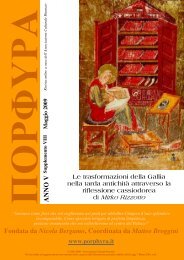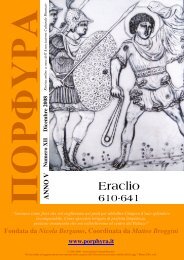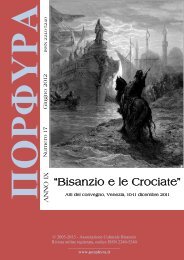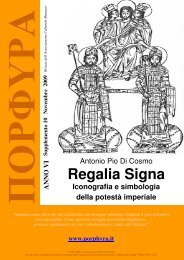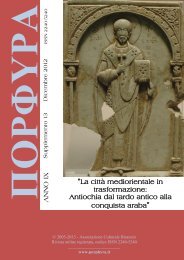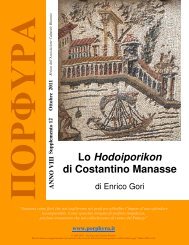You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Porphyra</strong> Anno IV, numero IX, Maggio 2007<br />
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi”<br />
prelevano i corpi dei morti per sotterrarli e poi sono condotti in giudizio. E se<br />
qualcuno di voi è incerto circa questi concetti, voglio dire, perdono e<br />
cambiamento, più approfonditamente leggerà, nel successivo capitolo<br />
Sull’antitesi.<br />
Da quel che ho detto, sarà possibile riconoscere gli ‘stati della<br />
questione’ ‘logici’: quelli ‘nomici’ saranno così individuabili. Primo, è<br />
necessario che vi sia investigazione intorno alle espressioni verbali; con<br />
espressioni verbali io alludo a leggi, disposizioni, testamenti, deliberazioni,<br />
epistole, annunci deliberativi, tutte cose che, evidentemente, sono state dette.<br />
Occorre che vi sia investigazione attorno ad una, ovvero a più di una,<br />
espressione verbale. Voglio dire, con ‘più di una espressione verbale’, anche<br />
il caso in cui una espressione verbale si divida in due parti e, da una parte, se<br />
ne serva uno dei giudicati, dall’altra, un altro. Se, dunque, la ricerca avviene<br />
attorno ad una sola espressione verbale, ovvero sui soli significati di questa,<br />
oppure ancòra su entrambi i casi, avviene che si disquisisca su contenuto<br />
letterale e significato. Si tratta di contenuto letterale e significato, quando, se<br />
un contendente adduce l’espressione verbale - e per lo più fa questo<br />
l’accusatore -, dalla parte avversa ci si ‘serve’ del suo significato. Ad<br />
esempio; dice la legge: «Se uno straniero raggiunga le mura, sia ucciso». In<br />
tempo d’assedio un tale arriva e compie atti di valore; successivamente, è<br />
condotto a dare conto a norma della legge. In questo caso, la norma non<br />
vale; quel tale oppone al dettato della legge una azione che mira a<br />
contrastare la norma scritta, con la norma non scritta. Avviene così la<br />
deduzione. Infatti è deduzione la comparazione della norma scritta con la<br />
norma non scritta, confrontando, appunto, la legge scritta con ciò che la<br />
legge stessa non dice. Per esempio: uno si oppone ad un altro dicendo che<br />
non è il figlio di un’etera, ma di una prostituta. Se, poi, l’investigazione<br />
riguarda due, o anche più, espressioni verbali, avviene il ricorso a leggi<br />
contraddittorie. V’è quest’antinomia per opposizione di due, o più,<br />
espressioni verbali – oppure di una, che si divide in due – contrarie ‘per<br />
natura’: per questa difficoltà, v’è controversia. E del tutto verso due direzioni<br />
si svolge la ricerca su ‘contenuto letterale e significato’. Ad esempio, una<br />
legge dice: «Il diseredato non abbia a partecipare delle ricchezze paterne»;<br />
un’altra legge dice: «Colui che amministra una nave abbandonata nella<br />
tempesta, ne sia il padrone». Allora capitò che un diseredato si diede da fare<br />
per salvare una nave in pericolo nel mare in tempesta e gli fu impedito<br />
d’esserne il padrone in quanto essa era proprio di proprietà del padre.<br />
Questo, invece, è un esempio di ‘antinomia’ per ‘distinzione’ di ciò che è<br />
espressione verbale; la legge dice che: «La donna che subisce violenza<br />
pretenda o le nozze, o la condanna a morte del violentatore». Avvenne<br />
dunque che un tale fece violenza a due fanciulle, e una richiese il matrimonio<br />
riparatore, l’altra preferì optare per la condanna a morte del bruto.<br />
L’ambiguità, come concetto, è manifesta dalla sua stessa denominazione,<br />
l’‘ambiguità’ è generata dall’incertezza che nasce, circa una espressione<br />
verbale, dalla pronuncia o dalla separazione delle sillabe. A causa della<br />
pronuncia; esempio: la legge dice che «Se un’etera porti oggetti d’oro<br />
sia/siano DEMOSIA 346 ». Capitò allora che una tale fu sorpresa a portare<br />
oggetti d’oro; lei diceva che gli oggetti d’oro erano da considerare demòsia –<br />
interpretando la legge nel senso che la parola andava letta come<br />
proparossitona -; altri dicevano invece che l’etera doveva essere considerata<br />
demosìa – interpretando la legge come se la parola fosse parossitona -. Un<br />
caso, invece, di distinzione di sillabe potrebbe essere questo: un tale aveva<br />
due figli, Leone e Pantaleone. Egli così decise: «Abbia tutte le mie sostanze<br />
PANTALEON ». I due figli si scontrarono su PANTA: uno leggeva infatti<br />
346<br />
Demosia può essere interpretato, appunto, sia come demosìa (cioè, femminile signolare, ossia l’etera), oppure come<br />
demòsia (neutro plurale, intendendosi gli oggetti d’oro); nel primo caso, vuol dire che l’etera deve essere considerata<br />
‘pubblica’, di pubblica proprietà; nel secondo, che gli oggetti d’oro vanno considerati ‘pubblici’.<br />
109<br />
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio