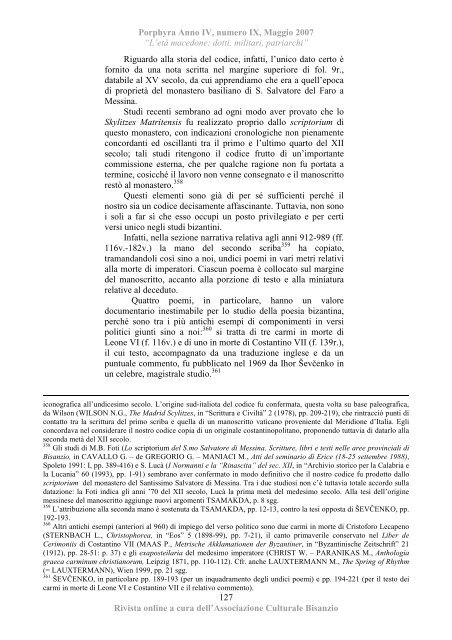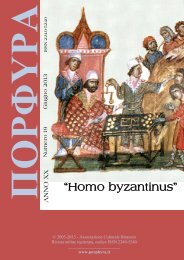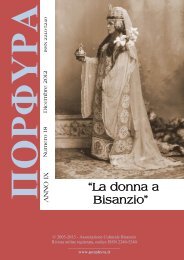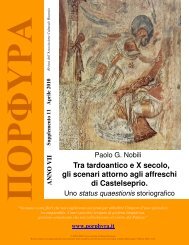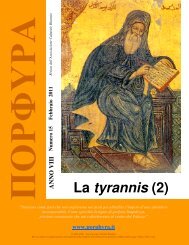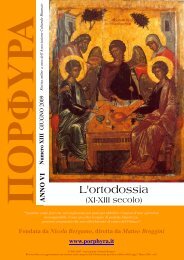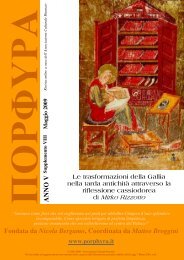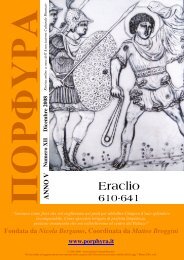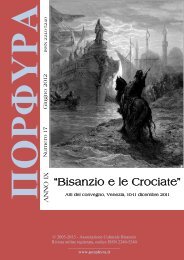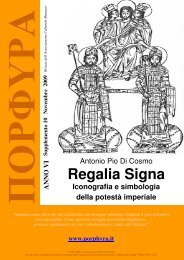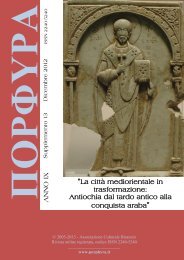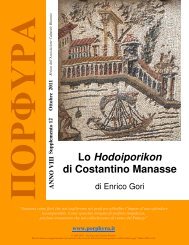Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Porphyra</strong> Anno IV, numero IX, Maggio 2007<br />
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi”<br />
Riguardo alla storia del codice, infatti, l’unico dato certo è<br />
fornito da una nota scritta nel margine superiore di fol. 9r.,<br />
databile al XV secolo, da cui apprendiamo che era a quell’epoca<br />
di proprietà del monastero basiliano di S. Salvatore del Faro a<br />
Messina.<br />
Studi recenti sembrano ad ogni modo aver provato che lo<br />
Skylitzes Matritensis fu realizzato proprio dallo scriptorium di<br />
questo monastero, con indicazioni cronologiche non pienamente<br />
concordanti ed oscillanti tra il primo e l’ultimo quarto del XII<br />
secolo; tali studi ritengono il codice frutto di un’importante<br />
commissione esterna, che per qualche ragione non fu portata a<br />
termine, cosicché il lavoro non venne consegnato e il manoscritto<br />
restò al monastero. 358<br />
Questi elementi sono già di per sé sufficienti perché il<br />
nostro sia un codice decisamente affascinante. Tuttavia, non sono<br />
i soli a far sì che esso occupi un posto privilegiato e per certi<br />
versi unico negli studi bizantini.<br />
Infatti, nella sezione narrativa relativa agli anni 912-989 (ff.<br />
116v.-182v.) la mano del secondo scriba 359 ha copiato,<br />
tramandandoli così sino a noi, undici poemi in vari metri relativi<br />
alla morte di imperatori. Ciascun poema è collocato sul margine<br />
del manoscritto, accanto alla porzione di testo e alla miniatura<br />
relative al deceduto.<br />
Quattro poemi, in particolare, hanno un valore<br />
documentario inestimabile per lo studio della poesia bizantina,<br />
perché sono tra i più antichi esempi di componimenti in versi<br />
politici giunti sino a noi: 360 si tratta di tre carmi in morte di<br />
Leone VI (f. 116v.) e di uno in morte di Costantino VII (f. 139r.),<br />
il cui testo, accompagnato da una traduzione inglese e da un<br />
puntuale commento, fu pubblicato nel 1969 da Ihor Ševčenko in<br />
un celebre, magistrale studio. 361<br />
iconografica all’undicesimo secolo. L’origine sud-italiota del codice fu confermata, questa volta su base paleografica,<br />
da Wilson (WILSON N.G., The Madrid Scylitzes, in “Scrittura e Civiltà” 2 (1978), pp. 209-219), che rintracciò punti di<br />
contatto tra la scrittura del primo scriba e quella di un manoscritto vaticano proveniente dal Meridione d’Italia. Egli<br />
concordava nel considerare il nostro codice copia di un originale costantinopolitano, proponendo tuttavia di datarlo alla<br />
seconda metà del XII secolo.<br />
358<br />
Gli studi di M.B. Foti (Lo scriptorium del S.mo Salvatore di Messina. Scritture, libri e testi nelle aree provinciali di<br />
Bisanzio, in CAVALLO G. – de GREGORIO G. – MANIACI M., Atti del seminario di Erice (18-25 settembre 1988),<br />
Spoleto 1991: I, pp. 389-416) e S. Lucà (I Normanni e la “Rinascita” del sec. XII, in “Archivio storico per la Calabria e<br />
la Lucania” 60 (1993), pp. 1-91) sembrano aver confermato in modo definitivo che il nostro codice fu prodotto dallo<br />
scriptorium del monastero del Santissimo Salvatore di Messina. Tra i due studiosi non c’è tuttavia totale accordo sulla<br />
datazione: la Foti indica gli anni ’70 del XII secolo, Lucà la prima metà del medesimo secolo. Alla tesi dell’origine<br />
messinese del manoscritto aggiunge nuovi argomenti TSAMAKDA, p. 8 sgg.<br />
359<br />
L’attribuzione alla seconda mano è sostenuta da TSAMAKDA, pp. 12-13, contro la tesi opposta di ŠEVČENKO, pp.<br />
192-193.<br />
360<br />
Altri antichi esempi (anteriori al 960) di impiego del verso politico sono due carmi in morte di Cristoforo Lecapeno<br />
(STERNBACH L., Christophorea, in “Eos” 5 (1898-99), pp. 7-21), il canto primaverile conservato nel Liber de<br />
Cerimoniis di Costantino VII (MAAS P., Metrische Akklamationen der Byzantiner, in “Byzantinische Zeitschrift” 21<br />
(1912), pp. 28-51: p. 37) e gli exaposteilaria del medesimo imperatore (CHRIST W. – PARANIKAS M., Anthologia<br />
graeca carminum christianorum, Leipzig 1871, pp. 110-112). Cfr. anche LAUXTERMANN M., The Spring of Rhythm<br />
(= LAUXTERMANN), Wien 1999, pp. 21 sgg.<br />
361<br />
ŠEVČENKO, in particolare pp. 189-193 (per un inquadramento degli undici poemi) e pp. 194-221 (per il testo dei<br />
carmi in morte di Leone VI e Costantino VII e il relativo commento).<br />
127<br />
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio