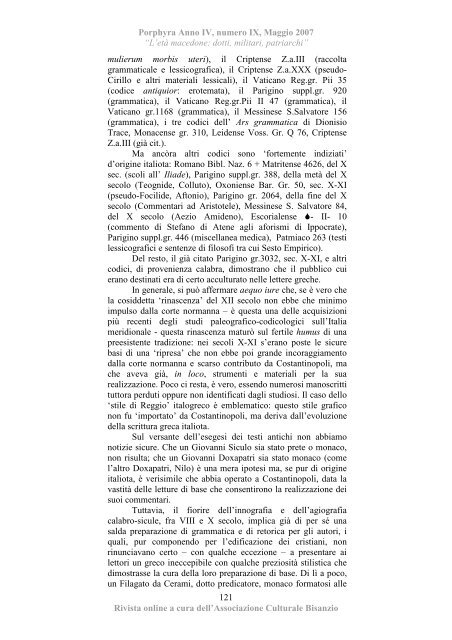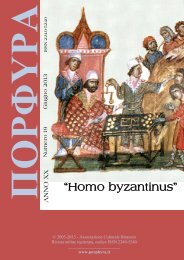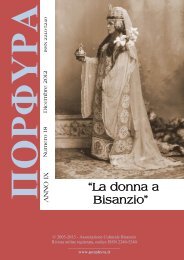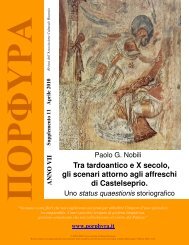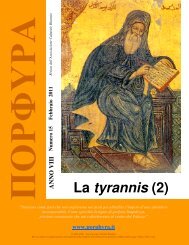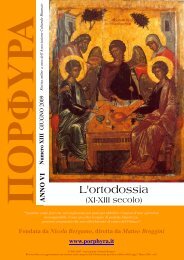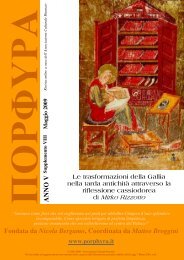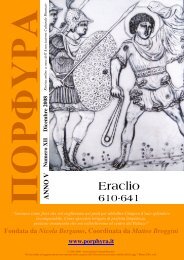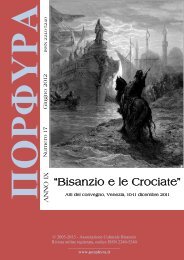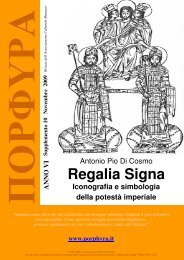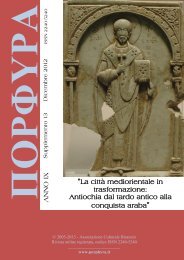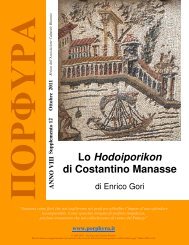Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Porphyra</strong> Anno IV, numero IX, Maggio 2007<br />
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi”<br />
mulierum morbis uteri), il Criptense Z.a.III (raccolta<br />
grammaticale e lessicografica), il Criptense Z.a.XXX (pseudo-<br />
Cirillo e altri materiali lessicali), il Vaticano Reg.gr. Pii 35<br />
(codice antiquior: erotemata), il Parigino suppl.gr. 920<br />
(grammatica), il Vaticano Reg.gr.Pii II 47 (grammatica), il<br />
Vaticano gr.1168 (grammatica), il Messinese S.Salvatore 156<br />
(grammatica), i tre codici dell’ Ars grammatica di Dionisio<br />
Trace, Monacense gr. 310, Leidense Voss. Gr. Q 76, Criptense<br />
Z.a.III (già cit.).<br />
Ma ancòra altri codici sono ‘fortemente indiziati’<br />
d’origine italiota: Romano Bibl. Naz. 6 + Matritense 4626, del X<br />
sec. (scoli all’ Iliade), Parigino suppl.gr. 388, della metà del X<br />
secolo (Teognide, Colluto), Oxoniense Bar. Gr. 50, sec. X-XI<br />
(pseudo-Focilide, Aftonio), Parigino gr. 2064, della fine del X<br />
secolo (Commentari ad Aristotele), Messinese S. Salvatore 84,<br />
del X secolo (Aezio Amideno), Escorialense - II- 10<br />
(commento di Stefano di Atene agli aforismi di Ippocrate),<br />
Parigino suppl.gr. 446 (miscellanea medica), Patmiaco 263 (testi<br />
lessicografici e sentenze di filosofi tra cui Sesto Empirico).<br />
Del resto, il già citato Parigino gr.3032, sec. X-XI, e altri<br />
codici, di provenienza calabra, dimostrano che il pubblico cui<br />
erano destinati era di certo acculturato nelle lettere greche.<br />
In generale, si può affermare aequo iure che, se è vero che<br />
la cosiddetta ‘rinascenza’ del XII secolo non ebbe che minimo<br />
impulso dalla corte normanna – è questa una delle acquisizioni<br />
più recenti degli studi paleografico-codicologici sull’Italia<br />
meridionale - questa rinascenza maturò sul fertile humus di una<br />
preesistente tradizione: nei secoli X-XI s’erano poste le sicure<br />
basi di una ‘ripresa’ che non ebbe poi grande incoraggiamento<br />
dalla corte normanna e scarso contributo da Costantinopoli, ma<br />
che aveva già, in loco, strumenti e materiali per la sua<br />
realizzazione. Poco ci resta, è vero, essendo numerosi manoscritti<br />
tuttora perduti oppure non identificati dagli studiosi. Il caso dello<br />
‘stile di Reggio’ italogreco è emblematico: questo stile grafico<br />
non fu ‘importato’ da Costantinopoli, ma deriva dall’evoluzione<br />
della scrittura greca italiota.<br />
Sul versante dell’esegesi dei testi antichi non abbiamo<br />
notizie sicure. Che un Giovanni Siculo sia stato prete o monaco,<br />
non risulta; che un Giovanni Doxapatri sia stato monaco (come<br />
l’altro Doxapatri, Nilo) è una mera ipotesi ma, se pur di origine<br />
italiota, è verisimile che abbia operato a Costantinopoli, data la<br />
vastità delle letture di base che consentirono la realizzazione dei<br />
suoi commentari.<br />
Tuttavia, il fiorire dell’innografia e dell’agiografia<br />
calabro-sicule, fra VIII e X secolo, implica già di per sé una<br />
salda preparazione di grammatica e di retorica per gli autori, i<br />
quali, pur componendo per l’edificazione dei cristiani, non<br />
rinunciavano certo – con qualche eccezione – a presentare ai<br />
lettori un greco ineccepibile con qualche preziosità stilistica che<br />
dimostrasse la cura della loro preparazione di base. Di lì a poco,<br />
un Filagato da Cerami, dotto predicatore, monaco formatosi alle<br />
121<br />
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio