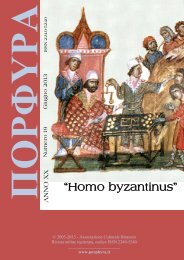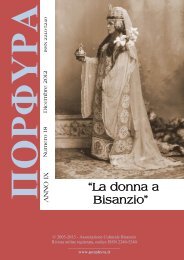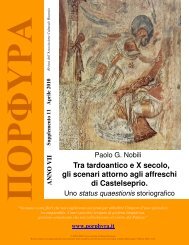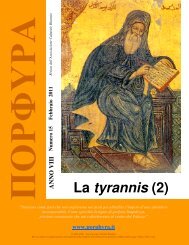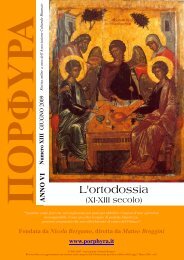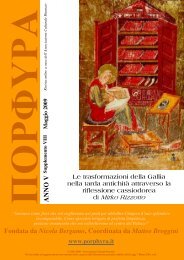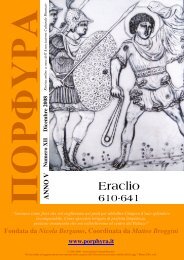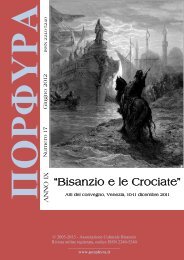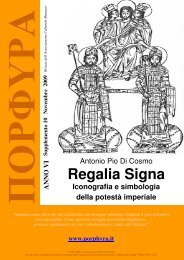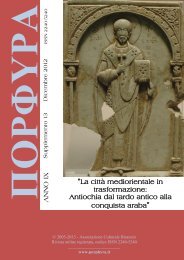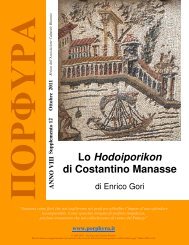You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Porphyra</strong> Anno IV, numero IX, Maggio 2007<br />
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi”<br />
lettere sacre e profane a Rossano, con le sue colte omelie avrebbe<br />
conferito ancòra maggior prestigio alla tradizione retorica<br />
italogreca.<br />
È proprio dal Parigino gr. 3032, miscellanea di testi<br />
retorici, alcuni dei quali attestati solo in questo codice, che<br />
può partire la riconsiderazione del p r o b l e m a<br />
d e l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e d i N i l o m o n a c o esegeta<br />
ermogeniano con quello di Rossano.<br />
È stato notato nel passato e poi accertato dallo scrivente<br />
con ulteriori approfondimenti come, nelle citazioni ermogeniane,<br />
le varianti testuali offerte dal Parigino gr. 3032 coincidano con<br />
quelle niliane: l’esegeta deve essersi servito di un codice assai<br />
‘vicino’, testualmente parlando, al Parigino gr. 3032.<br />
Sorprendenti analogie si riscontrano fra il commentario di Nilo<br />
monaco e quello di Cristoforo retore, che qualche studioso ha<br />
attribuito all’area italogreca. La generale ripresa della cultura<br />
dopo l’ ‘oscurantismo’ dell’età iconoclastica è riscontrabile<br />
anche in Italia meridionale, con un rinnovato interesse per i testi<br />
profani.<br />
Tutti questi motivi inducono a riflettere sull’intuizione di<br />
Gloeckner, che non va scartata, come hanno fatto taluni,<br />
considerandola del tutto ‘campata in aria’.<br />
Ancora un elemento orientativo: Nilo e Cristoforo, fra gli<br />
esegeti ermogeniani, hanno evidenziato, nel corso della loro<br />
trattazione, i loro nomi. Evidenziare il proprio nome è stato<br />
molto spesso una caratteristica del santo di Rossano. A<br />
prescindere dall’ Inno per san Nilo Sinaita, dove troviamo<br />
l’acrostico nominale, 353 e dal Canone per san Benedetto, dove lo<br />
stesso acrostico è presente nelle strofi in onore della Vergine<br />
(mariali), tale artificio retorico si rinviene anche in due carmi<br />
giambici del santo, i versi per san Paolo Apostolo (del Vaticano<br />
gr. 1971), e quelli per san Diadoco di Fotica (del Criptense B.a.<br />
XIX). Chi ha dimestichezza con l’epigramma, religioso o<br />
profano, in versi giambici sa che è affatto sporadico l’impiego di<br />
un acrostico nominale in tal genere letterario.<br />
Resterebbe da precisare l’epoca in cui presumibilmente il<br />
santo possa aver steso il commentario. In un primo tempo, avevo<br />
pensato al 950/960, al periodo di sant’Adriano, quando il santo,<br />
attorniato da discepoli che attendevano alla loro preparazione<br />
sacra e profana, aveva a disposizione una gran quantità di testi.<br />
Ora riterrei che la stesura sia da anticipare almeno al 940/950, al<br />
periodo del Merkurion, la ‘Tebaide italiana’ nella quale si<br />
profuse l’impegno del santo sotto la guida dei padri maestri.<br />
Il discorso potrebbe anche arrestarsi qui. Ma appare<br />
necessaria qualche ulteriore precisazione. Nel mondo bizantino<br />
non vi era separazione netta fra società ecclesiastica<br />
(e monastica) e società laica: esse costituivano un organismo<br />
353<br />
Nelle composizioni innografiche si soleva usare l’acrostico (o acrostichide), di due tipi: alfabetico (le lettere iniziali<br />
del primo verso di ciascuna strofe si susseguono, di strofe in strofe, secondo l’ordine alfabetico) o nominale (le iniziali<br />
si susseguono, sempre di strofe in strofe, in modo da formare una frase-chiave; spesso il nome dell’autore stesso).<br />
122<br />
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio