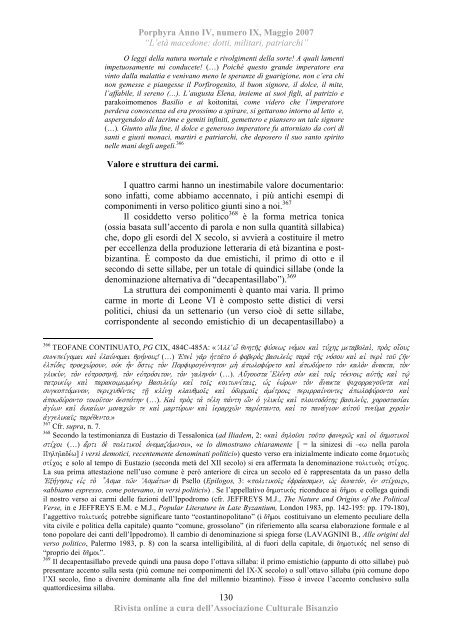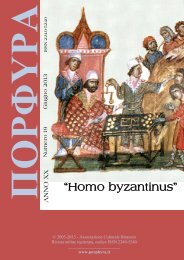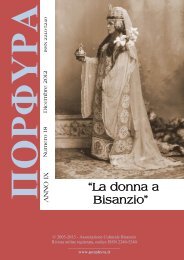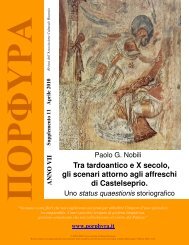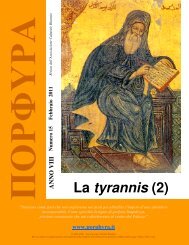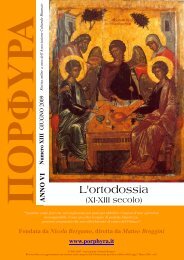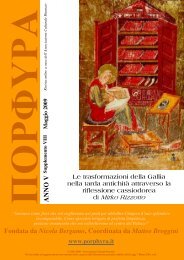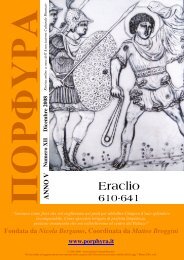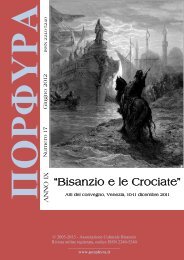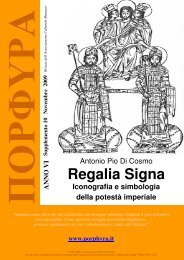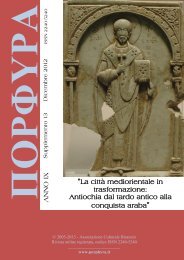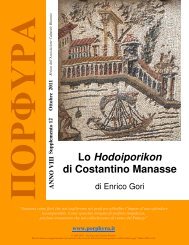Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Porphyra</strong> Anno IV, numero IX, Maggio 2007<br />
“L’età macedone: dotti, militari, patriarchi”<br />
O leggi della natura mortale e rivolgimenti della sorte! A quali lamenti<br />
impetuosamente mi conducete! (…) Poiché questo grande imperatore era<br />
vinto dalla malattia e venivano meno le speranze di guarigione, non c’era chi<br />
non gemesse e piangesse il Porfirogenito, il buon signore, il dolce, il mite,<br />
l’affabile, il sereno (…). L’augusta Elena, insieme ai suoi figli, al patrizio e<br />
parakoimomenos Basilio e ai koitonitai, come videro che l’imperatore<br />
perdeva conoscenza ed era prossimo a spirare, si gettarono intorno al letto e,<br />
aspergendolo di lacrime e gemiti infiniti, gemettero e piansero un tale signore<br />
(…). Giunto alla fine, il dolce e generoso imperatore fu attorniato da cori di<br />
santi e giusti monaci, martiri e patriarchi, che deposero il suo santo spirito<br />
nelle mani degli angeli. 366<br />
Valore e struttura dei carmi.<br />
I quattro carmi hanno un inestimabile valore documentario:<br />
sono infatti, come abbiamo accennato, i più antichi esempi di<br />
componimenti in verso politico giunti sino a noi. 367<br />
Il cosiddetto verso politico 368 è la forma metrica tonica<br />
(ossia basata sull’accento di parola e non sulla quantità sillabica)<br />
che, dopo gli esordi del X secolo, si avvierà a costituire il metro<br />
per eccellenza della produzione letteraria di età bizantina e postbizantina.<br />
È composto da due emistichi, il primo di otto e il<br />
secondo di sette sillabe, per un totale di quindici sillabe (onde la<br />
denominazione alternativa di “decapentasillabo”). 369<br />
La struttura dei componimenti è quanto mai varia. Il primo<br />
carme in morte di Leone VI è composto sette distici di versi<br />
politici, chiusi da un settenario (un verso cioè di sette sillabe,<br />
corrispondente al secondo emistichio di un decapentasillabo) a<br />
366<br />
TEOFANE CONTINUATO, PG CIX, 484C-485A: «VAll’w= qnhth/j fu,sewj no,moi kai. tu,chj metabolai.( pro.j oi[ouj<br />
sunepei,gomai kai. evlau,nomai qrh,nouj! (…) VEpei. ga/r h`tta/to o` fobero.j basileu.j para. th/j no,sou kai. ai` peri. tou/ zh/n<br />
evlpi,dej proecw,roun( ouvk h=n o[stij to.n Porfuroge,nnhton mh. avpwlofu,reto kai. avpwdu,reto to.n kalo.n a;nakta( to.n<br />
gluku.n( to.n euvproshnh/( to.n euvpro,siton( to.n galhno,n (…). Au;gousta Èle,nh su.n kai. toi/j te,knoij auvth/j kai. tw|/<br />
patriki,w| kai. parakoimwme,nw| Basilei,w| kai. toi/j koitwni,taij( w`j e`w,rwn to.n a;nakta yucorragou/nta kai.<br />
sugkopto,menon( pericuqe,ntej th|/ kli,nh| klauqmoi/j kai. o`durmoi/j avme,troij perirrai,nontej avpwlofu,ronto kai.<br />
avpowdu,ronto toiou/ton despo,thn (…). Kai. pro.j ta. te,lh pa,nth w'n o` gluku.j kai. ploutodo,thj basileu.j( corostasi,ai<br />
a`gi,wn kai. dikai,wn monacw/n te kai. martu,rwn kai. ièrarcw/n pari,stanto( kai. to pana,gion auvtou/ pneu/ma cersi.n<br />
avggelikai/j pare,qento)»<br />
367<br />
Cfr. supra, n. 7.<br />
368<br />
Secondo la testimonianza di Eustazio di Tessalonica (ad Iliadem, 2: «kai. dhlou/si tou/to fanerw/j kai. oi` dhmotikoi.<br />
sti,coi (…) a;rti de. politikoi. ovnomazo,menoi», «e lo dimostrano chiaramente [ = la sinizesi di –ew nella parola<br />
Phlhi?ade,w] i versi demotici, recentemente denominati politici») questo verso era inizialmente indicato come dhmotiko.j<br />
sti,coj e solo al tempo di Eustazio (seconda metà del XII secolo) si era affermata la denominazione politiko.j sti,coj.<br />
La sua prima attestazione nell’uso comune è però anteriore di circa un secolo ed è rappresentata da un passo della<br />
VExh,ghsij eivj to. =Asma tw/n VAsma,twn di Psello (Epilogos, 3: «politikoi/j evfra,asamen( w`j dunato,n( evn sti,coij»,<br />
«abbiamo espresso, come potevamo, in versi politici») . Se l’appellativo dhmotiko,j riconduce ai dh/moi e collega quindi<br />
il nostro verso ai carmi delle fazioni dell’Ippodromo (cfr. JEFFREYS M.J., The Nature and Origins of the Political<br />
Verse, in e JEFFREYS E.M. e M.J., Popular Literature in Late Byzantium, London 1983, pp. 142-195: pp. 179-180),<br />
l’aggettivo politiko,j potrebbe significare tanto “costantinopolitano” (i dh/moi costituivano un elemento peculiare della<br />
vita civile e politica della capitale) quanto “comune, grossolano” (in riferiemento alla scarsa elaborazione formale e al<br />
tono popolare dei canti dell’Ippodromo). Il cambio di denominazione si spiega forse (LAVAGNINI B., Alle origini del<br />
verso politico, Palermo 1983, p. 8) con la scarsa intelligibilità, al di fuori della capitale, di dhmotiko,j nel senso di<br />
“proprio dei dh/moi”.<br />
369<br />
Il decapentasillabo prevede quindi una pausa dopo l’ottava sillaba: il primo emistichio (appunto di otto sillabe) può<br />
presentare accento sulla sesta (più comune nei componimenti del IX-X secolo) o sull’ottavo sillaba (più comune dopo<br />
l’XI secolo, fino a divenire dominante alla fine del millennio bizantino). Fisso è invece l’accento conclusivo sulla<br />
quattordicesima sillaba.<br />
130<br />
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio