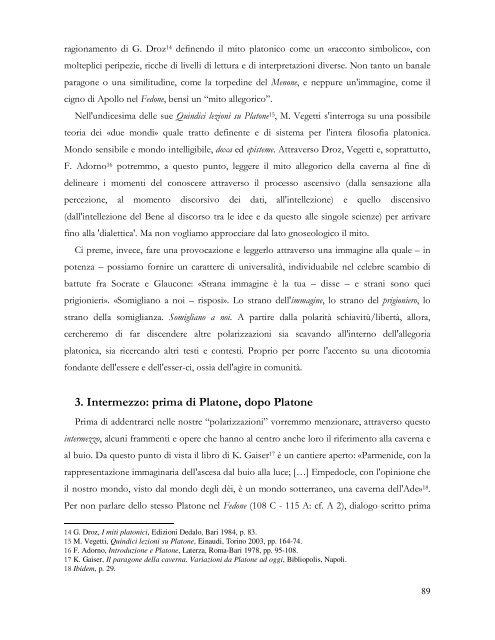Relazione finale SSIS Filosofia e Storia - DarioDanti.it
Relazione finale SSIS Filosofia e Storia - DarioDanti.it
Relazione finale SSIS Filosofia e Storia - DarioDanti.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
agionamento di G. Droz 14 definendo il m<strong>it</strong>o platonico come un «racconto simbolico», con<br />
molteplici peripezie, ricche di livelli di lettura e di interpretazioni diverse. Non tanto un banale<br />
paragone o una simil<strong>it</strong>udine, come la torpedine del Menone, e neppure un'immagine, come il<br />
cigno di Apollo nel Fedone, bensì un “m<strong>it</strong>o allegorico”.<br />
Nell'undicesima delle sue Quindici lezioni su Platone 15, M. Vegetti s'interroga su una possibile<br />
teoria dei «due mondi» quale tratto definente e di sistema per l'intera filosofia platonica.<br />
Mondo sensibile e mondo intelligibile, doxa ed episteme. Attraverso Droz, Vegetti e, soprattutto,<br />
F. Adorno 16 potremmo, a questo punto, leggere il m<strong>it</strong>o allegorico della caverna al fine di<br />
delineare i momenti del conoscere attraverso il processo ascensivo (dalla sensazione alla<br />
percezione, al momento discorsivo dei dati, all'intellezione) e quello discensivo<br />
(dall'intellezione del Bene al discorso tra le idee e da questo alle singole scienze) per arrivare<br />
fino alla 'dialettica'. Ma non vogliamo approcciare dal lato gnoseologico il m<strong>it</strong>o.<br />
Ci preme, invece, fare una provocazione e leggerlo attraverso una immagine alla quale – in<br />
potenza – possiamo fornire un carattere di universal<strong>it</strong>à, individuabile nel celebre scambio di<br />
battute fra Socrate e Glaucone: «Strana immagine è la tua – disse – e strani sono quei<br />
prigionieri». «Somigliano a noi – risposi». Lo strano dell'immagine, lo strano del prigioniero, lo<br />
strano della somiglianza. Somigliano a noi. A partire dalla polar<strong>it</strong>à schiav<strong>it</strong>ù/libertà, allora,<br />
cercheremo di far discendere altre polarizzazioni sia scavando all'interno dell'allegoria<br />
platonica, sia ricercando altri testi e contesti. Proprio per porre l'accento su una dicotomia<br />
fondante dell'essere e dell'esser-ci, ossia dell'agire in comun<strong>it</strong>à.<br />
3. Intermezzo: prima di Platone, dopo Platone<br />
Prima di addentrarci nelle nostre “polarizzazioni” vorremmo menzionare, attraverso questo<br />
intermezzo, alcuni frammenti e opere che hanno al centro anche loro il riferimento alla caverna e<br />
al buio. Da questo punto di vista il libro di K. Gaiser 17 è un cantiere aperto: «Parmenide, con la<br />
rappresentazione immaginaria dell'ascesa dal buio alla luce; […] Empedocle, con l'opinione che<br />
il nostro mondo, visto dal mondo degli dèi, è un mondo sotterraneo, una caverna dell'Ade» 18.<br />
Per non parlare dello stesso Platone nel Fedone (108 C - 115 A: cf. A 2), dialogo scr<strong>it</strong>to prima<br />
14 G. Droz, I m<strong>it</strong>i platonici, Edizioni Dedalo, Bari 1984, p. 83.<br />
15 M. Vegetti, Quindici lezioni su Platone, Einaudi, Torino 2003, pp. 164-74.<br />
16 F. Adorno, Introduzione e Platone, Laterza, Roma-Bari 1978, pp. 95-108.<br />
17 K. Gaiser, Il paragone della caverna. Variazioni da Platone ad oggi, Bibliopolis, Napoli.<br />
18 Ibidem, p. 29.<br />
89