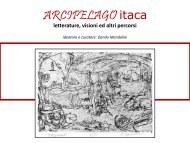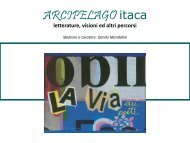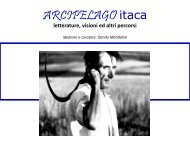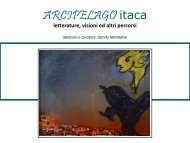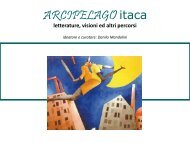Leonardo Mancino - Arcipelago Itaca
Leonardo Mancino - Arcipelago Itaca
Leonardo Mancino - Arcipelago Itaca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Poesia – Umanità<br />
Che cosa intende per “poema dal passo lungo”?<br />
Ho una predilezione particolare: quella di pensare ad una poesia che sia anche una sorta di romanzo in versi. Ne L’ultima rosa dell’inverno vi è<br />
proprio una poesia che parla della scrittura del romanzo, La formazione appassionata del “romanzo”: “se un romanzo vuol parlare / veramente<br />
/ ha il dovere di narrare dei mille trapianti / delle sequenze / innesti veri e falsi”. In questo si racconta tutto: non è il “parlare”, ed esso non ha<br />
ragione di esistere se non vi è l’eloquente e l’ascoltante; in questo la poesia deve essere fruibile, intelligibile, godibile, comprensibile, altrimenti<br />
non avrebbe senso. È più facile oggi dire “quel poeta è difficile”, ma quando si dice “quel narratore è incomprensibile”, il romanzo non si legge;<br />
e io voglio consentire alla poesia di avvalersi della capacità di essere compresa, come avviene per un’opera narrativa. D’altro canto non credo ai<br />
generi: o è poesia o non è poesia; in questo sono crociano.<br />
Quali sono i suoi temi prediletti?<br />
La ricerca del ruolo del poeta come iconografo morale della società in cui vive da sempre allo scoperto. E ancora, la dignità e la sacralità della<br />
vita; anche e soprattutto l’indagine accorata sui ritmi dell’esistenza umana e l’individuale farsi carico del problema della vita e dei gesti altrui.<br />
Nel visibile i miei temi sono anche la terra, il paesaggio e la natura, la condizione gestuale degli uomini, la prigione, l’esilio, la sacrosanta rabbia,<br />
ogni traccia necessaria per l’identificazione dei significati dell’azione, la donna, l’assente/presente. Nel gorgo sintattico si calano la vita,<br />
l’esistenza, l’anima e la mente, il cuore sempre in fuga, la memoria. Così posso odiare la funzione del poeta della o dalla residenza. Leopardi<br />
pare non voglia farmi partire, Keats mi chiama al viaggio avventuroso.<br />
Quando il poeta deve uscire allo scoperto?<br />
Se si riflette sulle ragioni per le quali Huizinga ha scritto La crisi della civiltà o Antonio Banfi Sulla crisi morale di un popolo, si comprende che è il<br />
momento di uscire allo scoperto quando la crisi sta muovendosi verso il profondo. Ma il poeta non lo fa solo come poeta, ma anche come uomo<br />
ed interprete dei bisogni culturali degli altri. Quindi egli è un’intelligenza con le intelligenze, una volontà con le volontà, un cuore con i cuori<br />
altrui.<br />
Oggi, in modo particolare, il compito del poeta finisce per essere fondamentale. Si dovrebbe prendere, ad esempio, Montale: egli scrive La<br />
bufera dopo la “bufera”, cioè dopo la guerra. Il poeta non deve rinunciare, in quanto poeta, alla sua essenza di uomo: deve vivere la coscienza<br />
della necessità della presenza umana, dell’altro, negli eventi. Egli così non scriverà mai delle piccole poesie, ma il poema della sua vita, e i lettori<br />
riconosceranno la validità di quella poesia interpretandola alla luce di ciò che nel tempo della scrittura è accaduto al mondo.<br />
Lei ha definito la condizione del poeta come una guerra: nel senso di rabbia, denuncia o altro?<br />
No. Nella poesia Un vecchio padre una mattina (3), si cita in corsivo il termine guerrato: che dice il poeta al padre e il padre al poeta? Identifica<br />
proprio la vita come qualcosa di guerrato: c’è un incontro di stimoli, di occasioni, di motivazioni che nella coscienza del soggetto devono creare<br />
per forza antinomie, antitesi, per giungere a delle sintesi ulteriori. Ma è il destino dell’intelligenza creativa dell’uomo, non solo del poeta, quello<br />
di vivere sempre in una conflittualità naturalmente intelligente. La rabbia può venire quando si scopre l’inanità, l’impossibilità di intervenire in<br />
modo che tutto sia migliore.<br />
Ne La lettera sulla condizione (4) dedicata a Vittorio Bodini, lei definisce il rancore come una condizione del vivere…<br />
Sì, ma ce dell’altro: ho coniato, per esempio, “sarcastironico”, “malincospirazioni”, che possono essere malinconie, aspirazioni, ma anche<br />
cospirazioni moralmente necessarie.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
33