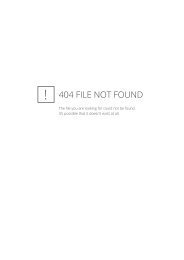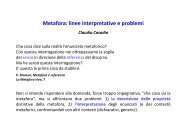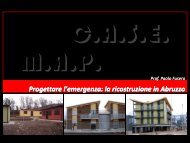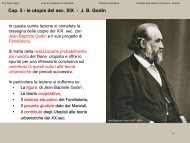Perdita del centro - Università Gabriele d'Annunzio
Perdita del centro - Università Gabriele d'Annunzio
Perdita del centro - Università Gabriele d'Annunzio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Seldmayr PERDITA DEL CENTRO 103<br />
prosegue poi nel pieno e tardo barocco. L'arte anticlassica <strong>del</strong> 1520-1590 (accanto alla<br />
quale esiste anche un tardo rinascimento) viene chiamata oggi con un nome che - al<br />
pari di "gotico "e di "barocco" che volevano esprimere in origine una condanna - vuole<br />
invece esprimere ciò che è manierato: col nome, cioè, di manierismo. 188<br />
Nel definire il manierismo come arte anticlassica, non bisogna dimenticare che esso<br />
si riallaccia saldamente al complesso <strong>del</strong>le forme classiche, ma in un settore a sé. Si<br />
riesce a comprendere bene i fenomeni manieristici soprattutto se si risale al senso <strong>del</strong>la<br />
vita <strong>del</strong> manierismo stesso: dubbio, scissione interna e angoscia, un profondo legame<br />
con la morte.<br />
Questo è il suo punto di contatto con l'arte moderna. Suoi tratti caratteristici sono<br />
l'estraneamento, la rigidità, il raffreddamento e la morte <strong>del</strong>la forma classica. Il manierismo<br />
cerca ciò che è liscio, rigido o morto; non la forma che nasce organicamente, ma<br />
quella imposta, e specialmente, ciò che appare formalistico e cerimonioso. Tutto diviene<br />
privo di vita e formale, spettrale e ricercato. Questa specie di arte sceglie materiali<br />
morti, freddi e grezzi (per esempio, il cristallo di rocca), i colori gessosi, pietrosi, metallici<br />
e il nero cupo. Le piace fondere i corpi umani con la pietra, ama i colori anemici,<br />
la corazza al posto <strong>del</strong> corpo, la maschera al posto <strong>del</strong> viso. 189 Negli atteggiamenti<br />
predilige la distinzione, la riservatezza, tutto ciò che è enigmatico e chiuso, la gravità<br />
<strong>del</strong>la morte.<br />
Il manierismo cerca nell'architettura ciò che è fragile e artificioso, esile, allungato,<br />
stiracchiato e specialmente la forma "turbata" in maniera inorganica. In questo esso<br />
assomiglia a certe costruzioni <strong>del</strong> tardo gotico, <strong>del</strong>l'epoca cioè intorno al 1525, nelle<br />
quali si notano, ad esempio, cordonature apparentemente spezzate e messe di nuovo<br />
insieme o ritagliate da altre forme o turbate da esse. Si aggiunga che nel manierismo il<br />
pittore dipinge se stesso davanti allo specchio che lo deforma.<br />
Questa corrente artistica ama comporre quadri servendosi di elementi desunti da varie<br />
realtà, con figure di varia grandezza, oppure anche mescolare frammenti di forme<br />
non pertinenti, per esempio forme gotiche con forme classiche. Esso riesuma l'antichità<br />
considerandola morta: un mondo di spoglie e di frammenti. Conosce l'immagine<br />
scissa (come pure la scissione fra osservatore ed immagine) e quella frammentaria.<br />
Così, alla fine <strong>del</strong>l'epoca, l'Arcimboldi compone teste umane servendosi esclusivamente<br />
di conchiglie o di ortaggi, ciò che assume un aspetto <strong>del</strong> tutto surrealista.<br />
Il legame più profondo fra il manierismo e l'arte moderna consiste nella vicinanza alla<br />
morte e in un dissidio fra l'uomo e la natura. La natura organica si separa. Dai grandi<br />
sconvolgimenti spirituali il manierismo si ritira in un mondo artificiale. In molti tratti<br />
caratteristici si manifesta una profonda angoscia <strong>del</strong>la vita e <strong>del</strong> mondo: nella labilità<br />
<strong>del</strong>l'insieme <strong>del</strong> quadro e nell'esagerazione, spesso opprimente, <strong>del</strong>le dimensioni spaziali<br />
in profondità.<br />
Con tutto ciò il manierismo è un'arte di grande spiritualità.<br />
Tutto questo spiega perché esso venisse riscoperto nei suoi valori proprio nel primo<br />
ventennio <strong>del</strong> secolo ventesimo. L'arte moderna riconosce sempre più in questo stile il<br />
suo predecessore e il suo mo<strong>del</strong>lo. La mostra dei manieristi francesi allestita nel 1946<br />
all'Albertina di Vienna sotto il titolo di "fantasticheria francese", intendeva far conoscere<br />
l'elemento anticlassico <strong>del</strong>l'arte francese, troppo a lungo misconosciuto, ma anche<br />
legittimare le assurdità degli artisti francesi più moderni paragonandole a così insigni<br />
predecessori.<br />
Il manierismo che, a sua volta, poteva appoggiarsi a certi caratteri <strong>del</strong>la tarda arte<br />
michelangiolesca - arte però interiormente assai lontana dal manierismo 190 - si diffuse<br />
in tutta l'Europa molto rapidamente, molto più rapidamente <strong>del</strong>lo stesso rinascimento.<br />
Il suo <strong>centro</strong> di gravità è l'Italia; non Roma, come per il pieno rinascimento e<br />
188 Oggi la bibliografia sul manierismo è già molto ricca; come orientamento vedi W. PINDER, Zur Physiognomik<br />
des Manierismus, nel volume in onore di Ludwig Klages, 1932; E. GOMBRICH, Zum Werke Giulio Romanos,<br />
in "Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen", Vienna, nuova serie, vol. VIII, 1934; H. SEDLMAYR,<br />
Die "Macchia" Bruegels, ibid.; H. HOFMANN, Hochrenaissance, Manierismus, Frühbarock, Zurigo-Lipsia 1938.<br />
189 W. PINDER, cit.<br />
190 Cfr. H. SEDLMAYR, Über Michelangelo: Versuch über seine Kunst, Monaco 1940.<br />
6 aprile 2013







![[Intervista su Sergio Bettini]1](https://img.yumpu.com/42985575/1/184x260/intervista-su-sergio-bettini1.jpg?quality=85)