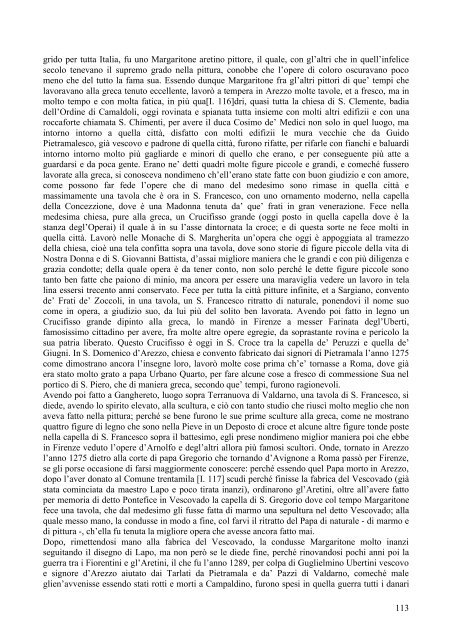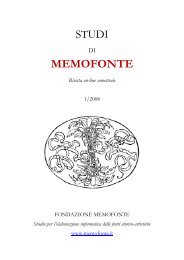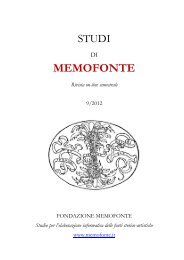- Page 1 and 2:
INDICE COPIOSO DELLE COSE PIÙ NOTA
- Page 3 and 4:
Arte Magistrati di Fiorenza, p. 177
- Page 5 and 6:
Bentivogli loro palazo, s. 424, cap
- Page 7 and 8:
Fioravanti, p. 230 Gondi, p. 83 Gri
- Page 9 and 10:
Città ritratte in Belvedere di Rom
- Page 11 and 12:
Discrezione finta in pittura dal Ma
- Page 13 and 14:
Facciata del Duomo di Siena, s. 463
- Page 15 and 16:
Gesso da formare che fa presa, s. 3
- Page 17 and 18:
Guidobaldo primo Duca d’Urbino, s
- Page 19 and 20:
Libro di Lorenzo Ghiberti, s. 275,
- Page 21 and 22:
Maso Finiguerra orefice, s. 466, p.
- Page 23 and 24:
N Nanni d’Antonio di Banco, s. 25
- Page 25 and 26:
P Pace da Faenza, s. 131 Pagno Port
- Page 27 and 28:
Piaza di San Giovanni di Fiorenza a
- Page 29 and 30:
Ruberto Martelli, s. 328 Ruvidino g
- Page 31 and 32:
San Giovanni in Monte di Bologna, s
- Page 33 and 34:
Santo Spirito di Fiorenza, p. 140,
- Page 35 and 36:
Silvano Razzi monaco, p. 128 Sigill
- Page 37 and 38:
Teatro di Marcello in Roma, p. 24 T
- Page 39 and 40:
TAVOLA DE’ RITRATTI CHE SONO NOMI
- Page 41 and 42:
F Farinata Uberti, p. 123 Farganacc
- Page 43 and 44:
Nicola V Papa, s. 361 Nicolò Forte
- Page 45 and 46:
Andrea Verocchio pittore, scultore
- Page 47 and 48:
Mino da Fiesole scultore, s. 419 N
- Page 49 and 50:
Cappella di Santa Maria Maddalena.
- Page 51 and 52:
SAN BERNARDO La cappella grande. Lo
- Page 53 and 54:
Tavola nella cappella de’ Rossi.
- Page 55 and 56:
SAN DOMENICO Tavola dell’altar ma
- Page 57 and 58:
Due statue verso la Canonica. Nicco
- Page 59 and 60:
La cappella de’ Castellani. Ghera
- Page 61 and 62:
Le figure di terra invetriata. Luca
- Page 63 and 64:
Il crocifisso nel primo chiostro, l
- Page 65 and 66:
Un Crocifisso. Pesello, s. 405 MONA
- Page 67 and 68:
Storia di San Miniato e San Cresci
- Page 69 and 70:
Figure della cappella maggiore, Gio
- Page 71 and 72:
Sant’Agostino, cappella di San Cr
- Page 73 and 74:
Sei storie di Iob. Giotto, p. 122 P
- Page 75 and 76:
Il Pergamo. Giovanni Pisano, p. 104
- Page 77 and 78:
Cappella di marmo del presepio. Mar
- Page 79 and 80:
Le storie della libreria del Domo.
- Page 81 and 82:
VOLTERRA DUOMO Il modello. Niccolò
- Page 83 and 84:
I Innocenzo da Imola pittore, 217 I
- Page 85 and 86:
La cappella di San Matteo. Antonio
- Page 87 and 88:
SAN MARGHERITA Monasterio di monach
- Page 89 and 90:
Una tavola della Concezione di Nost
- Page 91 and 92:
Un San Bernardo in fresco et una sa
- Page 93 and 94:
Mariotto Albertinelli, 37 SANT’AP
- Page 95 and 96:
Il Tabernacolo sul canto dietro a
- Page 97 and 98:
IL PALAGIO DE’ GONDI Dirimpetto a
- Page 99 and 100:
ROVEZZANO Un tabernacolo. Franciabi
- Page 101 and 102:
SAN FRANCESCO Una cappella, dove è
- Page 103 and 104:
Il pozzo. Antonio da San Gallo, 318
- Page 105 and 106:
Una tavola. Il Bronzino, 192 La Com
- Page 107 and 108:
Il tempio nel primo chiostro. Brama
- Page 109 and 110:
Pitture della detta cappella. Pelle
- Page 111 and 112:
Una facciata del Cardinale di Volte
- Page 113 and 114:
Una tavola d’un San Nicolò et al
- Page 115 and 116:
Pitture sopra la cappella del monte
- Page 117 and 118:
CHIESA DELLA TRINITÀ La tavola del
- Page 119 and 120:
Francesco Re di Francia, 80 Frances
- Page 121 and 122:
T Tibullo, 71 San Tomaso d’Aquino
- Page 123 and 124:
Antonio Floriani pittore, 185 Anton
- Page 125 and 126:
Bernia [F. Berni], 346 Bertoldo scu
- Page 127 and 128:
Carlo Ginori, 153, sua cappella in
- Page 129 and 130:
Diomede Caraffa, 147 Discepoli d’
- Page 131 and 132:
Fontanableo in Francia, 210, 211 Fo
- Page 133 and 134:
Giovan Maria pittore veronese, 255
- Page 135 and 136:
Insolenzia delli Ungheri, 46 Intagl
- Page 137 and 138:
Marco da Siena, pittore, 368 Marco
- Page 139 and 140:
Nostra Donna del Vinci, 4 Nostra Do
- Page 141 and 142:
Piero RosseIIi, scultore, 39 Piero
- Page 143 and 144:
S Sacco di Roma, 112, 141, 201, 233
- Page 145 and 146:
T Tabernacolo sul canto di via Mozz
- Page 147 and 148:
Vitruvio commentatore, 28 Vitto di
- Page 149 and 150:
Atlante descritto, 677, 707 B Bacci
- Page 151 and 152:
Cappella del Comune in Siena, 534 C
- Page 153 and 154:
Compagnia del Giesù, in Cortona, 4
- Page 155 and 156:
F Fabrica di San Piero data al Buon
- Page 157 and 158:
Giovan Maria Benintendi, 483 Giovan
- Page 159 and 160:
L Lascito del Bandinello, che volse
- Page 161 and 162:
Monache del Corpus Domini, in Venez
- Page 163 and 164:
Pace in Roma, 629, 748, 775, 828, 8
- Page 165 and 166:
Raffaello dal Colle dal Borgo Sanse
- Page 167 and 168:
San Domenico di Messina, 619 San Do
- Page 169 and 170:
Santa Maria dell’Anima in Roma, 5
- Page 171 and 172:
Taddeo Zucchero, pittore, 673, 703
- Page 173 and 174:
Bachiaccha pittore, 838, 865 Baldo
- Page 175 and 176:
N Fra’ Niccolò della Magna, 455
- Page 177 and 178:
Francesco Primaticcio Abbate di San
- Page 179 and 180:
SAN DOMENICO La tavola dell’altar
- Page 181 and 182:
I SERVI L’altar maggiore di marmo
- Page 183 and 184:
CREMA SANT’AGOSTINO Due tavole. P
- Page 185 and 186:
Le figure in fresco dell’arco del
- Page 187 and 188:
Una tavola con la Nostra Donna, San
- Page 189 and 190:
Pitture della sala grande e palco,
- Page 191 and 192:
CASTELLO VILLA DEL S. DUCA Una logg
- Page 193 and 194:
La tavola di Santa Agata. Ippolito
- Page 195 and 196:
LA FACCIATA DELLA CASA DEL SIGNOR G
- Page 197 and 198:
La Adorazione de’ Magi. Michel An
- Page 199 and 200:
Una tavola d’un Cristo deposto di
- Page 201 and 202:
Una tavola d’un Cristo morto, Iac
- Page 203 and 204:
Una cappella, che risponde nella co
- Page 205 and 206:
SANTO SPIRITO Una tavola. Domenico
- Page 207 and 208:
Una tavoletta d’un San Niccolò a
- Page 209 and 210:
Pitture della cappella del Sagramen
- Page 211 and 212:
Pitture di detto palazzo. Paolo e B
- Page 213 and 214:
Un palazzo del signor Mario Volpett
- Page 215 and 216:
Alaga Capitano de’ Giannizzeri Ca
- Page 217 and 218:
Giovanni Medici Giovanni Pierfrance
- Page 219 and 220:
Nicolao V Eugenio IIII Giulio III M
- Page 221 and 222:
Sopra alla terza porta vi sono due
- Page 223 and 224:
Cap. XXXIII. Del niello e come per
- Page 225 and 226:
Vita di Madonna Properzia de’ Ros
- Page 227 and 228:
VITE DE’ PIÙ ECCELLENTI PITTORI
- Page 229 and 230:
disegno et i lineamenti non sieno s
- Page 231 and 232:
intendono di cavarne, e possa, senz
- Page 233 and 234:
E finalmente, per rispondere a quel
- Page 235 and 236:
mie diletteranno coloro che non son
- Page 237 and 238:
tazza antica di porfido bellissima
- Page 239 and 240:
nel[I. 15]la cava, quando si taglia
- Page 241 and 242:
d’acque e di terra, che per la cr
- Page 243 and 244:
medesima, da mano a mano in dar gra
- Page 245 and 246:
quale abbia le commettiture dinanzi
- Page 247 and 248:
corinti, salvo che vuole essere pi
- Page 249 and 250:
vi si pone, come si vede alla vigna
- Page 251 and 252:
unitamente corrisponda all’appicc
- Page 253 and 254:
Del fare i modelli di cera e di ter
- Page 255 and 256:
naturalmente doverebbono; laonde sp
- Page 257 and 258:
cappa e quanta n’è uscita. E sap
- Page 259 and 260:
stucco grosso e bozzato; et appress
- Page 261 and 262:
cose vive, che si muovono. Quando p
- Page 263 and 264:
punto fatte diminuire e sfuggire, b
- Page 265 and 266:
orecchi restano offesi da una music
- Page 267 and 268:
più facilmente; et insomma li arte
- Page 269 and 270:
Cap. XXV Del dipignere nelle mura d
- Page 271 and 272:
trovar modo a poterlo talmente dist
- Page 273 and 274:
del nuovo e del durabile, che per p
- Page 275 and 276:
tempere che col tempo si consumavan
- Page 277 and 278:
non si vegghino. Così si fa un ril
- Page 279 and 280:
icercar di nuovo tutta l’Italia e
- Page 281 and 282:
altri leggiadri e gravi ornamenti i
- Page 283 and 284:
mastio dalla femmina; e similmente
- Page 285 and 286:
a somma perfezzione, e sopratutto d
- Page 287 and 288: Fu questo Apelle molto umano invers
- Page 289 and 290: medesimo. Questa figura di Protogen
- Page 291 and 292: Bacco il quale era nel tempio della
- Page 293 and 294: governo della provincia di Nerbona,
- Page 295 and 296: danno e guastarsi e per lo più a f
- Page 297 and 298: medesimo anche Efestione, molto int
- Page 299 and 300: della arte sua scrisse volumi. Molt
- Page 301 and 302: viso, onde questi artefici, per bef
- Page 303 and 304: porgeva da bere: le due ninfe, le q
- Page 305 and 306: avvenga[II. XXXVIII]ché per la bel
- Page 307 and 308: tutte l’altre cose, quando l’al
- Page 309 and 310: nostri, cioè l’anno 1554, trovat
- Page 311 and 312: Liberio papa gl’architetti di que
- Page 313 and 314: d’un pezzo solo e tanto grande e
- Page 315 and 316: L’edifizio sopradetto del Duomo d
- Page 317 and 318: [I. 83] Fine del proemio delle Vite
- Page 319 and 320: Tornato dunque Cimabue a Firenze, d
- Page 321 and 322: e così molte sculture di que’ te
- Page 323 and 324: si facesse molto maggiore e più ma
- Page 325 and 326: l’animo del Brunellesco a porvi s
- Page 327 and 328: molta pratica e con perfettissimo d
- Page 329 and 330: Avendo al tempo di Nicola cominciat
- Page 331 and 332: commesse nel marmo con molta dilige
- Page 333 and 334: Batista et un altro Santo si vede i
- Page 335 and 336: Regolari, dove, in un pergamo fatto
- Page 337: si veggiono intorno a quel tempio n
- Page 341 and 342: Quell’obligo stesso che hanno gl
- Page 343 and 344: egni né da corone né da palme che
- Page 345 and 346: dell’arte messer Niccolò Acciaiu
- Page 347 and 348: questa opera che pare vivissimo; et
- Page 349 and 350: duos ego novi pictores egregios, ne
- Page 351 and 352: lavoro, si rimise più d’una volt
- Page 353 and 354: assediato dagl’Aretini, si arrend
- Page 355 and 356: Iacopo di Pistoia; nella quale oper
- Page 357 and 358: teologiche sono tutti vòlti verso
- Page 359 and 360: perché dove figurò la Nostra Donn
- Page 361 and 362: naturale detto Pontefice. Laonde me
- Page 363 and 364: mura e barbacani, non aveva così i
- Page 365 and 366: Essendo poi, indi a non molto, dive
- Page 367 and 368: Dopo quest’opera andato Buonamico
- Page 369 and 370: una cosa che per burla e non per al
- Page 371 and 372: interamente sodisfatto; ma volendo
- Page 373 and 374: [I. 167] VITA DI PIETRO CAVALLINI R
- Page 375 and 376: Felici veramente si possono dire qu
- Page 377 and 378: ingraziarlo; e nello stesso quadro
- Page 379 and 380: Dipinse ancora sopra la porta della
- Page 381 and 382: Fu fattogli allogazione in Arezzo d
- Page 383 and 384: VITA D’ANDREA DI CIONE ORGAGNA Pi
- Page 385 and 386: carissimi, quali mise in paradiso,
- Page 387 and 388: Dopo la morte d’Andrea, Iacopo su
- Page 389 and 390:
leggere per esser consumate dal tem
- Page 391 and 392:
Essendo poi tornato Giovanni a Fire
- Page 393 and 394:
Giovanni Pisano l’anno 1312, come
- Page 395 and 396:
capella un Crucifisso grande e a’
- Page 397 and 398:
Molti che si starebbono nelle patri
- Page 399 and 400:
fatto nella medicina per coloro che
- Page 401 and 402:
[I. 212] VITA DI SPINELLO ARETINO P
- Page 403 and 404:
che fu tenuta figura bellissima ins
- Page 405 and 406:
Finita quest’opera in Camposanto,
- Page 407 and 408:
molta lode e si tiene al presente,
- Page 409 and 410:
ambiziosi che negli scioperati et o
- Page 411 and 412:
molta diligenza e con suo molto ono
- Page 413 and 414:
mettono in mezzo la capella maggior
- Page 415 and 416:
potuto sono iti investigando i modi
- Page 417 and 418:
nella Prima Parte) meriteranno quel
- Page 419 and 420:
ornamenti, arricchita et abbellita,
- Page 421 and 422:
Nunziata; dove egli fece in una man
- Page 423 and 424:
l’una, cioè San Gregorio papa e
- Page 425 and 426:
in simili masserizie istorie bellis
- Page 427 and 428:
Nella faccia di S. Maria del Fiore
- Page 429 and 430:
che ne fu inventore, riportò lode
- Page 431 and 432:
si acconciava a vivere in Fiorenza
- Page 433 and 434:
degli uccelli che d’altro, fu cog
- Page 435 and 436:
Donatello per la scultura, e se ste
- Page 437 and 438:
concorsi in Fiorenza molti forestie
- Page 439 and 440:
Romani, delle quali fu molto studio
- Page 441 and 442:
opere sue: avertenza certo grandiss
- Page 443 and 444:
molte, le quali tutte furono insiem
- Page 445 and 446:
delle femine l’arie più dolci et
- Page 447 and 448:
nipote, e come si dirà di mano in
- Page 449 and 450:
pervenire a quello onore et a quell
- Page 451 and 452:
che faceva (come io dissi poco di s
- Page 453 and 454:
moderni et ancora in quello degli a
- Page 455 and 456:
disegno e lavorata diligentemente,
- Page 457 and 458:
memoria sua, non mancherà di infon
- Page 459 and 460:
ciascuno grosso da piè braccia qua
- Page 461 and 462:
continuamente gridando si fece scal
- Page 463 and 464:
talmente, che nessuna cosa fu, quan
- Page 465 and 466:
migliore e di più bellezza; a cui
- Page 467 and 468:
legno d’abeto gagliardo e bene ar
- Page 469 and 470:
non hanno seguitato l’ordine del
- Page 471 and 472:
per le parole di Donato aspettava d
- Page 473 and 474:
simile ne lavorò, che medesimament
- Page 475 and 476:
ilievo nel marmo, che è tenuto cos
- Page 477 and 478:
Delle opere di costui restò così
- Page 479 and 480:
prestezza, facendo al dritto delle
- Page 481 and 482:
Similmente fece far Cosimo col dise
- Page 483 and 484:
[I. 347] Fine della Vita di Michell
- Page 485 and 486:
Malatesti e vi fece il suo ritratto
- Page 487 and 488:
termine, sono usurpate dalla preson
- Page 489 and 490:
Fu Piero, come si è detto, studios
- Page 491 and 492:
pareva che si guastasse, è stata r
- Page 493 and 494:
non cercare altra dignità che cerc
- Page 495 and 496:
[I. 366] VITA DI LEON BATISTA ALBER
- Page 497 and 498:
tonda, pare che caschi all’indiet
- Page 499 and 500:
Lavorava in Arezzo, ne’ tempi di
- Page 501 and 502:
gl’artefici di sapere in che modo
- Page 503 and 504:
padre, che arebbe voluto che egli a
- Page 505 and 506:
morte di tanto popolo, et inoltre l
- Page 507 and 508:
inchiuso, pensando alla pazzia sua
- Page 509 and 510:
fece due tavole et una nel Carmino
- Page 511 and 512:
edifizio. Fece il medesimo sotto le
- Page 513 and 514:
arrandellato e stretto con funi all
- Page 515 and 516:
particolarmente agl’intendenti de
- Page 517 and 518:
403] fatta da esso Pisano in Fioren
- Page 519 and 520:
invenzione. E si può dire che ques
- Page 521 and 522:
che dipinse di sua mano nel detto p
- Page 523 and 524:
elle e buone muraglie la fortezza;
- Page 525 and 526:
naturale la testa della Marietta de
- Page 527 and 528:
Ma per tornare al nostro, acquistat
- Page 529 and 530:
mano del Mantegna, due quadri, cio
- Page 531 and 532:
dallo star fuori di casa, se ne ste
- Page 533 and 534:
di[I. 432]pignere la medesima sala,
- Page 535 and 536:
che ritrasse esso imperator Maumett
- Page 537 and 538:
accanto all’entrata di Cestello.
- Page 539 and 540:
che era una maraviglia, e massimame
- Page 541 and 542:
condotto a quella perfezzione che o
- Page 543 and 544:
palazzo del cardinale di Monte, che
- Page 545 and 546:
Medici, il quale, come persona di s
- Page 547 and 548:
quadri, che mettono in mezzo la tav
- Page 549 and 550:
cognato; e l’altro che volta le s
- Page 551 and 552:
misurandole dapoi fatte che l’ave
- Page 553 and 554:
nella diligenzia e superollo nel di
- Page 555 and 556:
caso come passò appunto. Similment
- Page 557 and 558:
Inferno e lo mise in stampa, dietro
- Page 559 and 560:
son pieni di figure fatte di rimess
- Page 561 and 562:
Il medesimo alla Madonna delle Graz
- Page 563 and 564:
finalmente le dette due statue allo
- Page 565 and 566:
Si dilettò assai Andrea di formare
- Page 567 and 568:
erano cosa buona perché aveva nel
- Page 569 and 570:
l’esser stato riconosciuto dai pr
- Page 571 and 572:
come sotto la Speranza è la Disper
- Page 573 and 574:
cardinale chiamato a Siena a dipign
- Page 575 and 576:
nella sua patria inanzi che venisse
- Page 577 and 578:
dispiacere de la partita di messer
- Page 579 and 580:
di fame, di disagio, di incomodità
- Page 581 and 582:
con tutta quella fabrica gettate pe
- Page 583 and 584:
PETRUS PERUSINUS EGREGIUS PICTOR. P
- Page 585 and 586:
saggio di sé, che si aspettava che
- Page 587 and 588:
Nostra Donna col Figliuolo in bracc
- Page 589 and 590:
Bartolomeo Vivarino da Murano si po
- Page 591 and 592:
[I. 526] VITA DI LUCA SIGNORELLI DA
- Page 593 and 594:
diaspro al collo con infinita amore
- Page 595 and 596:
avezza del disegno, et oltra il con
- Page 597 and 598:
[II. 1] VITA DI LIONARDO DA VINCI P
- Page 599 and 600:
non sentito da Lionardo per il gran
- Page 601 and 602:
poiché delle cose sue ne son molte
- Page 603 and 604:
Soderini soleva pigliare, il cassie
- Page 605 and 606:
quale tiene la testa mozza di Golia
- Page 607 and 608:
antiche o de le buone moderne, nece
- Page 609 and 610:
VITA DI PIERO DI COSIMO Pittor Fior
- Page 611 and 612:
erano esuli, e come dire morti che
- Page 613 and 614:
tratto. E faceva discorsi e tirava
- Page 615 and 616:
ella invenzione, che si credette ch
- Page 617 and 618:
quelle in ciò che e’ [II. 33] po
- Page 619 and 620:
ignude. Per il che riscaldati i pop
- Page 621 and 622:
Bartolomeo: per il che levatolo di
- Page 623 and 624:
[II. 42] Mariotto Albertinelli, fam
- Page 625 and 626:
stette a Roma, volse mostrare ch’
- Page 627 and 628:
Uberti e San Benedetto abate, e dal
- Page 629 and 630:
perché chi aiuta e favorisce nell
- Page 631 and 632:
modelli al Francione et ad altri, e
- Page 633 and 634:
il Papa e col duca Valentino suo fi
- Page 635 and 636:
graziosissimo Raffaello da Urbino.
- Page 637 and 638:
punto e in tutte le cose, che i suo
- Page 639 and 640:
quale non aveva il frate atteso ins
- Page 641 and 642:
Petrarca e lo amoroso Boccaccio, ch
- Page 643 and 644:
quali ve n’ha una che a piè dell
- Page 645 and 646:
questi è vestito d’un panno ross
- Page 647 and 648:
si fa alla loggia di palazzo, e con
- Page 649 and 650:
Mercurio il caduceo, di Pan la samp
- Page 651 and 652:
tempo, ma a farsi un ottimo univers
- Page 653 and 654:
Beata veramente ti potevi chiamare,
- Page 655 and 656:
oscuri di mano in mano in quelle ch
- Page 657 and 658:
paragonarlo. Sono infinite opere di
- Page 659 and 660:
quella che fece nella medesima citt
- Page 661 and 662:
come si è detto, et a canto all’
- Page 663 and 664:
itratti similissimi al naturale, an
- Page 665 and 666:
morte Antonio, poi che fu fatto sep
- Page 667 and 668:
Pittori [II. 111] Dovendo io scrive
- Page 669 and 670:
Madalena in piedi e vestita con pic
- Page 671 and 672:
marmo che fece di mezzo rilievo nel
- Page 673 and 674:
sepellire, quattro Angeli in aria e
- Page 675 and 676:
feciono fare a Benedetto il disegno
- Page 677 and 678:
Michelagnolo, conosciuta la virtù
- Page 679 and 680:
giovane, in un pilastro d’Orsanmi
- Page 681 and 682:
Romano, del quale si è in altro lu
- Page 683 and 684:
preso un carbone, in un tratto ebbe
- Page 685 and 686:
fatte opere meritò tanto più lode
- Page 687 and 688:
ellissimo modello. Ma perché era c
- Page 689 and 690:
nazione spagnuola fatta fare il car
- Page 691 and 692:
onore et utile, e lo farebbe conosc
- Page 693 and 694:
ellissima pittura. Prese non molto
- Page 695 and 696:
di settembre, fu giudicato questo a
- Page 697 and 698:
dell’orto de’ Servi in due cant
- Page 699 and 700:
Federigo Secondo duca di Mantoa, ne
- Page 701 and 702:
grandezza, maestà e grazia infinit
- Page 703 and 704:
Fu la morte d’Andrea di grandissi
- Page 705 and 706:
asta che Temi e Cassandra e Manto e
- Page 707 and 708:
E DI DOSSO E BATTISTA Pittori Ferra
- Page 709 and 710:
monete, e di pittura Giorgio Vasari
- Page 711 and 712:
le cose altrui, o dal troppo volere
- Page 713 and 714:
viver in pace, partirsi di Udine, e
- Page 715 and 716:
Avendo il prencipe Doria in Genova
- Page 717 and 718:
ginocchioni, S. Caterina e S. Iacop
- Page 719 and 720:
pietre grosse ciascuna quanto un uo
- Page 721 and 722:
che, sì come gl’animi loro erano
- Page 723 and 724:
pittura ma paiono di metallo; e sop
- Page 725 and 726:
Disegnò il Rosso nella sua giovane
- Page 727 and 728:
portare addosso pesi e sgombrare qu
- Page 729 and 730:
forma di padiglione; la quale stanz
- Page 731 and 732:
nondimeno per essere quella di Bart
- Page 733 and 734:
uona maniera. Ne’ Servi di Bologn
- Page 735 and 736:
concorrenza di Andrea del Sarto e d
- Page 737 and 738:
di quella opera. E così in quella
- Page 739 and 740:
Pittore [II. 228] Quando il mondo h
- Page 741 and 742:
nell’altro; e nella testa d’uno
- Page 743 and 744:
In questo tempo il detto Antonio da
- Page 745 and 746:
Nella chiesa de’ frati Carmelitan
- Page 747 and 748:
splendore di Cristo con bella manie
- Page 749 and 750:
enefizio degl’artefici, anzi del
- Page 751 and 752:
nell’architettura, gli diedero or
- Page 753 and 754:
miniate. Fece ancora per la capella
- Page 755 and 756:
le bande di storie del Testamento V
- Page 757 and 758:
cioè Anselmo Canneri e Paulo Veron
- Page 759 and 760:
ultimamente in una carta bellissima
- Page 761 and 762:
Avendo il Gran Turco per un suo uom
- Page 763 and 764:
tutto svelto e volge le reni in par
- Page 765 and 766:
vescovo, e l’uno e l’altro frat
- Page 767 and 768:
presentasse occasione di far cose s
- Page 769 and 770:
fusse; et il padre don Girolamo Vol
- Page 771 and 772:
vedere i modi del fare e l’opere
- Page 773 and 774:
uon disegno, o che in pitture, scul
- Page 775 and 776:
intagliatori di Santa Maria del Fio
- Page 777 and 778:
Accrebbe poi in maggior eccellenza
- Page 779 and 780:
Francesco, et una impronta ne ha og
- Page 781 and 782:
in su due figure, cioè Sua Eccelle
- Page 783 and 784:
di San Giovanni, e nell’altra qua
- Page 785 and 786:
di Ioseffo, i quattro Evangelisti,
- Page 787 and 788:
secchi e d’ossame di morti, et ap
- Page 789 and 790:
sopra. E di questa sorte fece Franc
- Page 791 and 792:
appresso il Faetonte, il Tizio, il
- Page 793 and 794:
fonte; e si trae dietro legati come
- Page 795 and 796:
messer Marchionne sodisfattissimo,
- Page 797 and 798:
ellezza, perché dove si andava pri
- Page 799 and 800:
d’Austria, che dinanzi era Albert
- Page 801 and 802:
che il Papa teneva gran conto d’u
- Page 803 and 804:
Gostantino imperatore, et aveva, qu
- Page 805 and 806:
cose aiutato a lavorare. Onde non m
- Page 807 and 808:
mira, tutto tinto nel volto di colo
- Page 809 and 810:
Dopo queste opere dipinse Giulio a
- Page 811 and 812:
Peccati mortali ritratti dal detto
- Page 813 and 814:
Raffaello che a Michelagnolo. Ma no
- Page 815 and 816:
Aretino, e lo fece sì fatto che, o
- Page 817 and 818:
come quelli che, essendo universale
- Page 819 and 820:
l’aspetto et i modi suoi, attesoc
- Page 821 and 822:
ellissima, avendone un’altra a su
- Page 823 and 824:
grandissimo onor suo farsi conoscer
- Page 825 and 826:
fu cara tanto quanto s’e’ gli a
- Page 827 and 828:
Trevisi, il quale dipigneva una fac
- Page 829 and 830:
Roma si condusse; dove fattosi cono
- Page 831 and 832:
nell’ultimo della sua vita; il qu
- Page 833 and 834:
Sepolcro, che era cosa eccellente.
- Page 835 and 836:
medesima città, nella qual è di s
- Page 837 and 838:
da esso imperador domate e vinte. N
- Page 839 and 840:
tempera: essa Vergine presentata al
- Page 841 and 842:
era giovinetto, dal quale imparò G
- Page 843 and 844:
con una tempia fintamente insanguin
- Page 845 and 846:
Prassedia, fu posto nel mezzo di qu
- Page 847 and 848:
figure piccole, che sono ragionevol
- Page 849 and 850:
[II. 394] Raffaello legnaiuolo, sop
- Page 851 and 852:
ordine alla guerra et all’assedio
- Page 853 and 854:
QUIETEM RESTITUIT. L’altre furono
- Page 855 and 856:
accia e mezzo, e tanto pari e con b
- Page 857 and 858:
detti monti Asinaia e Falterona ven
- Page 859 and 860:
più vivo e più disideroso di glor
- Page 861 and 862:
che con favore, non pensavano al fa
- Page 863 and 864:
modo di condurla, se ne tornò a Fi
- Page 865 and 866:
un’agevolezza maravigliosa, la qu
- Page 867 and 868:
nel medesimo tempo fece un quadro p
- Page 869 and 870:
andato a Pinzirimonte, villa comper
- Page 871 and 872:
l’opera al vanto, scemò assai Ba
- Page 873 and 874:
che uccidesse Cacco per metterlo in
- Page 875 and 876:
croce, la quale fu opera rara, e la
- Page 877 and 878:
credere, ancorché indegno sia il b
- Page 879 and 880:
imperfetta e le statue in mano di d
- Page 881 and 882:
spesa invano, fatta così inconside
- Page 883 and 884:
icchezza di questo basamento, ne’
- Page 885 and 886:
parte delle statue che vi andavano.
- Page 887 and 888:
Giorgio lo mostrasse a Roma a Miche
- Page 889 and 890:
essendo giovinetto, il principio de
- Page 891 and 892:
l’ombre più crude, si venne a le
- Page 893 and 894:
male, più tosto stracciare, come f
- Page 895 and 896:
non le mura principali et il tetto,
- Page 897 and 898:
Santa Fiore de’ Monaci Neri, cio
- Page 899 and 900:
quale, avendo abbracciato Amore, lo
- Page 901 and 902:
Condusse dunque Cristofano in un ov
- Page 903 and 904:
tredici anni in Firenze e messo ne
- Page 905 and 906:
che fussero superati, dato del tutt
- Page 907 and 908:
disiderio di gloria e d’onore che
- Page 909 and 910:
Giovanmaria Benintendi, avendo quas
- Page 911 and 912:
entrano nelle capelle, in una figur
- Page 913 and 914:
perciò che se n’andava in ghirib
- Page 915 and 916:
Iacone, Pierfrancesco di Iacopo et
- Page 917 and 918:
e finiti, il tutto nondimeno è fuo
- Page 919 and 920:
di fogliami tutto traforato e pien
- Page 921 and 922:
Gualtieri, padre del vescovo di Vit
- Page 923 and 924:
Duca per far scene et apparati di c
- Page 925 and 926:
enissimo, come ne fa fede molte tav
- Page 927 and 928:
e del palazzo e residenza di detto
- Page 929 and 930:
compagno ad Antonio San Gallo, acci
- Page 931 and 932:
fussero chiamati con onoratissime c
- Page 933 and 934:
condurre a fine il campanile della
- Page 935 and 936:
gli tenevano nel palazzo del princi
- Page 937 and 938:
musico e de’ primi dell’accadem
- Page 939 and 940:
Giovannantonio da Verzelli, come eb
- Page 941 and 942:
imunerato di così bella pittura. O
- Page 943 and 944:
la barba, essendo già vecchio, e c
- Page 945 and 946:
Roma il fratello: con una parte de
- Page 947 and 948:
capricciose, né strade o lontani c
- Page 949 and 950:
trovare Perino, alla bella prima gl
- Page 951 and 952:
igata in sul canto de’ Medici, il
- Page 953 and 954:
tanto adoperò col sottomettersi e
- Page 955 and 956:
Modana per vedere l’altre opere d
- Page 957 and 958:
vagamente ridotte in diverse forme
- Page 959 and 960:
Ieronimo Mazzuoli, cugino di France
- Page 961 and 962:
maggiore che è in mezzo di detta c
- Page 963 and 964:
tavola in San Piero in Oliveto, che
- Page 965 and 966:
come s’è detto nella Vita di Bra
- Page 967 and 968:
si fugge. Sono di mano di Davitte n
- Page 969 and 970:
Campaccio, a una loro chiesetta, fe
- Page 971 and 972:
la caccia e l’uccellare dietro al
- Page 973 and 974:
vita, perciò che papa Paulo IV, pe
- Page 975 and 976:
a farsi di quest’opera se non qua
- Page 977 and 978:
vuole esser pittore, cominci ad ado
- Page 979 and 980:
questo si può fare giudizio che co
- Page 981 and 982:
alla sepoltura di Cristofano Fucche
- Page 983 and 984:
scorti, d’armadure, casamenti, ri
- Page 985 and 986:
fece alcune pitture ragionevoli, an
- Page 987 and 988:
cercarlo, quando vide colui averlo
- Page 989 and 990:
come aderenti, Andrea del Sarto dip
- Page 991 and 992:
farebbono lunga la nostra storia. F
- Page 993 and 994:
del vivere e regola loro, e tenendo
- Page 995 and 996:
d’Arezzo, intendendo che Girolamo
- Page 997 and 998:
principale della cappella fece un a
- Page 999 and 1000:
zampe schizza acqua in alto; e nel
- Page 1001 and 1002:
ell’orazione in lode di fra’ Gi
- Page 1003 and 1004:
Giovanni Polastra eccellente poeta
- Page 1005 and 1006:
Roma cosa alcuna notabile la quale
- Page 1007 and 1008:
fastidio il vivere di Vinezia a Fra
- Page 1009 and 1010:
lasciato pigliar piede et accommoda
- Page 1011 and 1012:
dell’altare, nella quale è un De
- Page 1013 and 1014:
altro. Ma per tornare alla tavola,
- Page 1015 and 1016:
Francesco di Girolamo dal Prato, in
- Page 1017 and 1018:
logge, e particolarmente vi fece mo
- Page 1019 and 1020:
studiando in un medesimo tempo i ca
- Page 1021 and 1022:
vergognose troppo disonestamente, f
- Page 1023 and 1024:
sapere d’aiuto più che tanto, tu
- Page 1025 and 1026:
pitture in uno studiolo a Pesaro, e
- Page 1027 and 1028:
Taddeo se ne tornò a Roma, e Feder
- Page 1029 and 1030:
che più attendeva al guadagno che
- Page 1031 and 1032:
parenti, arrivò finalmente in Roma
- Page 1033 and 1034:
quattro appartamenti, senza la part
- Page 1035 and 1036:
Parigi, Viseo, Morone, Badia, Trent
- Page 1037 and 1038:
Facciasi sorgere da una marina tran
- Page 1039 and 1040:
mezzo in giù sia sasso nero di col
- Page 1041 and 1042:
molte figure che si stanno nelle se
- Page 1043 and 1044:
Francesco ricevé le stìmate, dioc
- Page 1045 and 1046:
come era suo solito, gli disse: “
- Page 1047 and 1048:
Rovano franzese, disiderio di lasci
- Page 1049 and 1050:
Venne volontà ad Agnolo Doni, citt
- Page 1051 and 1052:
un Prigion sotto, qual’ sono oggi
- Page 1053 and 1054:
palazzo; et in questo modo pareva a
- Page 1055 and 1056:
d’aria e terribilità di cose var
- Page 1057 and 1058:
ancora è la storia delle Serpi di
- Page 1059 and 1060:
de’ Medici un modello delle fines
- Page 1061 and 1062:
Grato mi è il sonno, e più l’es
- Page 1063 and 1064:
Udine, divino, il quale per lo stuc
- Page 1065 and 1066:
che è stato superiore a tutti i su
- Page 1067 and 1068:
corso ne meni via chi cerca ritener
- Page 1069 and 1070:
ghiacere, antichi di marmo, sopra a
- Page 1071 and 1072:
Aveva il Vasari quell’anno finito
- Page 1073 and 1074:
casa; e gli ebbe tanto rispetto e r
- Page 1075 and 1076:
Vasari, come per più altre lettere
- Page 1077 and 1078:
Onde l’affettuosa fantasia, Che l
- Page 1079 and 1080:
l’imbasamento 18 grandissimi pila
- Page 1081 and 1082:
vede, basta aver così brevemente f
- Page 1083 and 1084:
onde tutti d’uno stesso volere ne
- Page 1085 and 1086:
È stata conosciuta la virtù di Mi
- Page 1087 and 1088:
vecchio, fino che faceva il Giudizi
- Page 1089 and 1090:
statue antiche”. Fu detto a Miche
- Page 1091 and 1092:
de’ Medici e dove è la maggior p
- Page 1093 and 1094:
L’essere stato veduto intorno a S
- Page 1095 and 1096:
dalle proprie mani e da tutta l’a
- Page 1097 and 1098:
Mausoleo d’Augusto in Roma; e for
- Page 1099 and 1100:
Vivens orbe peto laudibus aethera.
- Page 1101 and 1102:
statue, la Pittura, la Scultura e l
- Page 1103 and 1104:
partimenti di cornici, che hanno la
- Page 1105 and 1106:
si vede che ha imitato l’opere de
- Page 1107 and 1108:
Tiziano dunque, veduto il fare e la
- Page 1109 and 1110:
itratto dal vivo e senza artificio
- Page 1111 and 1112:
Aretino; ma non fu già questi sì
- Page 1113 and 1114:
è bellissimo. In Ancona, all’alt
- Page 1115 and 1116:
l’aver fama di bene e volentieri
- Page 1117 and 1118:
DESCRIZIONE DELL’OPERE DI IACOPO
- Page 1119 and 1120:
ancora un putto di stoppa et un cec
- Page 1121 and 1122:
facesse una grandissima chiesa e si
- Page 1123 and 1124:
et adornato quella Republica, ma ha
- Page 1125 and 1126:
due figure pure di marmo, molto gra
- Page 1127 and 1128:
i razzi solari attorno alla testa,
- Page 1129 and 1130:
una Benedizione della fonte del bat
- Page 1131 and 1132:
San Lorenzo per utilità publica; l
- Page 1133 and 1134:
per opera, si crede, di fra’ Gugl
- Page 1135 and 1136:
attesimo fu Giorgio Iulio. Attese d
- Page 1137 and 1138:
La quale opera fu condotta con tant
- Page 1139 and 1140:
Santo Alfonso vescovo: nei quali qu
- Page 1141 and 1142:
et altri, conobbi nel 1532 in Roma
- Page 1143 and 1144:
eccellentissimi scritti degl’arch
- Page 1145 and 1146:
che piovono sopra il popolo, con mo
- Page 1147 and 1148:
anni far manco bene che non hanno f
- Page 1149 and 1150:
considerazioni e giudizio, onde le
- Page 1151 and 1152:
Accademia alcun’altri giovani pit
- Page 1153 and 1154:
Tolledo al suo giardino di Fiorenza
- Page 1155 and 1156:
arissima. Nelli dua quadri di mezzo
- Page 1157 and 1158:
DESCRIZIONE DELLA PORTA AL PRATO [I
- Page 1159 and 1160:
alcuni poeti che latinamente avevan
- Page 1161 and 1162:
scherzando, altri di loro saettavan
- Page 1163 and 1164:
che rende tranquillissimo il mare,
- Page 1165 and 1166:
QUAMVIS, FLORA, TUIS, CELEBERRIMA,
- Page 1167 and 1168:
SED IAM NOX RUIT ET SIDERA CONCIDUN
- Page 1169 and 1170:
HEU DURIS SOLVIS, QUAE CLARUM CERNE
- Page 1171 and 1172:
trapassando alla predetta torre de
- Page 1173 and 1174:
E perché ciascuno degl’otto desc
- Page 1175 and 1176:
ardente fulmine. Ma sopra l’arco
- Page 1177 and 1178:
IMPERIIS AUXERE SUIS CERTAQUE SALUT
- Page 1179 and 1180:
antico tempio di Iano simigliante.
- Page 1181 and 1182:
IOANNES GUALBERTUS EQUES NOBILISS.
- Page 1183 and 1184:
Con l’istoria, similmente nella b
- Page 1185 and 1186:
cristiane azzioni esser bisognose e
- Page 1187 and 1188:
a seder posta era, seguitando di di
- Page 1189 and 1190:
le buccine a’ piedi sonando gli s
- Page 1191 and 1192:
dell’eccellentissimo Prin[II. 931
- Page 1193 and 1194:
porgere con l’una mano a un armat
- Page 1195 and 1196:
La quale fornita, e ciascuna delle
- Page 1197 and 1198:
Ma derivando dagl’inganni l’off
- Page 1199 and 1200:
Dunque, e tu, Psiche, scaccia L’a
- Page 1201 and 1202:
cose, che da noi contro a natura s
- Page 1203 and 1204:
ella e lucida Alba, con la biondiss
- Page 1205 and 1206:
messovi dentro una buona quantità
- Page 1207 and 1208:
capricciosi e bizarri oltre a modo
- Page 1209 and 1210:
come nell’altro si disse) si vede
- Page 1211 and 1212:
l’Anno, col capo tutto di ghiacci
- Page 1213 and 1214:
pastori con pelli di lupi rusticame
- Page 1215 and 1216:
ma forte e fiera a meraviglia e di
- Page 1217 and 1218:
CARRO UNDICESIMO DI VULCANO [II. 96
- Page 1219 and 1220:
giovani e vaghi Zete e Calai, figli
- Page 1221 and 1222:
CARRO DICIASSETTESIMO DI CIBELE Ma
- Page 1223 and 1224:
e tutta argentata navicella, che su
- Page 1225 and 1226:
terza, che forma di vitello aveva,
- Page 1227 and 1228:
morto mio padre di peste; il quale
- Page 1229 and 1230:
vi ebbi poco meno che a perdere il
- Page 1231 and 1232:
asso, oltre agl’Apostoli che sono
- Page 1233 and 1234:
passando fra le foglie dell’alber
- Page 1235 and 1236:
goffez[z]a di sesti. Nel che mi fur
- Page 1237 and 1238:
si vede la Pace abruciar l’arme,
- Page 1239 and 1240:
Fortuna, viene talvolta l’Invidia
- Page 1241 and 1242:
quell’orrendo spettacolo; e nell
- Page 1243 and 1244:
e Proserpina. In una camera maggior
- Page 1245 and 1246:
messo in tirare innanzi, da che pri
- Page 1247 and 1248:
far di nuovo e ridurre a miglior fo