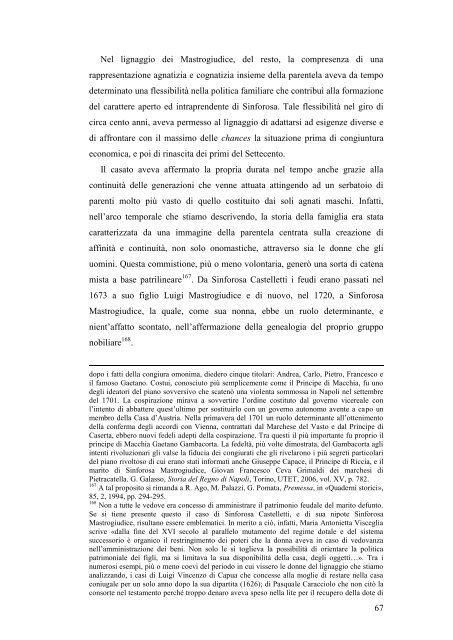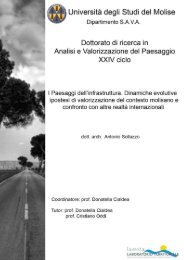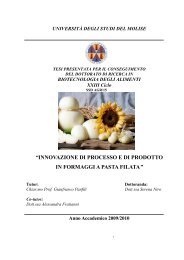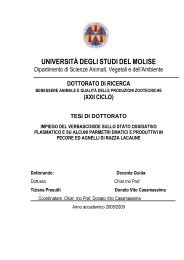Dipartimento di - Università degli Studi del Molise
Dipartimento di - Università degli Studi del Molise
Dipartimento di - Università degli Studi del Molise
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nel lignaggio dei Mastrogiu<strong>di</strong>ce, <strong>del</strong> resto, la compresenza <strong>di</strong> una<br />
rappresentazione agnatizia e cognatizia insieme <strong>del</strong>la parentela aveva da tempo<br />
determinato una flessibilità nella politica familiare che contribuì alla formazione<br />
<strong>del</strong> carattere aperto ed intraprendente <strong>di</strong> Sinforosa. Tale flessibilità nel giro <strong>di</strong><br />
circa cento anni, aveva permesso al lignaggio <strong>di</strong> adattarsi ad esigenze <strong>di</strong>verse e<br />
<strong>di</strong> affrontare con il massimo <strong>del</strong>le chances la situazione prima <strong>di</strong> congiuntura<br />
economica, e poi <strong>di</strong> rinascita dei primi <strong>del</strong> Settecento.<br />
Il casato aveva affermato la propria durata nel tempo anche grazie alla<br />
continuità <strong>del</strong>le generazioni che venne attuata attingendo ad un serbatoio <strong>di</strong><br />
parenti molto più vasto <strong>di</strong> quello costituito dai soli agnati maschi. Infatti,<br />
nell’arco temporale che stiamo descrivendo, la storia <strong>del</strong>la famiglia era stata<br />
caratterizzata da una immagine <strong>del</strong>la parentela centrata sulla creazione <strong>di</strong><br />
affinità e continuità, non solo onomastiche, attraverso sia le donne che gli<br />
uomini. Questa commistione, più o meno volontaria, generò una sorta <strong>di</strong> catena<br />
mista a base patrilineare 167 . Da Sinforosa Castelletti i feu<strong>di</strong> erano passati nel<br />
1673 a suo figlio Luigi Mastrogiu<strong>di</strong>ce e <strong>di</strong> nuovo, nel 1720, a Sinforosa<br />
Mastrogiu<strong>di</strong>ce, la quale, come sua nonna, ebbe un ruolo determinante, e<br />
nient’affatto scontato, nell’affermazione <strong>del</strong>la genealogia <strong>del</strong> proprio gruppo<br />
nobiliare 168 .<br />
dopo i fatti <strong>del</strong>la congiura omonima, <strong>di</strong>edero cinque titolari: Andrea, Carlo, Pietro, Francesco e<br />
il famoso Gaetano. Costui, conosciuto più semplicemente come il Principe <strong>di</strong> Macchia, fu uno<br />
<strong>degli</strong> ideatori <strong>del</strong> piano sovversivo che scatenò una violenta sommossa in Napoli nel settembre<br />
<strong>del</strong> 1701. La cospirazione mirava a sovvertire l’or<strong>di</strong>ne costituto dal governo vicereale con<br />
l’intento <strong>di</strong> abbattere quest’ultimo per sostituirlo con un governo autonomo avente a capo un<br />
membro <strong>del</strong>la Casa d’Austria. Nella primavera <strong>del</strong> 1701 un ruolo determinante all’ottenimento<br />
<strong>del</strong>la conferma <strong>degli</strong> accor<strong>di</strong> con Vienna, contrattati dal Marchese <strong>del</strong> Vasto e dal Principe <strong>di</strong><br />
Caserta, ebbero nuovi fe<strong>del</strong>i adepti <strong>del</strong>la cospirazione. Tra questi il più importante fu proprio il<br />
principe <strong>di</strong> Macchia Gaetano Gambacorta. La fe<strong>del</strong>tà, più volte <strong>di</strong>mostrata, <strong>del</strong> Gambacorta agli<br />
intenti rivoluzionari gli valse la fiducia dei congiurati che gli rivelarono i più segreti particolari<br />
<strong>del</strong> piano rivoltoso <strong>di</strong> cui erano stati informati anche Giuseppe Capace, il Principe <strong>di</strong> Riccia, e il<br />
marito <strong>di</strong> Sinforosa Mastrogiu<strong>di</strong>ce, Giovan Francesco Ceva Grimal<strong>di</strong> dei marchesi <strong>di</strong><br />
Pietracatella. G. Galasso, Storia <strong>del</strong> Regno <strong>di</strong> Napoli, Torino, UTET, 2006, vol. XV, p. 782.<br />
167<br />
A tal proposito si rimanda a R. Ago, M. Palazzi, G. Pomata, Premessa, in «Quaderni storici»,<br />
85, 2, 1994, pp. 294-295.<br />
168<br />
Non a tutte le vedove era concesso <strong>di</strong> amministrare il patrimonio feudale <strong>del</strong> marito defunto.<br />
Se si tiene presente questo il caso <strong>di</strong> Sinforosa Castelletti, e <strong>di</strong> sua nipote Sinforosa<br />
Mastrogiu<strong>di</strong>ce, risultano essere emblematici. In merito a ciò, infatti, Maria Antonietta Visceglia<br />
scrive «dalla fine <strong>del</strong> XVI secolo al parallelo mutamento <strong>del</strong> regime dotale e <strong>del</strong> sistema<br />
successorio è organico il restringimento dei poteri che la donna aveva in caso <strong>di</strong> vedovanza<br />
nell’amministrazione dei beni. Non solo le si toglieva la possibilità <strong>di</strong> orientare la politica<br />
patrimoniale dei figli, ma si limitava la sua <strong>di</strong>sponibilità <strong>del</strong>la casa, <strong>degli</strong> oggetti…». Tra i<br />
numerosi esempi, più o meno coevi <strong>del</strong> periodo in cui vissero le donne <strong>del</strong> lignaggio che stiamo<br />
analizzando, i casi <strong>di</strong> Luigi Vincenzo <strong>di</strong> Capua che concesse alla moglie <strong>di</strong> restare nella casa<br />
coniugale per un solo anno dopo la sua <strong>di</strong>partita (1626); <strong>di</strong> Pasquale Caracciolo che non citò la<br />
consorte nel testamento perché troppo denaro aveva speso nella lite per il recupero <strong>del</strong>la dote <strong>di</strong><br />
67