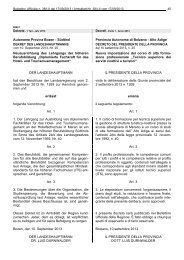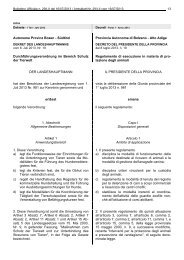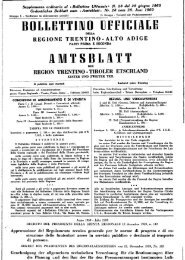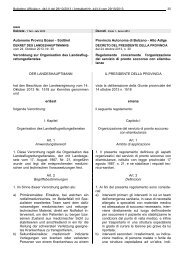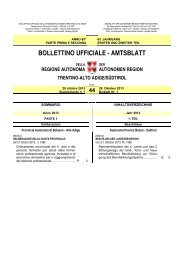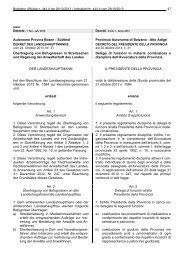[84117] Supplemento n. 1 al Bollettino n. 17 del 23/04/2013
[84117] Supplemento n. 1 al Bollettino n. 17 del 23/04/2013
[84117] Supplemento n. 1 al Bollettino n. 17 del 23/04/2013
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Supplemento</strong> n. 1 <strong>al</strong> B.U. n. <strong>17</strong>/I-II <strong>del</strong> <strong>23</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong> / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom <strong>23</strong>/<strong>04</strong>/<strong>2013</strong> Nr. <strong>17</strong>/I-II 86<br />
Per<strong>al</strong>tro ci sono state conversione a fini turistico-ricreativi di superfici precedentemente<br />
forestate (si pensi <strong>al</strong>l’area ricreativa circostante il Rifugio Potzmauer recentemente<br />
ampliata).<br />
Negli epoc<strong>al</strong>i processi morfogenetici i ghiacciai quaternari hanno generato morfologie<br />
dolci ed ondulate, in corrispondenza <strong>del</strong>lo spartiacque princip<strong>al</strong>e, più sotto, le dinamiche<br />
fluvi<strong>al</strong>i hanno formato gli ampi terrazzamenti (centri abitati e colture agrarie) ed infine<br />
profonde incisioni <strong>del</strong> profilo (a V).<br />
La pendenza elevata <strong>del</strong> medio versante ha favorito la destinazione prettamente<br />
forest<strong>al</strong>e (di limitata importanza economica se non nei limiti <strong>del</strong>la produzione di<br />
combustibile) mentre sulle zone ondulate sommit<strong>al</strong>i il bosco, come anzidetto, ha insidiato<br />
e spesso conquistato un territorio un tempo intensamente utilizzato anche <strong>al</strong>lo sf<strong>al</strong>cio.<br />
Anche qui come nei territori visti di Faver e V<strong>al</strong>da, la geologia è caratterizzata da una<br />
sostanzi<strong>al</strong>e omogeneità dei substrati derivanti d<strong>al</strong>la Piattaforma Porfirica Atesina: porfidi<br />
quarziferi, coperti da depositi glaci<strong>al</strong>i o detritici indistinti, (ripiani di V<strong>al</strong>donega). La<br />
sostituzione degli originari popolamenti misti di latifoglie (aceri, faggio, quercia<br />
soprattutto), con popolamenti di sole conifere (pino silvestre, larice e abete rosso)<br />
unitamente <strong>al</strong>le varie attività legate <strong>al</strong>l’uso civico, ha determinato in parte una perdita di<br />
fertilità e una pedogenesi orientata <strong>al</strong>la formazione di suoli bruni lisciviati o podsolizzati,<br />
da superfici<strong>al</strong>i a medio profondi gener<strong>al</strong>mente sabbiosi e sciolti, ricchi di scheletro ed a<br />
reazione tendenzi<strong>al</strong>mente acida, con humus ricco, inquadrabile nel tipo moder<br />
zoogenico. I suoli più freschi e profondi si riscontrano lungo gli impluvi princip<strong>al</strong>i e in<br />
esposizione nord-ovest, a nord-est (aridità edafica e contenuta fertilità sui crin<strong>al</strong>i).<br />
I boschi che occupano la fascia inferiore, orientativamente fra il fondov<strong>al</strong>le e i 1000 m<br />
s.l.m., rientrano nella zona fitoclimatica <strong>del</strong> castagno (Castanetum freddo) ma il territorio<br />
forest<strong>al</strong>e comun<strong>al</strong>e rientra per lo più nella zona <strong>del</strong> faggio (Fagetum). Ovvero nel cingolo<br />
Fagus-Abies (faggio, in misura minore abete bianco, mescolati <strong>al</strong>l’abete rosso), e<br />
Quercus-Tilia-Acer (quote collinari e submontane, esposizione prev<strong>al</strong>entemente sud, con<br />
castagno, carpino nero, orniello e roverella). È bene ripetere che la larga diffusione di<br />
pino silvestre e larice non qu<strong>al</strong>ifica <strong>al</strong>cun distretto fitoclimatico, ma riflette le passate<br />
forme di uso <strong>del</strong> suolo (pascolo in bosco), gli incendi boschivi, le caratteristiche stazion<strong>al</strong>i<br />
(fertilità, superfici<strong>al</strong>ità <strong>del</strong> suolo, aridità, ecc.).<br />
La formazione vegetazion<strong>al</strong>e più diffusa, speci<strong>al</strong>mente sulle dors<strong>al</strong>i più asciutte e<br />
soleggiate, facilmente accessibili ed oggetto di un’elevata pressione antropica, è la<br />
pineta di pino silvestre silicicola tipica, con ampi tratti puri di pino silvestre o con diffusa<br />
mescolanza di abete rosso e larice e con netta tendenza evolutiva verso formazioni ad<br />
elevata partecipazione <strong>del</strong> faggio (diffusamente presente nel piano dominato ma che<br />
nelle stazioni a fertilità migliore volge a fustaia); lo strato arbustivo, data la scarsa<br />
copertura esercitata d<strong>al</strong> pino, è molto denso ed è composto da specie arboree ridotte ad<br />
un portamento cespuglioso a causa <strong>del</strong>la sistematica ceduazione; fra queste sono<br />
presenti la rovere, il castagno, la betulla, il s<strong>al</strong>icone, il pioppo tremolo e l’orniello, il<br />
nocciolo, il maggiociondolo, il ginepro comune, il pero corvino e il crespino; lo strato<br />
suffruticoso è ovunque presente con uno strato t<strong>al</strong>volta continuo ad Erica carnea L.,<br />
Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L., nelle stazioni aride e meno evolute; felce<br />
aquilina e graminoidi nelle <strong>al</strong>tre.<br />
82


![[84117] Supplemento n. 1 al Bollettino n. 17 del 23/04/2013](https://img.yumpu.com/16038901/85/500x640/84117-supplemento-n-1-al-bollettino-n-17-del-23-04-2013.jpg)