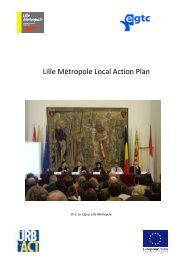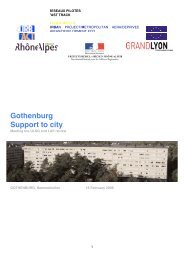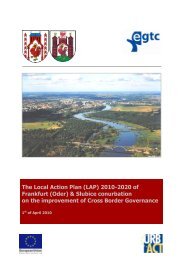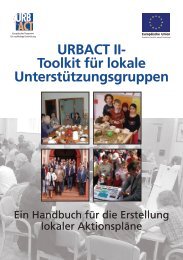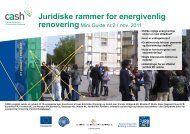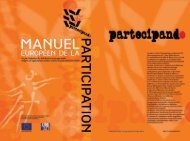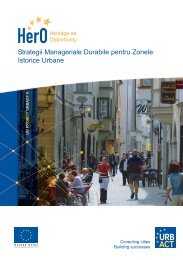VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO - Urbact
VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO - Urbact
VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO - Urbact
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>VERSO</strong> <strong>IL</strong> <strong>SECONDO</strong> <strong>PIANO</strong> <strong>STRATEGICO</strong> INNOVAZIONE E SV<strong>IL</strong>UPPO: ASSI, FATTORI E PROGETTI<br />
3.1 Produzione culturale e alta formazione<br />
Far propria una cultura della continuità significa non disperdere l’enorme patrimonio progettuale accumulato in<br />
questa fase ed evitare di ripartire ogni volta dalle analisi dello status quo, azzerando quel piccolo o grande capitale<br />
di conoscenze accumulato dai predecessori, senza per questo rinunciare a quella “permeabilità” indispensabile<br />
per raccogliere ogni altro tema di riflessione eventualmente maturato.<br />
Per dirla con Marc Fumaroli 1 , che nel suo ultimo saggio sulla celeberrima disputa fra gli antichi e i moderni riprende<br />
la fortunata metafora di Swift, significa fare come i ragni che “traggono da sé stessi, dalle proprie viscere” il<br />
materiale con cui tessono la propria tela, invece che come le api che “bottinando da fiore a fiore” producono il<br />
miele per il proprio alveare, laddove la varietà dei pollini sta a significare la pluralità delle esperienze preesistenti<br />
su cui si fonda la produzione del nuovo.<br />
Passare “dal progetto al processo” significa spostare l’attenzione sugli strumenti e sui metodi di pianificazione<br />
strategica anche allo scopo di imprimere un’accelerazione a quei processi di attuazione – in parte già avviati, in<br />
parte pronti per esserlo – che trasformano una serie di progetti in fatti concreti, capaci di contribuire al rinnovamento<br />
della città.<br />
Un rinnovamento, nel caso specifico dei progetti culturali, non solo del volto – dell’immagine della città, che pure<br />
non è elemento trascurabile – ma anche del suo corpo vivo, fatto di attività, di saperi, di capacità attrattiva non<br />
solo turistica, di ricadute sul tessuto sociale ed economico, di aspettative per le nuove generazioni, di ruolo internazionale<br />
nello scenario futuro, tutto giocato sull’economia della conoscenza, insomma in una parola: del destino<br />
di questa città.<br />
Già nel documento di diagnosi del primo Piano Strategico (Progettare Firenze, cap. 6) sono evidenziati con precisione<br />
i punti maggiormente critici ed indicate le ricette appropriate. In primo luogo quando si sottolinea la<br />
necessità di “porre fine alla contraddizione tra l’operare costante di un’intensa e ambiziosa progettualità e la marginalità<br />
delle realizzazioni concrete” o quando rileva l’antagonismo tra “consumo” e “produzione” culturali, con<br />
una netta prevalenza del primo sulla seconda, prevalenza determinata da scelte mirate al potenziamento dell’economia<br />
basata sul turismo, che trova il suo fondamento e a sua volta rafforza l’immagine della “città d’arte” oramai<br />
internazionalmente invalsa, a scapito delle altre “aree d’eccellenza e numerosi aspetti qualificanti delle vocazioni<br />
storiche di Firenze”.<br />
Da questa premessa deriva necessariamente la volontà di procedere, quale obbiettivo prioritario da tutti condiviso<br />
per un’azione strategica di rilancio della città e del suo territorio, al riequilibrio tra consumo e produzione<br />
culturale, quale asset fondamentale per il rilancio del ruolo di Firenze quale “luogo di elaborazione di modelli<br />
culturali, di sviluppo, di ricerche avanzate e come deposito continuamente arricchito di memorie rilevanti non<br />
solo nelle arti, ma anche nelle scienze e nelle tecniche, nelle discipline dell’uomo e della società”.<br />
Occorre anche ribadire la necessità, per perseguire con qualche efficacia tale obiettivo, di forti investimenti pubblici,<br />
attraverso l’individuazione di meccanismi di redistribuzione delle risorse prodotte dallo sfruttamento turistico<br />
intensivo della città (tasse di scopo, reintroduzione di tasse di soggiorno, promozione di leggi speciali sulla<br />
manutenzione delle città d’arte, etc.) oltre che del coinvolgimento, non soltanto a livello economico – di soggetti<br />
privati per l’intervento dei quali occorrerebbe favorire al massimo misure legislative volte alla detrazione fiscale<br />
di tali contributi. In entrambi questi settori Firenze, può farsi capofila di un movimento di pressione su Governo<br />
e Parlamento affinché vengano affrontate le problematiche relative alle città d’arte sottoposte alla pressione di<br />
flussi turistici in crescita costante.<br />
Una politica volta a contrastare il degrado della città non può prescindere dall’aspetto culturale: come è stato più<br />
volte rilevato, c’è una tendenza che porta alla chiusura di cinema, teatri, librerie e all’esodo di tanti giovani talenti,<br />
studiosi ricercatori, artisti. All’immigrazione, spesso clandestina, degli uni corrisponde l’emigrazione, quasi<br />
sempre nell’indifferenza, dunque anch’essa clandestina, degli altri, la cosiddetta “fuga dei cervelli”. Al di là delle<br />
evidenti differenze sociali c’è qualcosa che li accomuna: la speranza in un altrove migliore. Quell’altrove che<br />
Firenze per secoli ha rappresentato, attirando qui le migliori intelligenze nei vari settori dell’arte e della cultura<br />
umanistica e scientifica e che purtroppo da qualche decennio rappresenta sempre meno.<br />
Recuperare quella capacità attrattiva è condizione imprescindibile se si vuole invertire questa tendenza verso<br />
un “dorato declino” cui è destinata la città se rimane ancorata all’immagine di “città d’arte”, “Disneyland del<br />
Rinascimento”, parco tematico riservato a un turismo sempre più vorace e distruttivo. Occorre una comunicazione<br />
mirata a promuovere a livello internazionale, accanto alle meraviglie della città d’arte, le enormi potenzialità<br />
offerte dai numerosi centri d’eccellenza nei vari settori della ricerca e della formazione – dai vari centri di ricerca<br />
1 Fumaroli M., Le Api e i Ragni. La disputa degli Antichi e dei Moderni, Adelphi, 2005