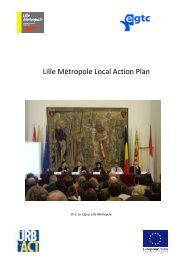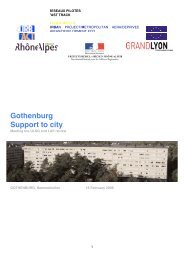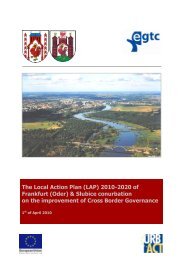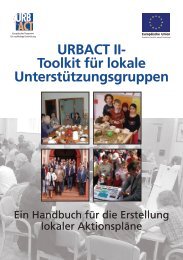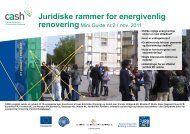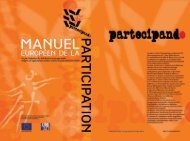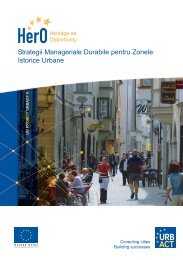VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO - Urbact
VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO - Urbact
VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO - Urbact
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>VERSO</strong> <strong>IL</strong> <strong>SECONDO</strong> <strong>PIANO</strong> <strong>STRATEGICO</strong> INNOVAZIONE E SV<strong>IL</strong>UPPO: ASSI, FATTORI E PROGETTI<br />
3.2 Attività produttive e manifattura di qualità<br />
Il passaggio dalla città accentrata a quella diffusa sul territorio è in molta parte causa del cambiamento della<br />
base produttiva della città, dalla produzione di tipo industriale a quella di tipo terziario. A partire dalla metà degli<br />
anni ’70 l’evoluzione tecnologica, il miglioramento dei trasporti, la maggiore infrastrutturazione del territorio e<br />
l’emergere di diseconomie crescenti nelle principali aree urbane hanno spinto all’affermazione di nuove produzioni<br />
e alla ricollocazione territoriale di quelle tradizionali. In generale, si è verificato un lento ma inesorabile processo<br />
di terziarizzazione (o deindustrializzazione) dell’economia, che ha trovato punte particolarmente elevate<br />
nelle città, che hanno perso molte attività manifatturiere a favore dei comuni periurbani. Non tutte le attività<br />
manifatturiere, tuttavia, ubbidiscono alla “legge” del decentramento, in quanto per determinati settori produttivi<br />
(si pensi alle attività a maggior contenuto di innovazione) restano fondamentali i vantaggi della centralità (rapporti<br />
con altre imprese, con i centri di ricerca, maggiore vicinanza ai servizi). La stessa evoluzione “duale” è stata<br />
sperimentata dalle attività terziarie, per le quali, a fronte di tendenze diffusive dei servizi di massa banali (o a forte<br />
consumo di suolo, come i grandi centri commerciali), si sono registrati fenomeni di agglomerazione relativi ai servizi<br />
a più alta specializzazione.<br />
La peculiarità del capoluogo fiorentino è quella di continuare ad affiancare ad una crescente caratterizzazione<br />
terziaria e commerciale una presenza industriale di tutto rispetto, se paragonata a quella degli altri comuni centrali<br />
di aree metropolitane, anche se in continuo decremento 2 . Lo stesso si può dire per i comuni della cintura,<br />
specialmente per quelli occidentali.<br />
Semplificando molto, la corona urbana intorno a Firenze può essere distinta, anche dal punto di vista funzionale,<br />
in due parti: i comuni occidentali più influenzati dal modello di sviluppo distrettuale (non a caso fanno da cerniera<br />
tra Firenze e Prato), in cui pesano ancora molto le attività manifatturiere e in cui si è assistito recentemente<br />
alla localizzazione di attività produttive a forte consumo di suolo (in primo luogo i grandi centri commerciali,<br />
ma non solo); i comuni di fascia orientale il cui sviluppo è avvenuto in tempi relativamente più recenti e in cui<br />
più marcato è stato il peso delle funzioni residenziali e terziarie diverse dal commercio (intermediazione monetaria,<br />
professioni, informatica, R&S). I comuni occidentali possono essere considerati a buon diritto esempi di<br />
quelle “fasce di transito” tra aree rurali e aree urbane in cui è avvenuto gran parte dello sviluppo regionale del<br />
passato e in cui ancora oggi si trovano i segnali di una maggiore vitalità. Nel complesso, tuttavia, tutta l’area fiorentina<br />
può essere considerata uno dei principali motori dello sviluppo regionale, come mostrano gli indicatori<br />
relativi alla capacità produttiva (P<strong>IL</strong>), alla dinamicità (investimenti) e alla penetrazione sui mercati esteri (esportazioni)<br />
(tab. 3.9).<br />
Tabella 3.9 PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI. Valori pro capite Toscana=100<br />
Fonte: stime Irpet, 2000 e 2005<br />
Le attività manifatturiere<br />
Confrontando il numero degli addetti manifatturieri al 1991 e al 2001 si evidenzia il proseguire del processo di<br />
deindustrializzazione dell’area fiorentina nel suo complesso (-12%) e di Firenze in particolare (-24%). Cresce inoltre<br />
il peso manifatturiero dei comuni della corona sul totale dell’area: assorbivano il 53% degli addetti nel 1991<br />
e ne assorbono il 59% nel 2001. I comuni in cui la presenza manifatturiera si mantiene su buoni livelli e continua<br />
a crescere sono quelli di fascia occidentale: Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino (tab. 3.10). Dati più<br />
recenti, relativi al 2005 (Istat, Archivio Asia) confermano le tendenze già rilevate e cioè la progressiva riduzione<br />
degli addetti manifatturieri e la crescita della loro concentrazione territoriale nei comuni suburbani occidentali:<br />
Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino ospitano da soli il 40% degli addetti manifatturieri di tutta l’area<br />
metropolitana fiorentina.<br />
2 Al 2001, Firenze mostra una quota di addetti all’industria pari al<br />
17% del totale contro il 16% negli altri grandi comuni, ma anche<br />
una quota di addetti al commercio pari al 24% del totale contro<br />
il 19%. Pesa relativamente meno, dunque, il resto del terziario:<br />
59% contro 64%.