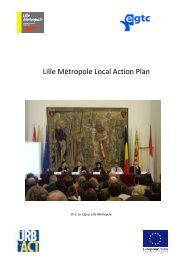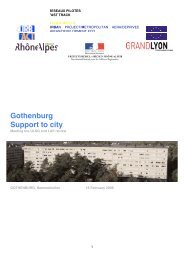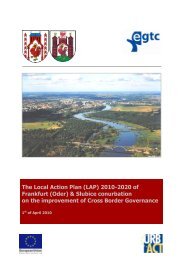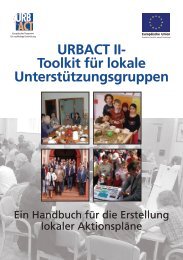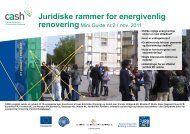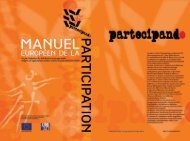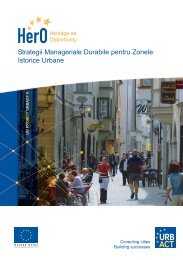VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO - Urbact
VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO - Urbact
VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO - Urbact
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>VERSO</strong> <strong>IL</strong> <strong>SECONDO</strong> <strong>PIANO</strong> <strong>STRATEGICO</strong> INNOVAZIONE E SV<strong>IL</strong>UPPO: ASSI, FATTORI E PROGETTI<br />
per un recupero e una rinnovata funzione sociale nel tessuto urbano. Molti sarebbero gli esempi da citare in<br />
proposito, dal Lingotto di Torino, all’Ansaldo a Milano, dall’India di Roma, alle aree del tessile a Cardiff, al porto di<br />
Valencia, al Guggenhaim di Bilbao, fino al più recente intervento della Fabbrica del Pane a Bologna.<br />
In tutti questi, e nei molti altri casi che potremmo analizzare, però possiamo rilevare almeno tre elementi trainanti<br />
che ne hanno reso possibile la realizzazione in tempi relativamente rapidi:<br />
- Una localizzazione strategica, capace non solo di cambiare realmente il volto di interi pezzi di città, fungendo<br />
da volano per un ridisegno completo delle aree dove vanno ad insistere, mutandone spesso l’identità, ma anche<br />
di esercitare una forte capacità attrattiva sui flussi turistici.<br />
- Un forte rapporto tra contenuto e contenitore – sia quando quest’ultimo sia progettato ex novo (come ad es.<br />
nel caso di Bilbao), sia quando conservi in tutto o in parte la struttura originaria – che che si traduce in una<br />
profonda consapevolezza della necessità di quel determinato intervento in quel preciso contesto urbano.<br />
- Infine, condizione imprescindibile, una forte condivisione del progetto fra tutti gli attori coinvolti, che si traduce<br />
in volontà politica e capacità di mobilitare ingenti risorse pubbliche e/o private.<br />
Ora, pare evidente dopo quasi un trentennio, che, nel caso del Meccanotessile, queste condizioni non si siano<br />
verificate se non in maniera parziale e sporadica.<br />
Lotti di lavori succedutisi con ingente impiego di risorse si sono alternati a periodi di abbandono, in assenza di<br />
un vero progetto che ne guidasse la razionalità. In origine Museo d’Arte Contemporanea, poi Centro,<br />
Laboratorio, spazio per residenze d’artista, luogo di formazione, senza rendersi conto che l’incertezza circa i contenuti<br />
si traduceva in vuoto progettuale, sino a giungere ad affidare agli uffici tecnici comunali un piano di recupero<br />
“polivalente”, dunque anonimo e anodino.<br />
Per non parlare dell’area circostante, di cui il Centro d’Arte doveva essere il cuore pulsante, portata a saturazione<br />
con lottizzazioni di dubbia qualità architettonica e scarsa integrazione funzionale.<br />
Nel frattempo sono accadute molte cose nel campo dell’arte contemporanea. Il forte ruolo conquistato negli<br />
anni di Barzel dal Museo Pecci, seguiti da un altrettanto forte e profonda crisi di cui solo ora si immagina la via<br />
d’uscita, l’affermarsi in regione di nuove realtà, come la Fondazione Celle e Palazzo Fabroni a Pistoia, il Palazzo<br />
delle Papesse a Siena, la Fondazione Ragghianti a Lucca, vari percorsi e iniziative in zone più decentrate come il<br />
Chianti e la Val d’Orcia.<br />
Alcuni tentativi più o meno episodici hanno avuto luogo anche a Firenze e con notevole successo, con interventi<br />
alla ex Manifattura Tabacchi (Sboom nel 2001, promosso dalla Camera di Commercio), la riapertura – fortemente<br />
voluta da Franco Camarlinghi e durata purtroppo solo per un anno – del Forte Belvedere da parte di Firenze<br />
Mostre, con la grande mostra Orizzonti curata da Achille Bonito Oliva, il nuovo spazio Quarter realizzato<br />
dall’Unicoop in Gavinana e diretto da Sergio Risaliti, alcune installazioni alla Stazione Leopolda in occasione di<br />
Fabbrica Europa e altre iniziative più o meno episodiche.<br />
Da queste esperienze scaturisce un forte segnale che andrebbe recepito con attenzione se si vuole affrontare<br />
con lucidità e concretezza il tema dell’arte contemporanea a Firenze e nell’area metropolitana. Un segnale che<br />
spinge nella direzione di un modello reticolare le cui maglie vadano a costituire un sistema che sia assolutamente<br />
permeabile ed in costante dialogo con le circostanti presenze dell’arte “storicizzata” e della vita culturale della<br />
città.<br />
Solo così si può sperare nella piena cittadinanza di un discorso il cui statuto linguistico cerca ogni giorno la propria<br />
legittimazione a partire dal confronto e dalla messa in discussione dello status quo. Questo ci insegnarono<br />
con forza dirompente le opere di Henry Moore sul terrazzo del Forte Belvedere, sul fondale prospettico della<br />
Basilica di Santa Croce o della Cupola del Brunelleschi.<br />
Firenze non necessita di un contenitore eclatante “alla Gehry”, capace di per sé di riconvertire l’immagine di una<br />
città come Bilbao. È possibile immaginare un sistema vitale, fatto di luoghi diversi e complementari, dove pubblico<br />
e privato possano trovare motivazioni di incontro nel reciproco rispetto dei ruoli, e dove far crescere quella<br />
cultura del contemporaneo che a Firenze, come ovunque, non è assente, solo assopita da troppi anni di inutile<br />
attesa.<br />
Un sistema che parta dalla valorizzazione e dal potenziamento delle esperienze fatte, individuando per ciascuno<br />
spazio la propria missione a partire dalla vocazione. Quindi in primis il Forte, forte appunto di una tradizione trentennale<br />
votata principalmente alla scultura e alla “monumentalità” contemporanea; poi Quarter uno spazio nato<br />
e subito “esploso” con un’attività di grande livello dal timbro provocatorio, proprio di una Kunsthalle e fortemente<br />
coinvolgente per tutto l’ambiente cittadino. Attività attualmente sospesa e in attesa di un riavvio da più parti<br />
sollecitato E ancora la Fondazione Palazzo Strozzi, con i suoi spazi al piano interrato, per un lavoro più didattico<br />
e di documentazione; la Stazione Leopolda, con Fabbrica Europa e Pitti Immagine per i rapporti dell’arte contemporanea<br />
con i linguaggi della scena o della moda; il Museo Alinari alle Leopoldine, per la fotografia.