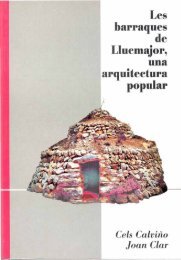Patrimoni de marjades a la mediterrània occidental: una proposta ...
Patrimoni de marjades a la mediterrània occidental: una proposta ...
Patrimoni de marjades a la mediterrània occidental: una proposta ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
...••......•... '<br />
V\T7<br />
-,---,- ~. .<br />
164. Carta geomorfologia <strong>de</strong>l versante di Vo<strong>la</strong>stra:<br />
1. Pareti, nicchie di distacca, superfici di scivo<strong>la</strong>mento <strong>de</strong>nudate 0<br />
parzialmentecaperti da caltri sottili; 2. Coltri <strong>de</strong>tritiche sistemate a terrazze<br />
prevalentemente in abbandono in condizioni di instabilita diffusa; 3. Coltri<br />
<strong>de</strong>tritiche sistemate a terrazze caltivate a vigneti (a) e a uliveti (b), in<br />
candizioni di prevalente stabilita, 4. Spiagge ciottolose; 5. Conoidi <strong>de</strong>tritici<br />
(a) e caltri in lento movimento (b); 6. Cigli di distacco attivi in roccia; 7.<br />
Cigli di distacca quiescenti in roccia; 8. Orli di terrazzi; 9. Erosione<br />
concentrata; 10. Spiagge in erosione; 11. Falesia viva. Nel riquadro,<br />
schema geologico: Complesso di Canetolo (A); Macigno (B). (da<br />
BRANDOLlNI, P;. TERRANOVA, R, 1996).<br />
165. Fasi di dissesto <strong>de</strong>lle terrazze nelle aree abbandonate:<br />
1. rigonfiamento <strong>de</strong>l muro per spinta centrale; 2. ribaltamento per spinta<br />
alia sommita; 3. dissesto per slittamento <strong>de</strong>i blocchi; 4. scivo<strong>la</strong>mento per<br />
spinta alia base; 5. dissesto e franamento <strong>de</strong>lle scarpate a zolle erbose; 6.<br />
dissesto totale su un versante; 7. superfici di taglio e di scarrimento (S1-<br />
S2-S3) nelle aree sostenute da muri a secca (da TERRANOVA, R., 1994).<br />
<strong>de</strong>nze si attenuano ed il versante si fa piG morbi do (DE STE-<br />
FANIS,A. et al., 1978; TERRANOVA, R., 1984, 1987).<br />
I fenomeni erosivi e di dissesto, che per Ie sud<strong>de</strong>tte<br />
condizioni geologiche e geomorfologiche hanno da sempre<br />
interessato questi versanti, hanno avuto <strong>una</strong> partico<strong>la</strong>re<br />
evoluzione in tempi recenti con intensi processi di riattivazione<br />
con <strong>la</strong> formazione di numerose lizze di frana che<br />
hanno interessato sia <strong>la</strong> coltre terrigena di copertura sia il<br />
substrato roccioso arenaceo (Fig. 163 e 165).<br />
In un contesto fisico <strong>de</strong>cisamente ostile all'insediamento<br />
<strong>de</strong>ll'uomo come quello <strong>de</strong>lle Cinque Terre, non esiste in<br />
reaIta lembo di territorio in cui non siano presenti tracce<br />
<strong>de</strong>ll'azione umana che, intrecciandosi e sovrapponendosi,<br />
sono riuscite a creare un tipo di paesaggio unico al<br />
mondo. Decodificare il paesaggio <strong>de</strong>lle Cinque Terre<br />
significa quindi ricostruire Ie motivazioni che lungo i<br />
secoli hanno spinto e costretto I'uomo a cercare soluzioni<br />
sempre differenti per poter sopravvivere.<br />
Le prime notizie certe sugli insediamenti <strong>de</strong>lia zona,<br />
data <strong>la</strong> scarsita di reperti archeologici e <strong>la</strong> mancanza di<br />
notizie per I'eta romana e alto-medievale, si possono collocare<br />
attorno al Mille quando per <strong>la</strong> prima volta i documenti<br />
nomina no Monterosso e Vernazza, che erano probabilmente<br />
piccole basi marittime anti-saracene. I due borghi<br />
costieri peraltro (a cui si aggiunse nel XIII secolo quello<br />
di Riomaggiore) i cui nuclei originari erano lievemente arretrati<br />
rispetto alia posizione attuale, si svilupparono in collegamento<br />
con i grandi feudi <strong>de</strong>ll'entroterra di cui costituiyanG<br />
10 sbocco al mare, mentre i borghi piG a oriente (Vo<strong>la</strong>stra,<br />
Corniglia, Manaro<strong>la</strong>) avevano <strong>una</strong> piG spiccata vocazione<br />
agrico<strong>la</strong>. Si riferiscono a questa periodo i primi cenni<br />
alia coltivazione <strong>de</strong>lia vite da cui si traeva un vino ben<br />
presto nota ed esportato in tutta Europa.<br />
II primo ad usare il toponimo collettivo di Cinque Terre per<br />
indicare il comprensorio che fa capo a Monterosso, Vernazza,<br />
Corniglia, Manaro<strong>la</strong> e Riomaggiore, fu nel XV secolo<br />
Jacopo Bracelli (1418) che individu6 I'elemento discriminante<br />
tra questi borghi e quelli contermini proprio nel<strong>la</strong> produzione<br />
di vino il cui commercio, che si effettuava quasi esclusivamente<br />
per via di mare, contribul a dare un certo benessere<br />
economico aile popo<strong>la</strong>zioni <strong>de</strong>lle Cinque Terre.<br />
E' a partire da questa periodo che si and6 <strong>de</strong>lineando<br />
I'impianto urbano <strong>de</strong>i centri che assunsero ben presto<br />
caratteristiche <strong>de</strong>l tutto simili a quelle attuali. Come nel<strong>la</strong><br />
-