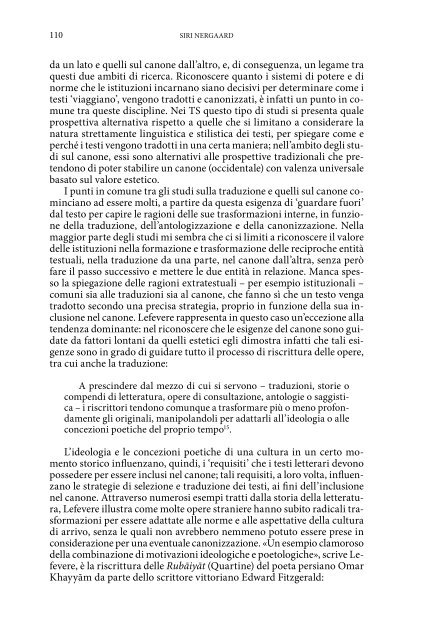biblioteca di studi di filologia moderna – 10 - Firenze University Press
biblioteca di studi di filologia moderna – 10 - Firenze University Press
biblioteca di studi di filologia moderna – 10 - Firenze University Press
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1<strong>10</strong><br />
siri nergaard<br />
da un lato e quelli sul canone dall’altro, e, <strong>di</strong> conseguenza, un legame tra<br />
questi due ambiti <strong>di</strong> ricerca. riconoscere quanto i sistemi <strong>di</strong> potere e <strong>di</strong><br />
norme che le istituzioni incarnano siano decisivi per determinare come i<br />
testi ‘viaggiano’, vengono tradotti e canonizzati, è infatti un punto in comune<br />
tra queste <strong>di</strong>scipline. nei ts questo tipo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> si presenta quale<br />
prospettiva alternativa rispetto a quelle che si limitano a considerare la<br />
natura strettamente linguistica e stilistica dei testi, per spiegare come e<br />
perché i testi vengono tradotti in una certa maniera; nell’ambito degli stu<strong>di</strong><br />
sul canone, essi sono alternativi alle prospettive tra<strong>di</strong>zionali che pretendono<br />
<strong>di</strong> poter stabilire un canone (occidentale) con valenza universale<br />
basato sul valore estetico.<br />
i punti in comune tra gli stu<strong>di</strong> sulla traduzione e quelli sul canone cominciano<br />
ad essere molti, a partire da questa esigenza <strong>di</strong> ‘guardare fuori’<br />
dal testo per capire le ragioni delle sue trasformazioni interne, in funzione<br />
della traduzione, dell’antologizzazione e della canonizzazione. nella<br />
maggior parte degli stu<strong>di</strong> mi sembra che ci si limiti a riconoscere il valore<br />
delle istituzioni nella formazione e trasformazione delle reciproche entità<br />
testuali, nella traduzione da una parte, nel canone dall’altra, senza però<br />
fare il passo successivo e mettere le due entità in relazione. manca spesso<br />
la spiegazione delle ragioni extratestuali <strong>–</strong> per esempio istituzionali <strong>–</strong><br />
comuni sia alle traduzioni sia al canone, che fanno sì che un testo venga<br />
tradotto secondo una precisa strategia, proprio in funzione della sua inclusione<br />
nel canone. lefevere rappresenta in questo caso un’eccezione alla<br />
tendenza dominante: nel riconoscere che le esigenze del canone sono guidate<br />
da fattori lontani da quelli estetici egli <strong>di</strong>mostra infatti che tali esigenze<br />
sono in grado <strong>di</strong> guidare tutto il processo <strong>di</strong> riscrittura delle opere,<br />
tra cui anche la traduzione:<br />
a prescindere dal mezzo <strong>di</strong> cui si servono <strong>–</strong> traduzioni, storie o<br />
compen<strong>di</strong> <strong>di</strong> letteratura, opere <strong>di</strong> consultazione, antologie o saggistica<br />
<strong>–</strong> i riscrittori tendono comunque a trasformare più o meno profondamente<br />
gli originali, manipolandoli per adattarli all’ideologia o alle<br />
concezioni poetiche del proprio tempo 15 .<br />
l’ideologia e le concezioni poetiche <strong>di</strong> una cultura in un certo momento<br />
storico influenzano, quin<strong>di</strong>, i ‘requisiti’ che i testi letterari devono<br />
possedere per essere inclusi nel canone; tali requisiti, a loro volta, influenzano<br />
le strategie <strong>di</strong> selezione e traduzione dei testi, ai fini dell’inclusione<br />
nel canone. attraverso numerosi esempi tratti dalla storia della letteratura,<br />
lefevere illustra come molte opere straniere hanno subito ra<strong>di</strong>cali trasformazioni<br />
per essere adattate alle norme e alle aspettative della cultura<br />
<strong>di</strong> arrivo, senza le quali non avrebbero nemmeno potuto essere prese in<br />
considerazione per una eventuale canonizzazione. «un esempio clamoroso<br />
della combinazione <strong>di</strong> motivazioni ideologiche e poetologiche», scrive lefevere,<br />
è la riscrittura delle Rubāiyāt (Quartine) del poeta persiano omar<br />
Khayyām da parte dello scrittore vittoriano edward fitzgerald: