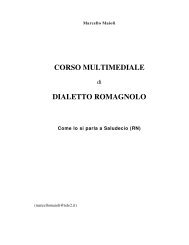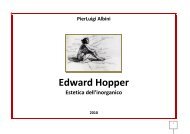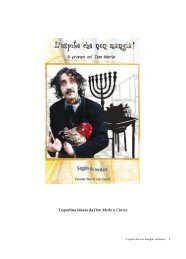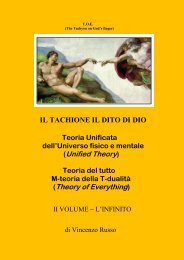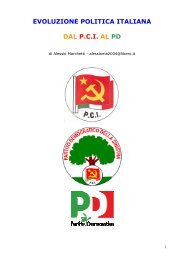la grammatica - Homolaicus
la grammatica - Homolaicus
la grammatica - Homolaicus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sorriso), soffre per <strong>la</strong> lontananza. La poesia dei «trovatori», cantori provenzali<br />
del cosiddetto «amor cortese», applicava al rapporto d'amore fra uomo<br />
e donna le regole del<strong>la</strong> società feudale: <strong>la</strong> donna era rappresentata come un<br />
signore feudale e l'uomo che l'amava come il suo vassallo.<br />
La letteratura in lingua d'OIL, costituita dalle canzoni di gesta<br />
eroiche, epiche e dai romanzi dei cicli carolingio e bretone (ad es. <strong>la</strong> Chanson<br />
de Ro<strong>la</strong>nd, che narra le imprese di Carlo Magno e dei suoi pa<strong>la</strong>dini<br />
contro i saraceni di<strong>la</strong>gati in Spagna; oppure Le gesta di re Artù e dei cavalieri<br />
del<strong>la</strong> tavo<strong>la</strong> rotonda, Lancillotto, Leggende di Tristano e Isotta ecc.),<br />
si mesco<strong>la</strong> con <strong>la</strong> lingua veneta, producendo una letteratura non molto diffusa.<br />
L'idea di scrivere poesie d'amore non più in <strong>la</strong>tino ma nel proprio<br />
volgare materno ebbe ben presto successo, e trovò poeti che l'applicarono<br />
prima nel<strong>la</strong> Francia del nord, poi in Germania e nel<strong>la</strong> peniso<strong>la</strong> iberica, e finalmente<br />
anche in Italia, per <strong>la</strong> precisione in Sicilia, al<strong>la</strong> corte di Federico II<br />
di Svevia, imperatore e re d'Italia dal 1220 al 1250.<br />
La scuo<strong>la</strong> siciliana<br />
La prima espressione poetica italiana, attuata da una omogenea<br />
cerchia di intellettuali e rimatori, che seppero fondere influssi arabi, elementi<br />
indigeni, tradizioni franco-normanne coi motivi del<strong>la</strong> poesia liricoprovenzale,<br />
si svolge al<strong>la</strong> corte palermitana di Federico II di Svevia, re di<br />
Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero. L'Italia meridionale, con<br />
questo felice esordio, entra a pieno titolo, seppure per breve tempo, nell'ecumene<br />
del<strong>la</strong> lirica cortese, accanto a Catalogna, Francia del Nord, Germania<br />
renano-danubiana, Portogallo, Galizia e ovviamente Provenza.<br />
Ciò che ha sempre stupito i critici è stata l'improvvisa apparizione<br />
di tale scuo<strong>la</strong> proprio nel<strong>la</strong> Magna Curia palermitana, visto e considerato<br />
che Federico II, una volta divenuto imperatore, non mostrò alcun partico<strong>la</strong>re<br />
interesse nei confronti dei poeti-musici tedeschi, autori e cantanti del<br />
Minnesang (canzoni d'amor cortese).<br />
È probabile che l'impulso dato da Federico al<strong>la</strong> «traduzione» e all'adattamento<br />
in un volgare italiano del modello trobadorico, fosse dettato<br />
sia da ragioni politiche: suo obiettivo era quello di realizzare uno Stato italiano<br />
forte e accentrato e <strong>la</strong> diffusione del volgare (il cui nemico principale<br />
era il <strong>la</strong>tino ecclesiastico) serviva certamente allo scopo; che da ragioni culturali:<br />
gli ambienti del<strong>la</strong> corte sveva dovevano essere già permeati di cultura<br />
cortese; intellettuali e funzionari non siciliani come Pier del<strong>la</strong> Vigna, Rinaldo<br />
d'Aquino, Jacopo da Lentini (cui è attribuita l'invenzione del sonetto)<br />
139