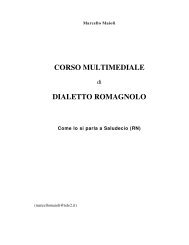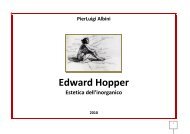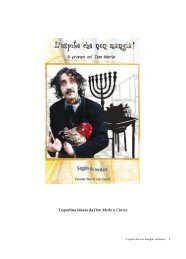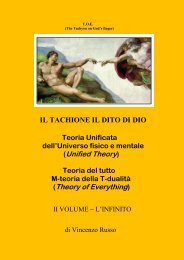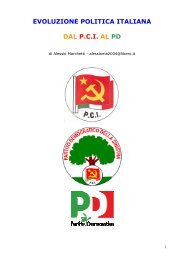la grammatica - Homolaicus
la grammatica - Homolaicus
la grammatica - Homolaicus
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
come sue componenti essenziali <strong>la</strong> profondità del pensiero, <strong>la</strong> magnificenza<br />
dei versi, l’elevatezza dei costrutti e l’eccellenza dei vocaboli.<br />
Lo stile tragico richiede grande perizia nel<strong>la</strong> sintassi, nel lessico,<br />
nel<strong>la</strong> scelta del<strong>la</strong> struttura dell'opera (divisione dei canti, disposizione delle<br />
parti, numero dei versi ecc.) e non può essere scritto in una metrica diversa<br />
dal pentenario o dal settenario o dall'endecasil<strong>la</strong>bo (quest'ultimo è generalmente<br />
ritenuto il migliore per durata ritmica, per capacità di pensiero, di costrutto<br />
e di vocaboli).<br />
La canzone tragica, usando l'endecasil<strong>la</strong>bo rimato, può trattare<br />
cose di altissimo livello, i grandi problemi dell'umanità. In tal senso si potrebbe<br />
dire che se il De Vulgari non fosse stato scritto dopo <strong>la</strong> Divina Commedia,<br />
si sarebbe posto come una sua grande premessa epistemologica.<br />
Nel<strong>la</strong> Commedia Dante diede il primo esempio di come fosse possibile<br />
usare il volgare (in questo caso il fiorentino) ottenendo effetti poetici<br />
di grande valore e affrontando astratti problemi filosofici, politici, culturali.<br />
Il Petrarca e il Boccaccio proseguirono sul<strong>la</strong> strada da lui indicata. Qui tuttavia<br />
va precisato che <strong>la</strong> lingua del<strong>la</strong> Commedia è il fiorentino par<strong>la</strong>to medio<br />
e non tanto il volgare illustre di Firenze: si può anzi dire che l'opera sia<br />
plurilinguistica, a causa dei suoi molti gallicismi, <strong>la</strong>tinismi, lombardismi,<br />
idiotismi vari e neologismi.<br />
In tal senso vi è contrasto con quanto detto nell'ultima parte del De<br />
Vulgari. Dante infatti ad un certo punto s'era chiesto quali potessero essere i<br />
vocaboli più giusti per scrivere una canzone. Ebbene le eccezioni poste<br />
sono così tante che al<strong>la</strong> fine vien da chiedersi chi mai potesse scrivere alle<br />
condizioni da lui poste (Dante riconosce come pertinenti allo stile tragico<br />
solo i vocaboli «pettinati» e «villosi»).<br />
Dopo <strong>la</strong> morte del Petrarca (1374) e del Boccaccio (1375), per un<br />
secolo circa, i letterati italiani più colti interrompono l'iniziativa intrapresa<br />
nei primi decenni del Duecento di scrivere in volgare e ritornano al <strong>la</strong>tino,<br />
non a quello medievale ma addirittura a quello c<strong>la</strong>ssico del<strong>la</strong> Roma antica.<br />
Di qui il disprezzo per quelle opere di Dante, Petrarca, Boccaccio, ecc.<br />
scritte in volgare (benché Petrarca e Boccaccio, ad es., per il loro tormentato<br />
distacco dal<strong>la</strong> sca<strong>la</strong> di valori umani e spirituali del Medioevo anticipassero<br />
in un certo senso i temi dell'Umanesimo).<br />
Commento al De vulgari eloquentia<br />
La cosa più curiosa di questo trattato è che Dante, per fare l'apologia<br />
del volgare illustre, sceglie l'antivolgare per eccellenza: il <strong>la</strong>tino. La motivazione<br />
è ch'egli intende rivolgersi ai «letterati». Dunque, il volgare par<strong>la</strong>to<br />
da operai, artigiani, contadini, commercianti… poteva trovare per Dante<br />
151