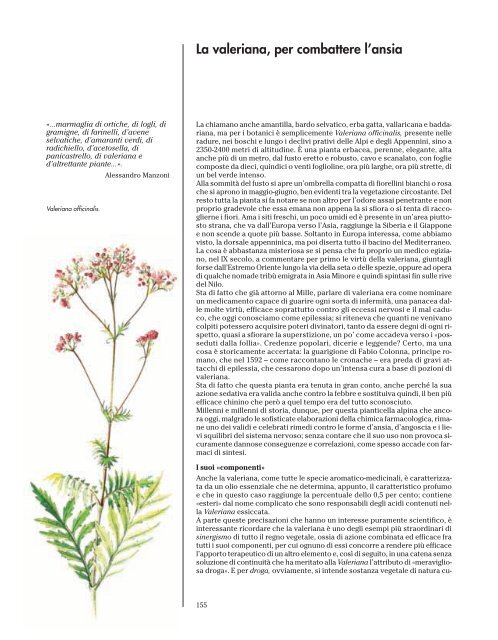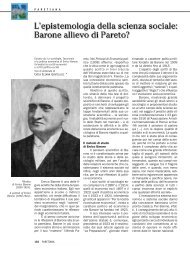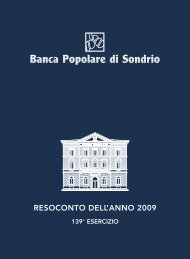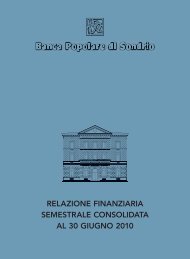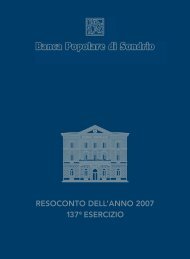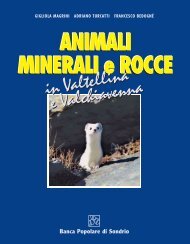L'elleboro, fiore della saggezza - Banca Popolare di Sondrio
L'elleboro, fiore della saggezza - Banca Popolare di Sondrio
L'elleboro, fiore della saggezza - Banca Popolare di Sondrio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
«...marmaglia <strong>di</strong> ortiche, <strong>di</strong> logli, <strong>di</strong><br />
gramigne, <strong>di</strong> farinelli, d’avene<br />
selvatiche, d’amaranti ver<strong>di</strong>, <strong>di</strong><br />
ra<strong>di</strong>chiello, d’acetosella, <strong>di</strong><br />
panicastrello, <strong>di</strong> valeriana e<br />
d’altrettante piante...».<br />
Alessandro Manzoni<br />
Valeriana officinalis.<br />
La valeriana, per combattere l’ansia<br />
La chiamano anche amantilla, bardo selvatico, erba gatta, vallaricana e baddariana,<br />
ma per i botanici è semplicemente Valeriana officinalis, presente nelle<br />
radure, nei boschi e lungo i declivi prativi delle Alpi e degli Appennini, sino a<br />
2350-2400 metri <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne. È una pianta erbacea, perenne, elegante, alta<br />
anche più <strong>di</strong> un metro, dal fusto eretto e robusto, cavo e scanalato, con foglie<br />
composte da <strong>di</strong>eci, quin<strong>di</strong>ci o venti foglioline, ora più larghe, ora più strette, <strong>di</strong><br />
un bel verde intenso.<br />
Alla sommità del fusto si apre un’ombrella compatta <strong>di</strong> <strong>fiore</strong>llini bianchi o rosa<br />
che si aprono in maggio-giugno, ben evidenti tra la vegetazione circostante. Del<br />
resto tutta la pianta si fa notare se non altro per l’odore assai penetrante e non<br />
proprio gradevole che essa emana non appena la si sfiora o si tenta <strong>di</strong> raccoglierne<br />
i fiori. Ama i siti freschi, un poco umi<strong>di</strong> ed è presente in un’area piuttosto<br />
strana, che va dall’Europa verso l’Asia, raggiunge la Siberia e il Giappone<br />
e non scende a quote più basse. Soltanto in Europa interessa, come abbiamo<br />
visto, la dorsale appenninica, ma poi <strong>di</strong>serta tutto il bacino del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
La cosa è abbastanza misteriosa se si pensa che fu proprio un me<strong>di</strong>co egiziano,<br />
nel IX secolo, a commentare per primo le virtù <strong>della</strong> valeriana, giuntagli<br />
forse dall’Estremo Oriente lungo la via <strong>della</strong> seta o delle spezie, oppure ad opera<br />
<strong>di</strong> qualche nomade tribù emigrata in Asia Minore e quin<strong>di</strong> spintasi fin sulle rive<br />
del Nilo.<br />
Sta <strong>di</strong> fatto che già attorno al Mille, parlare <strong>di</strong> valeriana era come nominare<br />
un me<strong>di</strong>camento capace <strong>di</strong> guarire ogni sorta <strong>di</strong> infermità, una panacea dalle<br />
molte virtù, efficace soprattutto contro gli eccessi nervosi e il mal caduco,<br />
che oggi conosciamo come epilessia; si riteneva che quanti ne venivano<br />
colpiti potessero acquisire poteri <strong>di</strong>vinatori, tanto da essere degni <strong>di</strong> ogni rispetto,<br />
quasi a sfiorare la superstizione, un po’ come accadeva verso i «posseduti<br />
dalla follia». Credenze popolari, <strong>di</strong>cerie e leggende? Certo, ma una<br />
cosa è storicamente accertata: la guarigione <strong>di</strong> Fabio Colonna, principe romano,<br />
che nel 1592 – come raccontano le cronache – era preda <strong>di</strong> gravi attacchi<br />
<strong>di</strong> epilessia, che cessarono dopo un’intensa cura a base <strong>di</strong> pozioni <strong>di</strong><br />
valeriana.<br />
Sta <strong>di</strong> fatto che questa pianta era tenuta in gran conto, anche perché la sua<br />
azione sedativa era valida anche contro la febbre e sostituiva quin<strong>di</strong>, il ben più<br />
efficace chinino che però a quel tempo era del tutto sconosciuto.<br />
Millenni e millenni <strong>di</strong> storia, dunque, per questa pianticella alpina che ancora<br />
oggi, malgrado le sofisticate elaborazioni <strong>della</strong> chimica farmacologica, rimane<br />
uno dei vali<strong>di</strong> e celebrati rime<strong>di</strong> contro le forme d’ansia, d’angoscia e i lievi<br />
squilibri del sistema nervoso; senza contare che il suo uso non provoca sicuramente<br />
dannose conseguenze e correlazioni, come spesso accade con farmaci<br />
<strong>di</strong> sintesi.<br />
I suoi «componenti»<br />
Anche la valeriana, come tutte le specie aromatico-me<strong>di</strong>cinali, è caratterizzata<br />
da un olio essenziale che ne determina, appunto, il caratteristico profumo<br />
e che in questo caso raggiunge la percentuale dello 0,5 per cento; contiene<br />
«esteri» dal nome complicato che sono responsabili degli aci<strong>di</strong> contenuti nella<br />
Valeriana essiccata.<br />
A parte queste precisazioni che hanno un interesse puramente scientifico, è<br />
interessante ricordare che la valeriana è uno degli esempi più straor<strong>di</strong>nari <strong>di</strong><br />
sinergismo <strong>di</strong> tutto il regno vegetale, ossia <strong>di</strong> azione combinata ed efficace fra<br />
tutti i suoi componenti, per cui ognuno <strong>di</strong> essi concorre a rendere più efficace<br />
l’apporto terapeutico <strong>di</strong> un altro elemento e, così <strong>di</strong> seguito, in una catena senza<br />
soluzione <strong>di</strong> continuità che ha meritato alla Valeriana l’attributo <strong>di</strong> «meravigliosa<br />
droga». E per droga, ovviamente, si intende sostanza vegetale <strong>di</strong> natura cu<br />
155