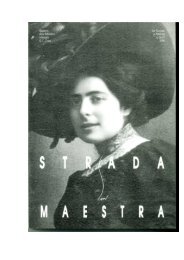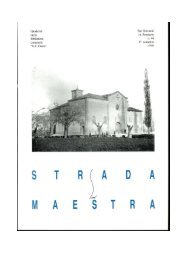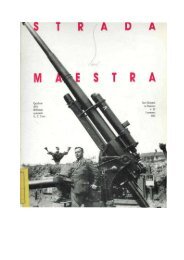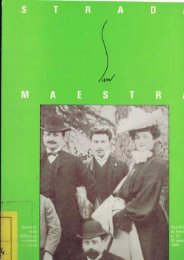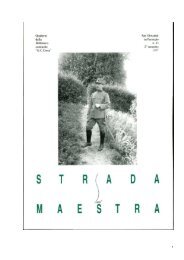MARIO GANDINI RAFFAELE PETTAZZONI NEGLI ANNI 1937 ...
MARIO GANDINI RAFFAELE PETTAZZONI NEGLI ANNI 1937 ...
MARIO GANDINI RAFFAELE PETTAZZONI NEGLI ANNI 1937 ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pettazzoni 6-11-2007 8:57 Pagina 156<br />
avrà ancora contatti con Pettazzoni; dopo l’8 settembre 1943 si farà propugnatore di una “sanguinosa<br />
riscossa” del fascismo; sarà fucilato dai partigiani nell’aprile 1945 ( 44 ).<br />
Nella seconda metà di marzo Pettazzoni riceve la visita del m.o Adolfo Gandino, visita<br />
preannunciata da una lettera di don Antonio Bottoni in data 16 marzo; il compositore è figlio<br />
del latinista Gian Battista, del quale nei primi anni del secolo il nostro storico delle religioni<br />
ha seguito le lezioni nell’Università di Bologna ( 45 ).<br />
Con lettera del 20 aprile Hendrik Wagenvoort restituisce a Pettazzoni le bozze del suo<br />
Orcus per il primo fascicolo 1938 degli SMSR; manda anche due estratti rammaricandosi di<br />
non poter aggiungere copia della sua dissertazione Vergils vierte Ekloge und das sidus<br />
Julium; scrive infine: “Anch’io mi ricordo con gioia del nostro incontro a Roma”. Non sappiamo<br />
se l’incontro è avvenuto alla fine del <strong>1937</strong> o nei primi mesi del 1938.<br />
Dal “Lei” al “Voi” (primi mesi del 1938)<br />
“Autarchia” (= autosufficienza) è una voce dotta introdotta nella lingua italiana<br />
nell’Ottocento, ma diventata di uso comune nella seconda metà degli anni Trenta del<br />
Novecento, quando, a seguito delle sanzioni economiche inflitte all’Italia dalla Società delle<br />
Nazioni, il regime fascista deve affrontare il problema dell’autarchia economica (esso viene<br />
impostato nei suoi termini generali da Mussolini con il discorso del 23 marzo 1936 alla<br />
seconda assemblea nazionale delle corporazioni); nella seconda metà degli anni Trenta vengono<br />
intensificate le campagne anche per l’autarchia culturale a cominciare dall’autarchia<br />
linguistica: per furore xenofobo si debbono applicare le “controsanzioni linguistiche” eliminando<br />
dal nostro vocabolario le parole straniere; E. Silvestri Viola, La grafia dei nomi stranieri,<br />
Il Resto del Carlino, 12 maggio 1938, propone addirittura che l’Accademia d’Italia si<br />
impegni per la revisione dei nomi propri di persona e geografici stranieri, per l’adozione di<br />
una grafia italiana al posto delle grafie inglese, francese, tedesca ecc. (qualcuno suggerisce<br />
“Ciamberlino” per Chamberlain, “Buonaria” per Buenos Aires, “Vosintone” per<br />
Washington…).<br />
Nei primi mesi del 1938 ha inizio la campagna per l’abolizione del Lei, considerato un<br />
uso straniero introdotto in Italia durante il predominio spagnolo; si deve tornare all’“italianissimo<br />
Voi”: Bruno Cicognani, Abolizione del ‘lei’, Corriere della sera, 15 gennaio 1938,<br />
invita a tornare all’uso di Roma, al ‘tu’ espressione dell’universale romano e cristiano, e al<br />
‘voi’ segno di rispetto e riconoscimento di gerarchia; segue il segretario del PNF, Achille<br />
Starace, zelante persecutore delle manifestazioni di borghesismo nella vita sociale italiana:<br />
nel Foglio di disposizioni n. 983 (14 febbraio 1938) egli impartisce apposita direttiva agli<br />
iscritti alla G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) e poi la estende a tutti gli iscritti al PNF;<br />
intervengono successivamente i vari ministeri, per esempio quello dell’educazione nazionale<br />
con circolari del 23 febbraio e dell’8 marzo 1938:<br />
In relazione alle norme impartite da S.E. il Segretario del Partito, dispongo che nella corrispondenza ufficiale<br />
ed ufficiosa il “Lei” venga sostituito dal “Voi”.<br />
Analogamente dovrà provvedersi nei rapporti tra funzionari, tra insegnanti e tra docenti e discepoli, nei quali<br />
sino ad oggi era usato il “Lei”.<br />
La disposizione viene ribadita più volte con circolari successive, nelle quali, tra l’altro, si<br />
lamenta che troppo frequentemente si continua a far uso del Lei dimostrando “scarso senso<br />
di disciplina e mancanza di carattere”; l’abolizione del Lei incontra resistenze (Benedetto<br />
156