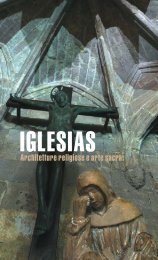la civiltà nuragica - Sardegna Cultura
la civiltà nuragica - Sardegna Cultura
la civiltà nuragica - Sardegna Cultura
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Caombus, vi sono nicchie alle pareti e, a sinistra<br />
dell’ingresso, si osserva un gruppo di tre<br />
elementi rituali: <strong>la</strong> vaschetta rettango<strong>la</strong>re, <strong>la</strong><br />
bacinel<strong>la</strong> e il betilo (qui una semplice colonna<br />
troncoconica, del tutto liscia). Il dibattito<br />
dei principi era preceduto o si concludeva<br />
con una sacra cerimonia, forse quel<strong>la</strong> solenne<br />
del giuramento dei patti, a base di sacrifizi<br />
e di offerte. I primi sono attestati da cumuli<br />
di ceneri e carboni intorno al betilo. Le<br />
seconde consistevano in statuine di bronzo<br />
d’animali (toro, vacca, cinghiale, capra)<br />
sostitutivo magico di sacrifizi reali , in oggetti<br />
e armi pure di bronzo (aghi crinali, o punteruoli,<br />
pugnaletti, ghiere di aste di <strong>la</strong>ncia), in<br />
vasetti del<strong>la</strong> stessa materia, in genere di<br />
carattere votivo per <strong>la</strong> piccolezza delle proporzioni.<br />
Furono ritrovati altresì vasi di terracotta,<br />
di varia forma (boccali, piatti ecc.),<br />
usati per libagioni, riti lustrali e per accogliere<br />
offerte in natura. Un torciere di bronzo,<br />
d’importazione cipriota (VIII-VII secolo<br />
aC.), fa supporre che le sedute si svolgessero<br />
anche di notte oppure che il servizio religioso<br />
avesse come liturgia quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> fiamma<br />
ardente, simbolo di luce e di splendore,<br />
segno del<strong>la</strong> chiarezza e del<strong>la</strong> perennità del<br />
«foedus ».Di impiego collettivo e cerimoniale<br />
potrebbero considerarsi pure due ampi<br />
recinti circo<strong>la</strong>ri, ricordanti nelle proporzioni<br />
quello di S. Vittoria, annessi al vil<strong>la</strong>ggio di<br />
capanne di Monte Siseri basso, nel<strong>la</strong> Nurra di<br />
Alghero. Distanti 25 e 75 metri rispettivamente<br />
dal grosso nuraghe trilobato omonimo,<br />
i recinti, limitati da un muro di blocchi<br />
subquadrati di calcare spesso m. 1, chiudono<br />
ciascuno uno spazio di m. Il e 10 di diametro.<br />
Al centro del vano, sul pavimento hen <strong>la</strong>stricato,<br />
risalta il foco<strong>la</strong>re rotondo di m. 3,60 e<br />
3,40. Ai recinti, che presentano l’ingresso a<br />
Nord e Sud, si annettono due piccoli ambienti<br />
più volte restaurati come i vani maggiori,<br />
destinati forse a ripostigli o depositi cii partico<strong>la</strong>ri<br />
oggetti e suppellettili.<br />
Atti di religione, di natura privata, avevano<br />
luogo nell’intimità del<strong>la</strong> famiglia, a<br />
livello di vil<strong>la</strong>ggio e di c<strong>la</strong>ns, e appagavano le<br />
esigenze del<strong>la</strong> realtà di vita quotidiana.<br />
Parecchie case d’abitazione del Nuragico<br />
Il (metà VII- fine VI), nel vil<strong>la</strong>ggio di<br />
Barflmini, mostrano un singo<strong>la</strong>re e quasi<br />
«canonico» ambiente, nel<strong>la</strong> parte più ciposta,<br />
che non si spiega con una funzione pratica. Il<br />
partico<strong>la</strong>re si ripete in dimore dell’aggregato<br />
abitativo di Santa Vittoria di Serri, fuori del<br />
santuario vero e proprio, e di Sa Mandra de<br />
sa giua ad Ossi, nel nord del<strong>la</strong> <strong>Sardegna</strong>. Si<br />
tratta, come ho già accennato, di piccoli vani<br />
rotondi, posti per lo più dietro quello maggiore<br />
del<strong>la</strong> cucina col forno-foco<strong>la</strong>re, del diametro<br />
da m. 2,66 e 1,36. Sono di giro perfetto<br />
e rifiniti nelle strutture murarie composte,<br />
nelle pareti, a li<strong>la</strong>retti rego<strong>la</strong>ri di quadrelli in<br />
pietra, che si restringevano ad anelli aggettanti<br />
sino al<strong>la</strong> chiusura del<strong>la</strong> volta. Al<strong>la</strong> base<br />
dei vani, col pavimento di <strong>la</strong>stre ben curato<br />
nelinclinato per facilitare il deflusso dell’acqua<br />
di <strong>la</strong>vaggio attraverso fori praticati nel<br />
muro, corre un sedile di pietre conca scorniciate.<br />
Al centro del pavimento è collocato un<br />
bacile emisferico con piede, levigato a scalpello,<br />
variante nel diametro interno da cm.<br />
81 a 67 e in profondità da 25 a 23. Sul sedile<br />
circostante potevano stare da 7 a 5 persone,<br />
il corrispettivo numerico d’un nucleo<br />
familiare. La finitura e distinzione del vano<br />
rispetto agli altri ambienti dell’abitazione<br />
irrego<strong>la</strong>ri nel<strong>la</strong> pianta e dimessi nel<strong>la</strong> struttura,<br />
<strong>la</strong> presenza del<strong>la</strong> conca al centro del sedile<br />
(in qualche caso anche d’una vaschetta<br />
rettango<strong>la</strong>re per l’acqua), fanno pensare a un<br />
rito domestico, di carattere lustrale. Si immagina<br />
una sorta di battesimo per immersione<br />
del neonato, officiato dal patriarca al<strong>la</strong><br />
presenza dei membri del<strong>la</strong> famiglia. Questo<br />
intimo sacrario, nell’occasione del<strong>la</strong> cerimonia<br />
purificatrice, poteva venire riscaldato<br />
accendendo l’attiguo forno, per evitare<br />
che il bambino soffrisse del bagno da<br />
supporre fatto perciò nell’acqua tiepida.<br />
Altre ipotesi sono state affacciate o si potreb-<br />
Fig. 206. Cagliari, Museo Archeologico Nazionale: eroe o<br />
demone con due scudi e quattro braccia, da Abini, TEti<br />
(NU). Alt. cm 15.<br />
178



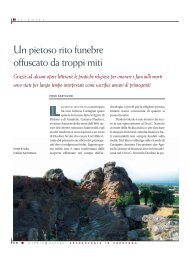


![[PDF] untitled - Sardegna Cultura](https://img.yumpu.com/51061213/1/177x260/pdf-untitled-sardegna-cultura.jpg?quality=85)

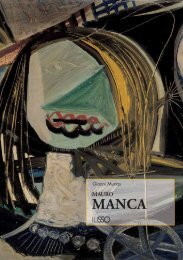


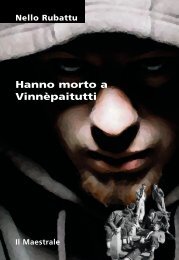
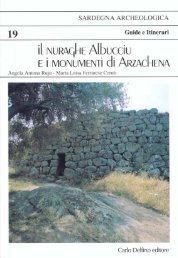
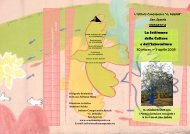
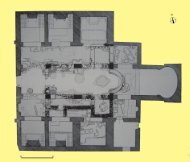
![[PDF] Cagliari, citt romana di Karales - Sardegna Cultura](https://img.yumpu.com/50065895/1/184x260/pdf-cagliari-citt-romana-di-karales-sardegna-cultura.jpg?quality=85)