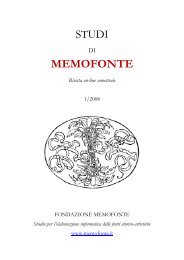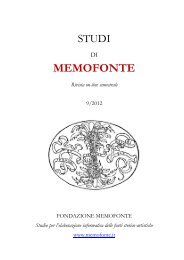- Page 1 and 2:
[II. 1] VITA DI LIONARDO DA VINCI P
- Page 3 and 4:
non sentito da Lionardo per il gran
- Page 5 and 6:
poiché delle cose sue ne son molte
- Page 7 and 8:
Soderini soleva pigliare, il cassie
- Page 9 and 10:
quale tiene la testa mozza di Golia
- Page 11 and 12:
antiche o de le buone moderne, nece
- Page 13 and 14:
VITA DI PIERO DI COSIMO Pittor Fior
- Page 15 and 16:
erano esuli, e come dire morti che
- Page 17 and 18:
tratto. E faceva discorsi e tirava
- Page 19 and 20:
ella invenzione, che si credette ch
- Page 21 and 22:
quelle in ciò che e’ [II. 33] po
- Page 23 and 24: ignude. Per il che riscaldati i pop
- Page 25 and 26: Bartolomeo: per il che levatolo di
- Page 27 and 28: [II. 42] Mariotto Albertinelli, fam
- Page 29 and 30: stette a Roma, volse mostrare ch’
- Page 31 and 32: Uberti e San Benedetto abate, e dal
- Page 33 and 34: perché chi aiuta e favorisce nell
- Page 35 and 36: modelli al Francione et ad altri, e
- Page 37 and 38: il Papa e col duca Valentino suo fi
- Page 39 and 40: graziosissimo Raffaello da Urbino.
- Page 41 and 42: punto e in tutte le cose, che i suo
- Page 43 and 44: quale non aveva il frate atteso ins
- Page 45 and 46: Petrarca e lo amoroso Boccaccio, ch
- Page 47 and 48: quali ve n’ha una che a piè dell
- Page 49 and 50: questi è vestito d’un panno ross
- Page 51 and 52: si fa alla loggia di palazzo, e con
- Page 53 and 54: Mercurio il caduceo, di Pan la samp
- Page 55 and 56: tempo, ma a farsi un ottimo univers
- Page 57 and 58: Beata veramente ti potevi chiamare,
- Page 59 and 60: oscuri di mano in mano in quelle ch
- Page 61 and 62: paragonarlo. Sono infinite opere di
- Page 63 and 64: quella che fece nella medesima citt
- Page 65 and 66: come si è detto, et a canto all’
- Page 67 and 68: itratti similissimi al naturale, an
- Page 69 and 70: morte Antonio, poi che fu fatto sep
- Page 71 and 72: Pittori [II. 111] Dovendo io scrive
- Page 73: Madalena in piedi e vestita con pic
- Page 77 and 78: sepellire, quattro Angeli in aria e
- Page 79 and 80: feciono fare a Benedetto il disegno
- Page 81 and 82: Michelagnolo, conosciuta la virtù
- Page 83 and 84: giovane, in un pilastro d’Orsanmi
- Page 85 and 86: Romano, del quale si è in altro lu
- Page 87 and 88: preso un carbone, in un tratto ebbe
- Page 89 and 90: fatte opere meritò tanto più lode
- Page 91 and 92: ellissimo modello. Ma perché era c
- Page 93 and 94: nazione spagnuola fatta fare il car
- Page 95 and 96: onore et utile, e lo farebbe conosc
- Page 97 and 98: ellissima pittura. Prese non molto
- Page 99 and 100: di settembre, fu giudicato questo a
- Page 101 and 102: dell’orto de’ Servi in due cant
- Page 103 and 104: Federigo Secondo duca di Mantoa, ne
- Page 105 and 106: grandezza, maestà e grazia infinit
- Page 107 and 108: Fu la morte d’Andrea di grandissi
- Page 109 and 110: asta che Temi e Cassandra e Manto e
- Page 111 and 112: E DI DOSSO E BATTISTA Pittori Ferra
- Page 113 and 114: monete, e di pittura Giorgio Vasari
- Page 115 and 116: le cose altrui, o dal troppo volere
- Page 117 and 118: viver in pace, partirsi di Udine, e
- Page 119 and 120: Avendo il prencipe Doria in Genova
- Page 121 and 122: ginocchioni, S. Caterina e S. Iacop
- Page 123 and 124: pietre grosse ciascuna quanto un uo
- Page 125 and 126:
che, sì come gl’animi loro erano
- Page 127 and 128:
pittura ma paiono di metallo; e sop
- Page 129 and 130:
Disegnò il Rosso nella sua giovane
- Page 131 and 132:
portare addosso pesi e sgombrare qu
- Page 133 and 134:
forma di padiglione; la quale stanz
- Page 135 and 136:
nondimeno per essere quella di Bart
- Page 137 and 138:
uona maniera. Ne’ Servi di Bologn
- Page 139 and 140:
concorrenza di Andrea del Sarto e d
- Page 141 and 142:
di quella opera. E così in quella
- Page 143 and 144:
Pittore [II. 228] Quando il mondo h
- Page 145 and 146:
nell’altro; e nella testa d’uno
- Page 147 and 148:
In questo tempo il detto Antonio da
- Page 149 and 150:
Nella chiesa de’ frati Carmelitan
- Page 151 and 152:
splendore di Cristo con bella manie
- Page 153 and 154:
enefizio degl’artefici, anzi del
- Page 155 and 156:
nell’architettura, gli diedero or
- Page 157 and 158:
miniate. Fece ancora per la capella
- Page 159 and 160:
le bande di storie del Testamento V
- Page 161 and 162:
cioè Anselmo Canneri e Paulo Veron
- Page 163 and 164:
ultimamente in una carta bellissima
- Page 165 and 166:
Avendo il Gran Turco per un suo uom
- Page 167 and 168:
tutto svelto e volge le reni in par
- Page 169 and 170:
vescovo, e l’uno e l’altro frat
- Page 171 and 172:
presentasse occasione di far cose s
- Page 173 and 174:
fusse; et il padre don Girolamo Vol
- Page 175 and 176:
vedere i modi del fare e l’opere
- Page 177 and 178:
uon disegno, o che in pitture, scul
- Page 179 and 180:
intagliatori di Santa Maria del Fio
- Page 181 and 182:
Accrebbe poi in maggior eccellenza
- Page 183 and 184:
Francesco, et una impronta ne ha og
- Page 185 and 186:
in su due figure, cioè Sua Eccelle
- Page 187 and 188:
di San Giovanni, e nell’altra qua
- Page 189 and 190:
di Ioseffo, i quattro Evangelisti,
- Page 191 and 192:
secchi e d’ossame di morti, et ap
- Page 193 and 194:
sopra. E di questa sorte fece Franc
- Page 195 and 196:
appresso il Faetonte, il Tizio, il
- Page 197 and 198:
fonte; e si trae dietro legati come
- Page 199 and 200:
messer Marchionne sodisfattissimo,
- Page 201 and 202:
ellezza, perché dove si andava pri
- Page 203 and 204:
d’Austria, che dinanzi era Albert
- Page 205 and 206:
che il Papa teneva gran conto d’u
- Page 207 and 208:
Gostantino imperatore, et aveva, qu
- Page 209 and 210:
cose aiutato a lavorare. Onde non m
- Page 211 and 212:
mira, tutto tinto nel volto di colo
- Page 213 and 214:
Dopo queste opere dipinse Giulio a
- Page 215 and 216:
Peccati mortali ritratti dal detto
- Page 217 and 218:
Raffaello che a Michelagnolo. Ma no
- Page 219 and 220:
Aretino, e lo fece sì fatto che, o
- Page 221 and 222:
come quelli che, essendo universale
- Page 223 and 224:
l’aspetto et i modi suoi, attesoc
- Page 225 and 226:
ellissima, avendone un’altra a su
- Page 227 and 228:
grandissimo onor suo farsi conoscer
- Page 229 and 230:
fu cara tanto quanto s’e’ gli a
- Page 231 and 232:
Trevisi, il quale dipigneva una fac
- Page 233 and 234:
Roma si condusse; dove fattosi cono
- Page 235 and 236:
nell’ultimo della sua vita; il qu
- Page 237 and 238:
Sepolcro, che era cosa eccellente.
- Page 239 and 240:
medesima città, nella qual è di s
- Page 241 and 242:
da esso imperador domate e vinte. N
- Page 243 and 244:
tempera: essa Vergine presentata al
- Page 245 and 246:
era giovinetto, dal quale imparò G
- Page 247 and 248:
con una tempia fintamente insanguin
- Page 249 and 250:
Prassedia, fu posto nel mezzo di qu
- Page 251 and 252:
figure piccole, che sono ragionevol
- Page 253 and 254:
[II. 394] Raffaello legnaiuolo, sop
- Page 255 and 256:
ordine alla guerra et all’assedio
- Page 257 and 258:
QUIETEM RESTITUIT. L’altre furono
- Page 259 and 260:
accia e mezzo, e tanto pari e con b
- Page 261 and 262:
detti monti Asinaia e Falterona ven
- Page 263 and 264:
più vivo e più disideroso di glor
- Page 265 and 266:
che con favore, non pensavano al fa
- Page 267 and 268:
modo di condurla, se ne tornò a Fi
- Page 269 and 270:
un’agevolezza maravigliosa, la qu
- Page 271 and 272:
nel medesimo tempo fece un quadro p
- Page 273 and 274:
andato a Pinzirimonte, villa comper
- Page 275 and 276:
l’opera al vanto, scemò assai Ba
- Page 277 and 278:
che uccidesse Cacco per metterlo in
- Page 279 and 280:
croce, la quale fu opera rara, e la
- Page 281 and 282:
credere, ancorché indegno sia il b
- Page 283 and 284:
imperfetta e le statue in mano di d
- Page 285 and 286:
spesa invano, fatta così inconside
- Page 287 and 288:
icchezza di questo basamento, ne’
- Page 289 and 290:
parte delle statue che vi andavano.
- Page 291 and 292:
Giorgio lo mostrasse a Roma a Miche
- Page 293 and 294:
essendo giovinetto, il principio de
- Page 295 and 296:
l’ombre più crude, si venne a le
- Page 297 and 298:
male, più tosto stracciare, come f
- Page 299 and 300:
non le mura principali et il tetto,
- Page 301 and 302:
Santa Fiore de’ Monaci Neri, cio
- Page 303 and 304:
quale, avendo abbracciato Amore, lo
- Page 305 and 306:
Condusse dunque Cristofano in un ov
- Page 307 and 308:
tredici anni in Firenze e messo ne
- Page 309 and 310:
che fussero superati, dato del tutt
- Page 311 and 312:
disiderio di gloria e d’onore che
- Page 313 and 314:
Giovanmaria Benintendi, avendo quas
- Page 315 and 316:
entrano nelle capelle, in una figur
- Page 317 and 318:
perciò che se n’andava in ghirib
- Page 319 and 320:
Iacone, Pierfrancesco di Iacopo et
- Page 321 and 322:
e finiti, il tutto nondimeno è fuo
- Page 323 and 324:
di fogliami tutto traforato e pien
- Page 325 and 326:
Gualtieri, padre del vescovo di Vit
- Page 327 and 328:
Duca per far scene et apparati di c
- Page 329 and 330:
enissimo, come ne fa fede molte tav
- Page 331 and 332:
e del palazzo e residenza di detto
- Page 333 and 334:
compagno ad Antonio San Gallo, acci
- Page 335 and 336:
fussero chiamati con onoratissime c
- Page 337 and 338:
condurre a fine il campanile della
- Page 339 and 340:
gli tenevano nel palazzo del princi
- Page 341 and 342:
musico e de’ primi dell’accadem
- Page 343 and 344:
Giovannantonio da Verzelli, come eb
- Page 345 and 346:
imunerato di così bella pittura. O
- Page 347 and 348:
la barba, essendo già vecchio, e c
- Page 349 and 350:
Roma il fratello: con una parte de
- Page 351 and 352:
capricciose, né strade o lontani c
- Page 353 and 354:
trovare Perino, alla bella prima gl
- Page 355 and 356:
igata in sul canto de’ Medici, il
- Page 357 and 358:
tanto adoperò col sottomettersi e
- Page 359 and 360:
Modana per vedere l’altre opere d
- Page 361 and 362:
vagamente ridotte in diverse forme
- Page 363 and 364:
Ieronimo Mazzuoli, cugino di France
- Page 365 and 366:
maggiore che è in mezzo di detta c
- Page 367 and 368:
tavola in San Piero in Oliveto, che
- Page 369 and 370:
come s’è detto nella Vita di Bra
- Page 371 and 372:
si fugge. Sono di mano di Davitte n
- Page 373 and 374:
Campaccio, a una loro chiesetta, fe
- Page 375 and 376:
la caccia e l’uccellare dietro al
- Page 377 and 378:
vita, perciò che papa Paulo IV, pe
- Page 379 and 380:
a farsi di quest’opera se non qua
- Page 381 and 382:
vuole esser pittore, cominci ad ado
- Page 383 and 384:
questo si può fare giudizio che co
- Page 385 and 386:
alla sepoltura di Cristofano Fucche
- Page 387 and 388:
scorti, d’armadure, casamenti, ri
- Page 389 and 390:
fece alcune pitture ragionevoli, an
- Page 391 and 392:
cercarlo, quando vide colui averlo
- Page 393 and 394:
come aderenti, Andrea del Sarto dip
- Page 395 and 396:
farebbono lunga la nostra storia. F
- Page 397 and 398:
del vivere e regola loro, e tenendo
- Page 399 and 400:
d’Arezzo, intendendo che Girolamo
- Page 401 and 402:
principale della cappella fece un a
- Page 403 and 404:
zampe schizza acqua in alto; e nel
- Page 405 and 406:
ell’orazione in lode di fra’ Gi
- Page 407 and 408:
Giovanni Polastra eccellente poeta
- Page 409 and 410:
Roma cosa alcuna notabile la quale
- Page 411 and 412:
fastidio il vivere di Vinezia a Fra
- Page 413 and 414:
lasciato pigliar piede et accommoda
- Page 415 and 416:
dell’altare, nella quale è un De
- Page 417 and 418:
altro. Ma per tornare alla tavola,
- Page 419 and 420:
Francesco di Girolamo dal Prato, in
- Page 421 and 422:
logge, e particolarmente vi fece mo
- Page 423 and 424:
studiando in un medesimo tempo i ca
- Page 425 and 426:
vergognose troppo disonestamente, f
- Page 427 and 428:
sapere d’aiuto più che tanto, tu
- Page 429 and 430:
pitture in uno studiolo a Pesaro, e
- Page 431 and 432:
Taddeo se ne tornò a Roma, e Feder
- Page 433 and 434:
che più attendeva al guadagno che
- Page 435 and 436:
parenti, arrivò finalmente in Roma
- Page 437 and 438:
quattro appartamenti, senza la part
- Page 439 and 440:
Parigi, Viseo, Morone, Badia, Trent
- Page 441 and 442:
Facciasi sorgere da una marina tran
- Page 443 and 444:
mezzo in giù sia sasso nero di col
- Page 445 and 446:
molte figure che si stanno nelle se
- Page 447 and 448:
Francesco ricevé le stìmate, dioc
- Page 449 and 450:
come era suo solito, gli disse: “
- Page 451 and 452:
Rovano franzese, disiderio di lasci
- Page 453 and 454:
Venne volontà ad Agnolo Doni, citt
- Page 455 and 456:
un Prigion sotto, qual’ sono oggi
- Page 457 and 458:
palazzo; et in questo modo pareva a
- Page 459 and 460:
d’aria e terribilità di cose var
- Page 461 and 462:
ancora è la storia delle Serpi di
- Page 463 and 464:
de’ Medici un modello delle fines
- Page 465 and 466:
Grato mi è il sonno, e più l’es
- Page 467 and 468:
Udine, divino, il quale per lo stuc
- Page 469 and 470:
che è stato superiore a tutti i su
- Page 471 and 472:
corso ne meni via chi cerca ritener
- Page 473 and 474:
ghiacere, antichi di marmo, sopra a
- Page 475 and 476:
Aveva il Vasari quell’anno finito
- Page 477 and 478:
casa; e gli ebbe tanto rispetto e r
- Page 479 and 480:
Vasari, come per più altre lettere
- Page 481 and 482:
Onde l’affettuosa fantasia, Che l
- Page 483 and 484:
l’imbasamento 18 grandissimi pila
- Page 485 and 486:
vede, basta aver così brevemente f
- Page 487 and 488:
onde tutti d’uno stesso volere ne
- Page 489 and 490:
È stata conosciuta la virtù di Mi
- Page 491 and 492:
vecchio, fino che faceva il Giudizi
- Page 493 and 494:
statue antiche”. Fu detto a Miche
- Page 495 and 496:
de’ Medici e dove è la maggior p
- Page 497 and 498:
L’essere stato veduto intorno a S
- Page 499 and 500:
dalle proprie mani e da tutta l’a
- Page 501 and 502:
Mausoleo d’Augusto in Roma; e for
- Page 503 and 504:
Vivens orbe peto laudibus aethera.
- Page 505 and 506:
statue, la Pittura, la Scultura e l
- Page 507 and 508:
partimenti di cornici, che hanno la
- Page 509 and 510:
si vede che ha imitato l’opere de
- Page 511 and 512:
Tiziano dunque, veduto il fare e la
- Page 513 and 514:
itratto dal vivo e senza artificio
- Page 515 and 516:
Aretino; ma non fu già questi sì
- Page 517 and 518:
è bellissimo. In Ancona, all’alt
- Page 519 and 520:
l’aver fama di bene e volentieri
- Page 521 and 522:
DESCRIZIONE DELL’OPERE DI IACOPO
- Page 523 and 524:
ancora un putto di stoppa et un cec
- Page 525 and 526:
facesse una grandissima chiesa e si
- Page 527 and 528:
et adornato quella Republica, ma ha
- Page 529 and 530:
due figure pure di marmo, molto gra
- Page 531 and 532:
i razzi solari attorno alla testa,
- Page 533 and 534:
una Benedizione della fonte del bat
- Page 535 and 536:
San Lorenzo per utilità publica; l
- Page 537 and 538:
per opera, si crede, di fra’ Gugl
- Page 539 and 540:
attesimo fu Giorgio Iulio. Attese d
- Page 541 and 542:
La quale opera fu condotta con tant
- Page 543 and 544:
Santo Alfonso vescovo: nei quali qu
- Page 545 and 546:
et altri, conobbi nel 1532 in Roma
- Page 547 and 548:
eccellentissimi scritti degl’arch
- Page 549 and 550:
che piovono sopra il popolo, con mo
- Page 551 and 552:
anni far manco bene che non hanno f
- Page 553 and 554:
considerazioni e giudizio, onde le
- Page 555 and 556:
Accademia alcun’altri giovani pit
- Page 557 and 558:
Tolledo al suo giardino di Fiorenza
- Page 559 and 560:
arissima. Nelli dua quadri di mezzo
- Page 561 and 562:
DESCRIZIONE DELLA PORTA AL PRATO [I
- Page 563 and 564:
alcuni poeti che latinamente avevan
- Page 565 and 566:
scherzando, altri di loro saettavan
- Page 567 and 568:
che rende tranquillissimo il mare,
- Page 569 and 570:
QUAMVIS, FLORA, TUIS, CELEBERRIMA,
- Page 571 and 572:
SED IAM NOX RUIT ET SIDERA CONCIDUN
- Page 573 and 574:
HEU DURIS SOLVIS, QUAE CLARUM CERNE
- Page 575 and 576:
trapassando alla predetta torre de
- Page 577 and 578:
E perché ciascuno degl’otto desc
- Page 579 and 580:
ardente fulmine. Ma sopra l’arco
- Page 581 and 582:
IMPERIIS AUXERE SUIS CERTAQUE SALUT
- Page 583 and 584:
antico tempio di Iano simigliante.
- Page 585 and 586:
IOANNES GUALBERTUS EQUES NOBILISS.
- Page 587 and 588:
Con l’istoria, similmente nella b
- Page 589 and 590:
cristiane azzioni esser bisognose e
- Page 591 and 592:
a seder posta era, seguitando di di
- Page 593 and 594:
le buccine a’ piedi sonando gli s
- Page 595 and 596:
dell’eccellentissimo Prin[II. 931
- Page 597 and 598:
porgere con l’una mano a un armat
- Page 599 and 600:
La quale fornita, e ciascuna delle
- Page 601 and 602:
Ma derivando dagl’inganni l’off
- Page 603 and 604:
Dunque, e tu, Psiche, scaccia L’a
- Page 605 and 606:
cose, che da noi contro a natura s
- Page 607 and 608:
ella e lucida Alba, con la biondiss
- Page 609 and 610:
messovi dentro una buona quantità
- Page 611 and 612:
capricciosi e bizarri oltre a modo
- Page 613 and 614:
come nell’altro si disse) si vede
- Page 615 and 616:
l’Anno, col capo tutto di ghiacci
- Page 617 and 618:
pastori con pelli di lupi rusticame
- Page 619 and 620:
ma forte e fiera a meraviglia e di
- Page 621 and 622:
CARRO UNDICESIMO DI VULCANO [II. 96
- Page 623 and 624:
giovani e vaghi Zete e Calai, figli
- Page 625 and 626:
CARRO DICIASSETTESIMO DI CIBELE Ma
- Page 627 and 628:
e tutta argentata navicella, che su
- Page 629 and 630:
terza, che forma di vitello aveva,
- Page 631 and 632:
morto mio padre di peste; il quale
- Page 633 and 634:
vi ebbi poco meno che a perdere il
- Page 635 and 636:
asso, oltre agl’Apostoli che sono
- Page 637 and 638:
passando fra le foglie dell’alber
- Page 639 and 640:
goffez[z]a di sesti. Nel che mi fur
- Page 641 and 642:
si vede la Pace abruciar l’arme,
- Page 643 and 644:
Fortuna, viene talvolta l’Invidia
- Page 645 and 646:
quell’orrendo spettacolo; e nell
- Page 647 and 648:
e Proserpina. In una camera maggior
- Page 649 and 650:
messo in tirare innanzi, da che pri
- Page 651 and 652:
far di nuovo e ridurre a miglior fo


![[II. 1] VITA DI LIONARDO DA VINCI Pittore e Scultore Fiorentino ...](https://img.yumpu.com/5678977/74/500x640/ii-1-vita-di-lionardo-da-vinci-pittore-e-scultore-fiorentino-.jpg)