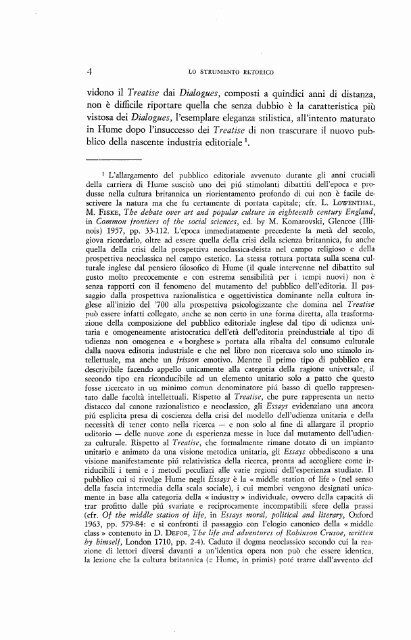Dialoghi sulla religione naturale - Studi umanistici Unimi - Università ...
Dialoghi sulla religione naturale - Studi umanistici Unimi - Università ...
Dialoghi sulla religione naturale - Studi umanistici Unimi - Università ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LO STRUMENTO RETORICO<br />
vidono il Treatise dai Dialogues, composti a quindici anni di distanza,<br />
non è difficile riportare quella che senza dubbio è la caratteristica più<br />
vistosa dei Dialogues, l'esemplare eleganza stilistica, all'intento maturato<br />
in Hume dopo l'insuccesso dei Treatise di non trascurare il nuovo pub<br />
blico della nascente industria editoriale x .<br />
1 L'allargamento del pubblico editoriale avvenuto durante gli anni cruciali<br />
della carriera di Hume suscitò uno dei più stimolanti dibattiti dell'epoca e pro<br />
dusse nella cultura britannica un riorientamento profondo di cui non è facile de<br />
scrivere la natura ma che fu certamente di portata capitale; cfr. L. LOWENTHAL,<br />
M. FISKE, The debate over art and -popular culture in eighteenth century England,<br />
in Common frontiers of thè social sciences, ed. by M. Komarovski, Glencoe (Illi<br />
nois) 1957, pp. 33-112. L'epoca immediatamente precedente la metà del secolo,<br />
giova ricordarlo, oltre ad essere quella della crisi della scienza britannica, fu anche<br />
quella della crisi della prospettiva neoclassica-deista nel campo religioso e della<br />
prospettiva neoclassica nel campo estetico. La stessa rottura portata <strong>sulla</strong> scena cul<br />
turale inglese dal pensiero filosofico di Hume (il quale intervenne nel dibattito sul<br />
gusto molto precocemente e con estrema sensibilità per i tempi nuovi) non è<br />
senza rapporti con il fenomeno del mutamento del pubblico dell'editoria. Il pas<br />
saggio dalla prospettiva razionalistica e oggettivistica dominante nella cultura in<br />
glese all'inizio del 700 alla prospettiva psicologizzante che domina nel Treatise<br />
può essere infatti collegato, anche se non certo in una forma diretta, alla trasforma<br />
zione della composizione del pubblico editoriale inglese dal tipo di udienza uni<br />
taria e omogeneamente aristocratica dell'età dell'editoria preindustriale al tipo di<br />
udienza non omogenea e « borghese » portata alla ribalta del consumo culturale<br />
dalla nuova editoria industriale e che nel libro non ricercava solo uno stimolo in<br />
tellettuale, ma anche un frisson emotivo. Mentre il primo tipo di pubblico era<br />
descrivibile facendo appello unicamente alla categoria della ragione universale, il<br />
secondo tipo era riconducibile ad un elemento unitario solo a patto che questo<br />
fosse licercato in un minimo comun denominatore più basso di quello rappresen<br />
tato dalle facoltà intellettuali. Rispetto al Treatise, che pure rappresenta un netto<br />
distacco dal canone razionalistico e neoclassico, gli Essays evidenziano una ancora<br />
più esplicita presa di coscienza della crisi del modello dell'udienza unitaria e della<br />
necessità di tener conto nella ricerca — e non solo al fine di allargare il proprio<br />
uditorio — delle nuove zone di esperienza messe in luce dal mutamento dell'udien<br />
za culturale. Rispetto al Treatise, che formalmente rimane dotato di un impianto<br />
unitario e animato da una visione metodica unitaria, gli Essays obbediscono a una<br />
visione manifestamente più relativistica della ricerca, pronta ad accogliere come ir<br />
riducibili i temi e i metodi peculiari alle varie regioni dell'esperienza studiate. Il<br />
pubblico cui si rivolge Hume negli Essays è la « middle station of life » (nel senso<br />
della fascia intermedia della scala sociale), i cui membri vengono designati unica<br />
mente in base alla categoria della « industry » individuale, ovvero della capacità di<br />
trar profitto dalle più svariate e reciprocamente incompatibili sfere della prassi<br />
(cfr. Of thè middle station of life, in Essays moral, politicai and literary, Oxford<br />
1963, pp. 579-84: e si confronti il passaggio con l'elogio canonico della « middle<br />
class » contenuto in D. DEFOE, The life and adventures of Robinson Crusoe, written<br />
by himself, London 1710, pp. 2-4). Caduto il dogma neoclassico secondo cui la rea<br />
zione di lettori diversi davanti a un'identica opera non può che essere identica,<br />
la lezione che la cultura britannica (e Hume, in primis) potè trarre dall'avvento del